Felicitazioni…
Non ci si può felicitare con qualcuno che abbia autorizzato l’abbattimento di un aereo civile, scambiandolo per un aereo spia che abbia sconfinato nello spazio aereo sovietico, uccidendo così, centinaia di persone innocenti.
Eppure s’entra nei Chiostri di San Pietro, a Reggio Emilia, sorvegliati dall’ombra dei soldati del cambio della guardia nella ex Repubblica Democratica Tedesca, sotto un grande richiamo all’urlo convulso di “Spara Jurij”. “Felicitazioni”; per un atto indegno, che rischiava di portare il mondo nel pieno di una guerra atomica.
Il racconto dell’esperienza dei CCCP, inizia da qui, da questa apparente professione di fede cieca, che in realtà è modulata da Giovanni Lindo Ferretti, quando invoca nella canzone, un’ultima volta Jurij (Andropov, ex Segretario Generale del PCUS), con un urlo strozzato dalla disperazione, per qualcosa che, meccanicamente e ignorando le ragioni dell’umanità, si muove comunque, e a qualsiasi costo, e che si trasforma nella consapevolezza di dover invece fermare questa disciplina dogmatica, considerata inevitabile.

E’ tutta qui, la perenne e continua contraddizione portata in scena dai CCCP lungo l’arco della loro vita artistica. Il richiamo, anche estetico, ad un mondo di certezze di ferro e cemento, coniugato con l’origine da balera del loro punk, a sua volta contraddittorio per l’uso programmatico di una batteria elettronica al posto della classica batteria da gruppo rock, e schizzato di continui richiami ad una impossibile purezza ideologica, contrapposta alle contraddizioni del capitale: quelle stesse contraddizioni che incidevano nel profondo l’esperienza politica ed amministrativa dell’Emilia Romagna, nata con l’originalissima visione di Palmiro Togliatti del “Ceto medio ed Emilia Rossa” e finita nella “Rozzemilia” (come tutta Italia, in fondo), sazia e disperata, in cui tutti sono onesti e tutti sono pari… e provocando, così stati di alterazione, e una spettacolare visionarietà scenica, modulata dalle provocazioni di Annarella e Danilo Fatur artista del popolo.
Ed è qui, che si riverbera la loro forza, dalla metà degli anni ‘80 in poi, anche in relazione alle prime vere discussioni, all’interno del Partito Comunista Italiano, sulla linea da seguire, con i primi congressi nei quali comparivano le Tesi, ma anche gli emendamenti, a quelle Tesi, a sottolineare l’inesistenza di un partito granitico e fideista, e l’esistenza invece di un partito nel quale, sia pure con troppe cautele, era posta in discussione la strada da seguire e, in questo timido ma essenziale cambiamento, i CCCP erano naturalmente un riferimento per quanti, soprattutto giovani, intuivano che dietro la pretesa etichetta di “filosovietico”, vi fosse in realtà una acuta elaborazione del reale che poneva un accento, anche ironico, sulle contraddizioni, non abbastanza indagate dell’assenza di senso di un mondo che sempre più esaltava il consumo e l’irresponsabilità e l’individualità, mentre proponeva un impossibile ritorno ad una purezza ideologica originaria, che si trasformava però nel contempo, in una denuncia, anche disperata, di una condizione limite che gli anni ‘80 stavano vivendo, di alienazione e straniamento; dentro periferie, rapporti di lavoro, relazioni interpersonali, perdita di direzione del progresso, emersione del denaro e dell’apparire come unici regolatori dei rapporti sociali.
Tanto più i CCCP mostravano di esaltare le granitiche certezze dell’Est europeo, tanto più in realtà si facevano portavoce del disagio profondo dell’Ovest, destinato ad esplodere con la caduta del Muro di Berlino, e a trasformarsi nell’esaltazione dei bruti rapporti di forza economici, in cui molti soccombono e sono abbandonati, e pochi prosperano sulle spoglie degli altri.
E’ per questo, che ad inizio della mostra, sotto gli archi dei Chiostri, è scandita la frase contenuta nel brano “Io sto bene”, non a caso tratta dal loro primo 33 giri “1964-1985 Affinità/Divergenze tra il compagno Togliatti e noi – ovvero del conseguimento della maggiore età”.

Ma, in realtà, “io sto bene, io sto male, io non so dove stare, io sto bene, io sto male, io non so cosa fare”, segnala che la questione di qualità investe il campo fondamentale dell’esistenza: non saper cosa essere, in un tempo che presentisce il cambiamento, e mentre si vorrebbe anche provare ad indirizzarlo, si resta invece , alla fine, totalmente spiazzati e travolti.
Nel cortile centrale del chiostro, intangibile, il fantasma della separazione del mondo: la fisicità di una Europa divisa dai reticolati e da un muro, allora, disunita oggi, dai diversi egoismi nazionali e nazionalisti: una sorta di monumento funebre ad un tempo che è ancora, e dentro il quale i CCCP hanno provato a costruire ponti, anche con l’Islam, prima che questo diventasse brodo di coltura del terrore.

Questa sezione della Mostra di Reggio Emilia, introduce al racconto della discografia dei CCCP; dai primi singoli autoprodotti all’ultimo disco uscito, insieme ad Amanda Lear; una versione scarnificata e tribale di “Tomorrow”.
Una storia ricca di canzoni, di concerti, di ricerca, e di rigore.
Una storia piena di versi iconici e scolpiti nella carne e nel sangue di un mondo che diventava invece sempre più esangue.
Una storia percorsa sempre sul filo più tagliente di una lama che guardava e sezionava il mondo e le anime; senza paura di apparire estetizzanti, o commerciali; troppo realistici o sognatori; utopici o veterocomunisti destinati ad essere ignorati da un mondo paninaro in piena esplosione ormonale da televisione privata berlusconiana.
Una storia che esaltava la possibilità di comunicare su più piani e su più canali, quando non esistevano le connessioni internet e le loro storie passavano per volantini autoprodotti, manifesti di concerti disegnati a mano; abiti inventati e invenzioni recuperate dentro le strade dritte, nebbiose e scure dell’Emilia di campagna, densa di memorie partigiane e di industrie alimentari maleodoranti.
Una storia che coinvolgeva molteplici possibilità espressive; suggestioni di bazar orientali, paure e presenza della morte, sfidata, in nome di piani quinquennali e della voglia di irraggiungibile stabilità.
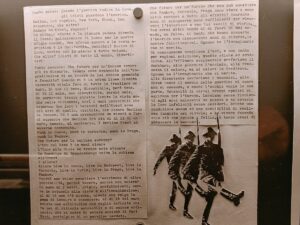
Una storia segnata dal recupero dei ritmi delle feste di paese e dei balli nella Casa del Popolo, per renderli eterei e beffardi, come nel valzer di “Oh, battagliero”, che, ricordata in una stanza in cui è presente il tavolo dove si riuniva la Segreteria della Federazione Provinciale del PCI di Reggio Emilia, presentisce il fetore del prossimo ceto politico, purtroppo talvolta anche ammantato di Sinistra, ammonendolo, tuttavia, in nome di una dirittura morale sempre praticata, non come “diversità” berlingueriana, ma, più semplicemente, come “normalità” contadina, credente, militante (ah, se la si fosse spiegata così, l’”Austerità”, così vicina al nostro carattere nazionale…), che “non lo salverà dal cero, il suo lucido pensiero disinvolto faccendiero…”
Aspetta tutti noi una fine perché “esiste una sconfitta, pari al venire corroso, che non ho scelto io, ma è dell’epoca in cui vivo…” E si può fare, contemporaneamente, lode a Mishima, e a Majakovskij, mentre ci si lancia in una scelta nichilista imposta da altri e vissuta come una imperdonabile condanna: “produci, consuma, crepa…”
Eppure, “teatri vuoti inutili, potrebbero affollarsi, se tu ti proponessi, di recitare te…” Ferretti e Zamboni cantano la consapevolezza della unicità di una esperienza politica ed amministrativa che diventa esistenziale, e che chiede a sé stessa di ritrovare sé stessa, non per un impossibile ritorno a radici mitiche, bensì per rielaborare, quelle radici, alla luce di quel che è accaduto dopo, di quel che accade oggi.
Recitare sé stessi, non per soddisfare un ego ipertrofico, come talvolta facciamo sui social; ma per ridare senso ad ogni discorso, ad ogni singola storia del nostro essere: alle nostre molteplici origini, trafitte e trapassate dal futuro, perché noi, per quel che siamo, e vorremmo essere, non possiamo che “tifare rivolta”.

Socialismo, o barbarie.
Non sono molte altre, le alternative.
La musica dei CCCP esplora l’Oriente, tra drammi afghani e fascinazioni mongole (che saranno riprese dopo, in un’altra loro incarnazione) : “era vanto dei Mongoli, che una vergine sola, sopra un carico d’oro, traversasse indenne i domini del Khan”; e auguri ad Hong Kong, che di lì a poco, sarebbe “tornata a casa”, dopo la dominazione coloniale; per tornare alla Cina, parafrasandone l’inno per provare a raggiungere qualcosa di cui si sente l’esistenza, ma non se ne rilevano/rivelano i contorni e si prova, per questo, ad “odorare il sapore celeste del ferro e a vedere il profumo sanguigno del fuoco”, e si rovescia anche, la famose frase di Lenin, perché “i Soviet più l’elettricità, non fanno il Comunismo”, perché si può solo continuare a cercare, e non si svende, l’ideale, anche se non funziona; bisogna invece osare l’impossibile, persino osare perdere.
E quanta triste consapevolezza c’è in queste parole, mentre il circo mediatico intorno, continuava a mettere l’accento sulla loro “ortodossia sovietica”, proprio mentre, prima di tutti, ne raccontavano il disfacimento angosciante ed irrimediabile, pur se si lasciavano ancora una speranza di futuro: ed era questa, la loro vicinanza più grande al nostro sentire di allora, di giovani uomini e donne di Sinistra, non irregimentati, che avvertivano contemporaneamente, il dolore di una perdita, e la necessità di un riscatto. Noi non eravamo conformi, e sapevamo, che solo da noi stessi poteva venire qualcosa di più che salvasse noi, e tutti gli altri intorno.
Ci siamo riusciti ?
Probabilmente no. Ma molti di noi non hanno smesso di andare in quella direzione, consapevoli che “io non adoro quello che voi adorate e voi non adorate quello che io adoro; io non venero quello che voi venerate e voi non venerate, quello che io venero”.
E noi sapevamo, che ce ne erano tanti, già allora, di soggetti cui si poteva cantare : “ eri così carino, eri così carino, pigro di testa, e ben vestito: non fai niente di male, niente di ciò che credi, non sai quello che vuoi, non riuscirai ad averlo…”
Qualcuno tra loro, forse, invece lo sapeva molto bene, cosa volesse: un posto dove restare ben aggrappato a mangiare…

Il tempo, sta finendo, perché “ Paolo VI non c’è più, è morto Berlinguer, qualcuno ha l’AIDS, qualcuno è pre, qualcuno è post, senza essere mai stato niente”. E siamo persi, confusi, a abbiamo bisogno di qualcuno che ci tenga tra le braccia, ci rinfreschi, con la propria saliva, ci dedichi i suoi giorni, le sue notti, domani, e ancora, e sempre, in realtà, abbiamo di questo bisogno: d’essere stretti forte, coperti, avvolti.
Perchè io, “vorrei morire ora”.
E’ il tempo dei “sezionatori d’anime, che giocano con il bisturi, di maggioranze boriose che cercano furbi e stupidi, sobillano i malvagi, aizzano i violenti e gli invidiosi indispongono” ed è il 1989, quando i CCCP guardano dentro il futuro.
Un futuro in cui “ se produco, sembra che convenga, se consumo, sembra che convenga, se mi espando sembra che convenga, mi assicuro sembra che convenga, me ne frego, sembra che convenga…”. Ritornano persino le semplificazioni verbali del fascismo.
E la consapevolezza, che “non è questo, il migliore dei mondi possibili, eccolo è un luogo finalmente spazioso, ormai privo d’alberi, di vegetazione, affollato di centri di concentrazione”: una visione di centri commerciali avvolti dal nulla del nostro tempo.
Non resta che pregare: un canto delicato, un canto dedicato alla madre di tutti e di tutto, ad un Dio donna, finalmente: “ Madre di Dio, e dei suoi figli, madre dei padri e delle madri, madre, oh madre mia, l’anima mia si volge a te”…

E, infine, ti amo.
“Amami ancora, fallo dolcemente, un anno, un mese, un’ora, perdutamente, amami ancora, fallo dolcemente, solo per un’ora, perdutamente. Amandoti è la vita, la mia”. Nella mia vita, posso solo amarti.
E’ il momento del distacco. Dell’Epica, dell’Etica, dell’Etnica, del Pathos.
Un distacco che sa già di futuro, anche se affoga nel tedio domenicale, che consuma droga, mentre Sophia Loren , Santa Sofia, cucina la pizza a Pozzuoli.
I CCCP sono già altrove “ No, non ora non qui, in questa immane frana…la libertà è una forma di disciplina, assomiglia all’ingenuità la saggezza…”, una Depressione Caspica, che muove, sgretola, dilaga…
Alla vigilia di una nuova stagione politica, che nel 1990 sembra imminente, è singolare che questi musicisti sentano il bisogno di dichiarare che, nell’andazzo generale è “causa nostra, cosa nostra…cosa nostra colpa nostra…” E’ finito il Maxiprocesso di Palermo alla mafia, e sta per aprirsi una stagione di vendetta e di stragi, e i CCCP riflettono sulla comune responsabilità, di fronte a fenomeni divenuti endemici e pervasivi, privi ormai di confini geografici, mentre tutti, a quel tempo, li consideravano fermi a precise aree geografiche.
E poi, l’addio, dolcissimo, di “Annarella”: “Lasciami qui, lasciami stare, lasciami così, non dire una parola che non sia d’amore, per me, per la mia vita che è tutto quello che ho”, e non è solo l’addio ad una storia, che contiene in sé gli “Appunti di un viaggiatore nelle terre del Socialismo reale”, ma anche l’ultima invettiva di “Maciste contro tutti” : “Soffocherai tra gli stilisti, imprecherai tra i progressisti, maledirai la Fininvest, maledirai i credit cards…sembra sole nascente il sole d’Occidente, sembra sole che nasce, questo sole calante…” La voce di Giovanni Lindo Ferretti, non è solo salmodiante; è la voce di un profeta sconfitto.
La sconfitta dell’amore, del troppo amore buttato via, non esplorato, fino in fondo, non compreso, fino in fondo; o forse, solo il rogo che serve ad andare oltre.

Di qui, si sale; si sale al secondo piano del convento, e non lo voglio raccontare.
Perchè è un immenso viaggio nell’arte moderna, e nella modernità della loro arte, perfettamente inserita dentro un contenitore incompiuto, che sfolgora, di inquietudini e suggestioni; di ironia e di dolore; di possibilità e di profondissimo amore.
Solo tre foto, per invitare tutti ad andare a Reggio Emilia e ad immergersi dentro questa straordinaria storia e dentro questa straordinaria ricerca di senso; dentro questa straordinaria esplorazione umana; e non si esce, come si è entrati. Ma con un profondo sentimento di meraviglia e di gratitudine.
E anche con la voglia di averne ancora; mai con gli occhi rivolti al passato, ma solo con la determinazione rivolta al futuro.












