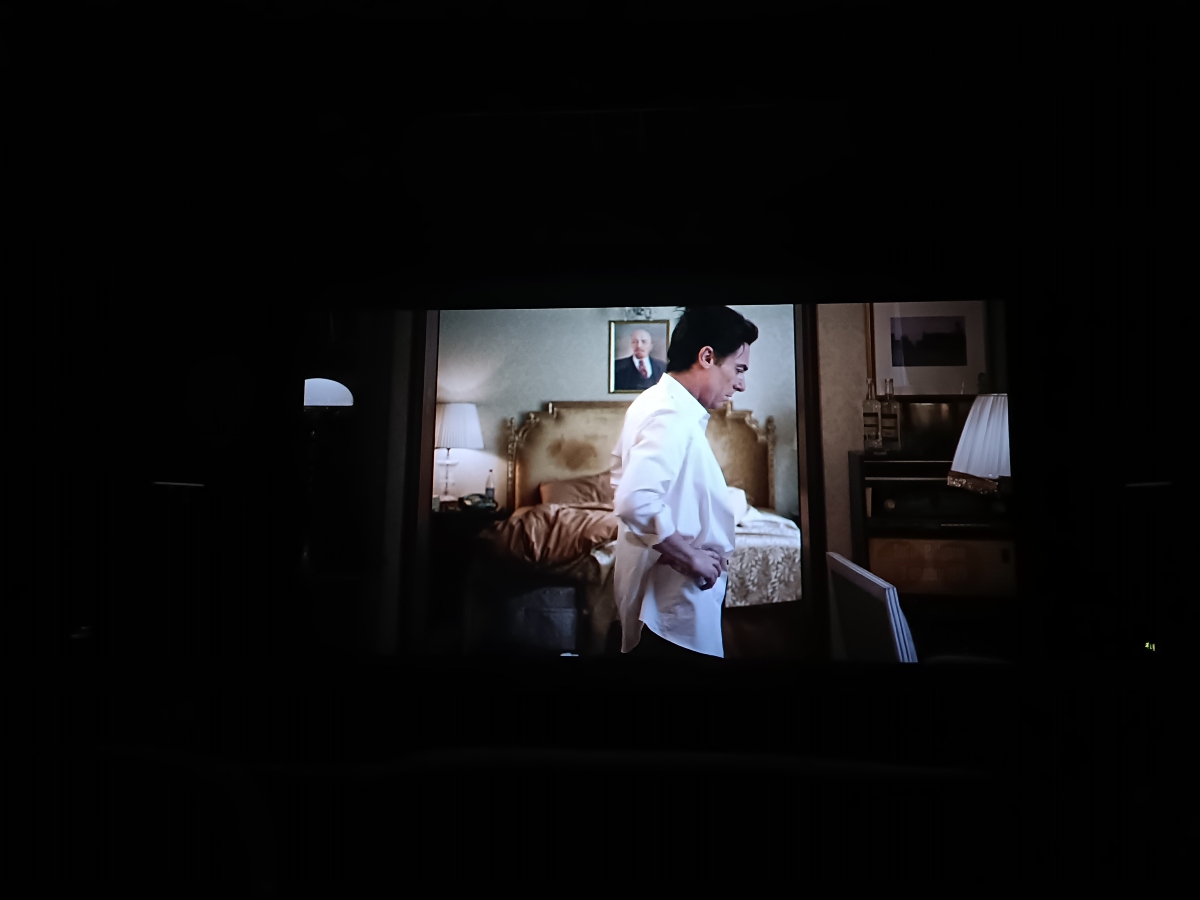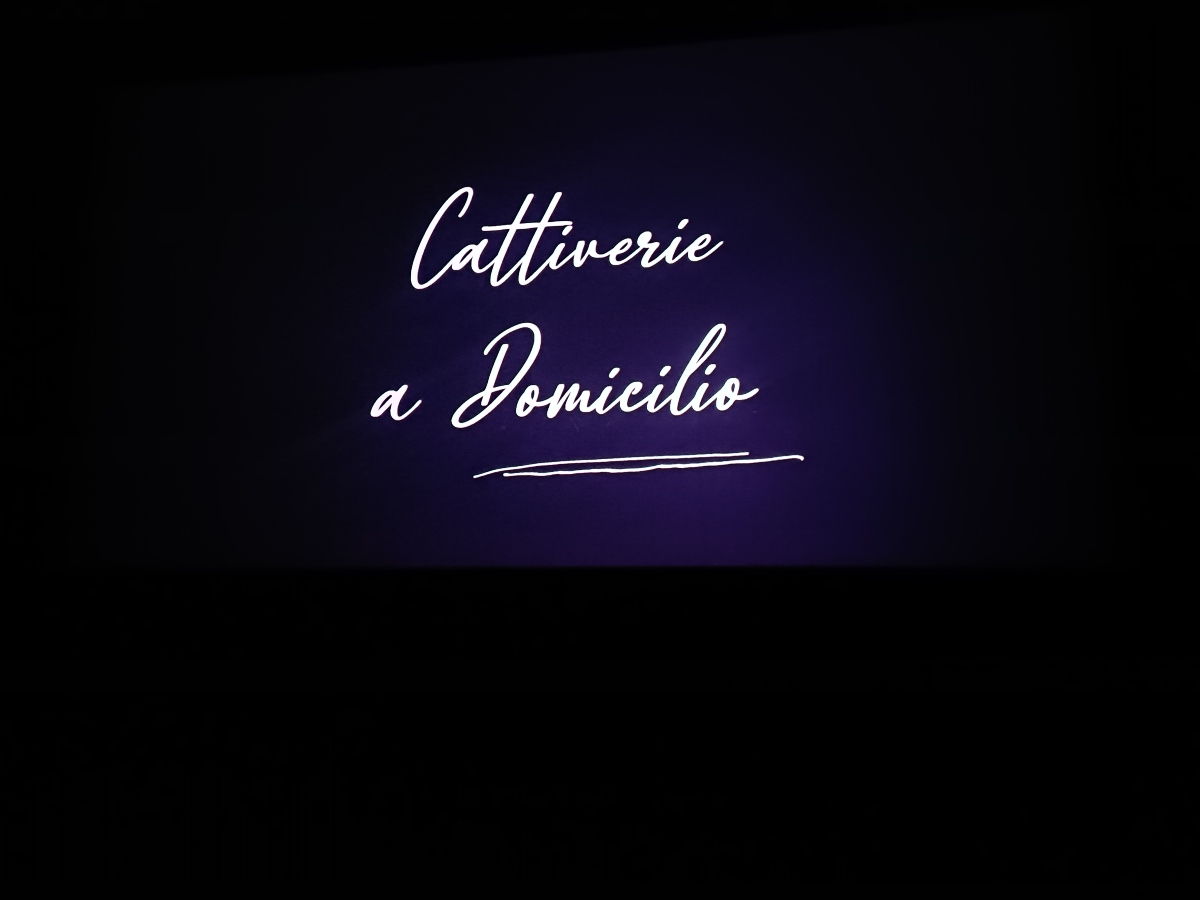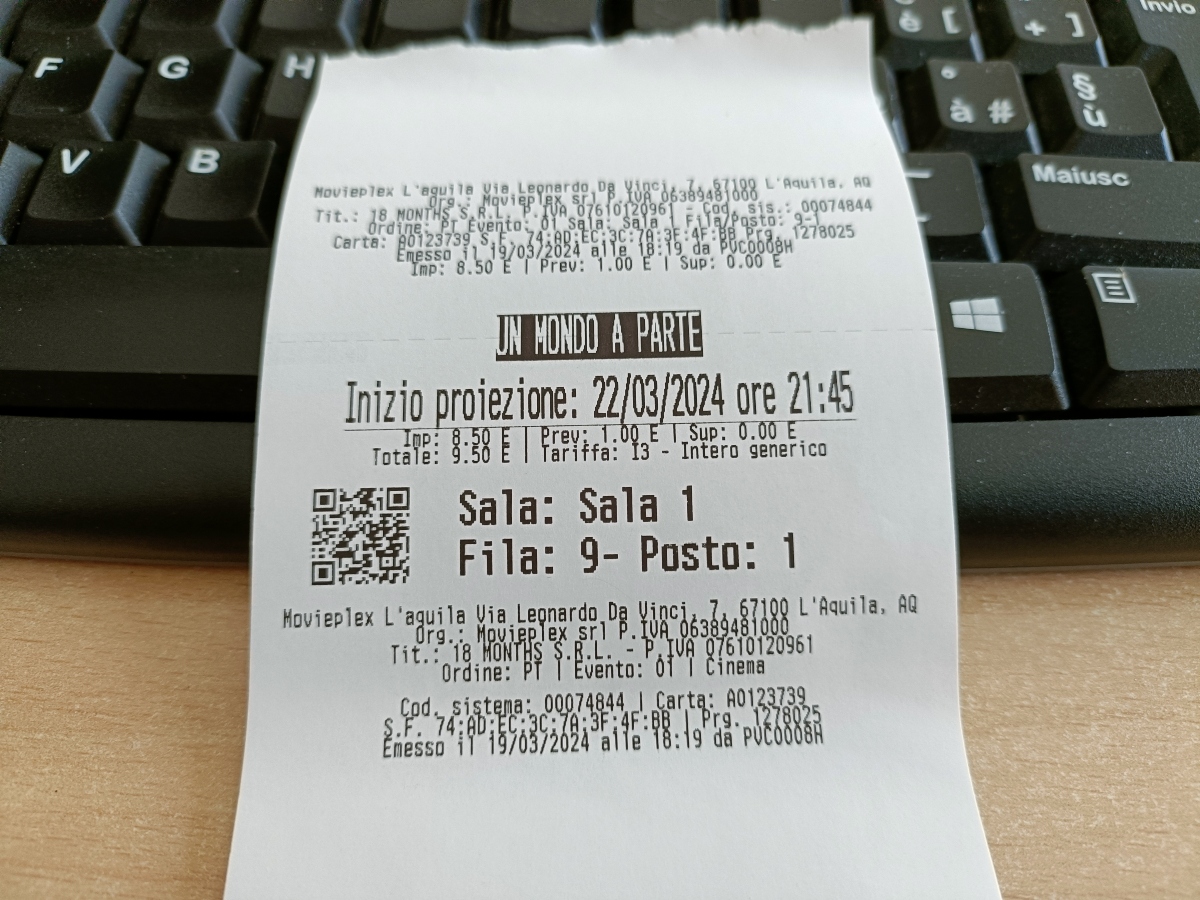Chi riesca ad inventare una storia, raccontandola poi, in una certa misura, somiglia ad un Creatore.
E’ lui, a decidere dove cammina una narrazione; quali deviazioni si trovi a percorrere; cosa guardare, durante il percorso. E’ lui a decidere se la storia abbia un finale, o se, invece, possa essere lasciata sospesa, perché è giusto lasciare aperte le porte al possibile.
Ozpetek, col suo film “Diamanti”, esplicita, la sua funzione di creatore della storia, e di artefice di essa, nello stesso tempo; e se nella stessa persona, possono esser presenti l’idea di una storia, e la sua concreta realizzazione, allo stesso modo, in quella stessa storia, è possibile raccontare il concreto svolgimento di accadimenti, che sono, in un medesimo tempo, fantasia, ricordo, e realtà.
Ma tutto è al servizio del mezzo, attraverso il quale raccontare questa storia diviene possibile: il cinema. Un mezzo che, in sé, permette la sintesi tra i diversi elementi del racconto, e la sua relazione con la realtà.
E il film infatti, inizia col regista che riunisce le sue attrici, e i suoi attori, intorno ad un tavolo, ed insieme a loro discute la trama e l’assegnazione dei personaggi, che subito diventano gli interpreti della storia, e che, ogni tanto, nel farsi del film, torneranno ad essere insieme, fuori dal film, per affinarne i ruoli, e accompagnare lo svolgersi degli eventi.
Ed Ozpetek, diviene il Creatore della storia, che, non solo racconta di un gruppo di donne che lavorano, ma forse anche di una personale infanzia, che ritrova, proprio al termine del film, forse, la propria Rosebud, come un Orson Welles che non si sia perso nei suoi deliri di potere, ma abbia, fino in fondo, vissuto la bellezza del proprio fare, ed in esso cercato l’eccellenza.
Il film racconta di un gruppo di donne che lavorano.
La loro immagine pubblica, è quella del lavoro; ma dietro il lavoro si nasconde la vita personale, con i suoi drammi, le sue contraddizioni; il suo dolore e le sue possibilità di redenzione; con la sua solidarietà, la sua ambizione e la sua passione del realizzare idee, sogni; costumi per lo spettacolo ( teatro o cinema ), capaci d’essere essi stessi ruolo e personaggio.
Un tempo, non tanto lontano ( visto che la vicenda si svolge a metà degli anni ‘70 dello scorso secolo ), l’Italia, e anche Aquila, era un paese di artigiani, talvolta geniali e capaci di dar vita ad imprese importanti, qualcuna, di peso mondiale.
Un tempo, il centro di Aquila, era popolato da artigiani, che ne rendevano vive le vie; e così era in tantissime altre città d’Italia dove ora, come ad Aquila, i centri storici sono stati svuotati e resi una pura scenografia a servizio del consumo.
Un tempo, l’Italia era un paese anche di sarti che inventavano la moda e il costume, per tutto il mondo, prima che l’ingordigia finanziaria portasse i tessuti ad essere lavorati in paesi lontani, con lavoro a bassi salari e senza diritti.
Nel tempo del film, due sorelle, irrigidite dapprima, ciascuna, nella propria maschera, dirigono e gestiscono un atelier che, d’improvviso, si trova di fronte alla sfida di realizzare abiti di scena disegnati da una costumista premio Oscar, per un film, diretto da un regista premio Oscar, in tempi assai ristretti.
Il film sfiora, drammatizzandolo con la personificazione di un amore trascorso, uno dei motivi per cui quel mondo di manualità straordinarie e di abilità e dedizione individuali non ha avuto futuro: perché non è stato possibile collegare quelle competenze con il mondo finanziario, troppo spesso attratto solo dal guadagno facile e rapido. Quelle imprese non erano capitalizzate, e poste di fronte alla concorrenze di altri che abbassavano i costi producendo all’estero, hanno finito con lo scomparire e, con loro, un intero mondi di saperi non replicabili.
Nella storia di Ozpetk, c’è tanto, il rimpianto per questa dimensione produttiva. Più umana, più rispettosa dell’ingegno e del lavoro compiuto ad arte; di fronte ad un mondo odierno che, mentre finge di esaltare in ogni modo l’individualità irripetibile, in realtà la macina e la massifica dentro la ruota di un consumo globale inesausto e privo quasi del tutto di senso.
Purtroppo talvolta, a me pare, questo rimpianto sia troppo calligrafico, impegnato com’è ad inseguire i dettagli di una bellezza classica ed antica, piuttosto che il succedersi degli eventi dentro un arco narrativo che, forse anche per questo, talvolta sembra eccedere nel melodramma.
Il melodramma italiano, quello lirico in particolare, ha dettato il modo di raccontare storie nel mondo per un tempo lunghissimo; ed era capace di avvincere a sé lo spettatore fin nelle emozioni più profonde e significative. Ma, forse, era lontano dalla trama più vera della realtà, dei suoi rapporti sociali e delle sue tensioni ideali.
Ozpetek chiede alle sue attrici – tutte grandi prove di presenza dentro una coralità multiforme – di inserire nella trama antica delle dinamiche del dramma da cui tutto origina ( la morte di una figlia ), le moderne tensioni del lavoro femminile, che mal si sposa senza servizi con la cura dei figli; che si scontra col permanere di un presunto dominio maschile pronto ad affermare le sue ragioni anche con la violenza più cieca e brutale; che mette in tensione gli equilibri familiari per i tempi di lavoro che possono dilatarsi secondo necessità eterodirette.
Che scopre, infine, che solo con la solidarietà e la cittadinanza per tutte le voci, possono raggiungersi obiettivi di assoluto rilievo, e possono essere vinte sfide in apparenza insormontabili.
Quello che più colpisce, nel film, è la volontà di rendere pubblici i sentimenti, le emozioni, senza la mediazione del nascondimento, o della loro attenuazione. I nodi stretti e difficili delle relazioni interpersonali, vengono costantemente declinati nei termini del conflitto, ma anche del cambiamento reciproco, che è il vero effetto positivo del dialogo.
Ci sono amori infiniti che vengono fatti morire dall’assenza di dialogo: dalla mancanza di capacità nel parlare e nell’ascoltare; nell’aprirsi.
Le donne di Ozpetek sembrano indicarci la strada della parola e della fiducia reciproca, per uscire dal buio del vivere; per crescere insieme. Per trovare, e ritrovare nuove ragioni che nobilitino il legame che ci unisce agli altri, piuttosto che accentuare tutte le tentazioni di separazione, che, quotidianamente, sperimentiamo, e che sembrerebbero rispondere alle nostre domande, mentre invece servono solo ad isolarci, a renderci più tristi e deboli, incapaci di incontrare l’ardore incontaminato del vivere e realizzare i propri sogni.
E tutte le donne del film escono cambiate, dal suo dipanarsi: meno maschere, e più persone, fragili, e bisognose di cura reciproca.
Devo dire che trovo molto bello, in tutto il film, il modo con il quale attrici e regista hanno scelto di enucleare sentimenti ed emozioni da ogni singolo gesto, o parola, o inquadratura, ma, nello stesso tempo, ho avuto come l’impressione che, tutto insieme, si volesse racchiudere tutto; come in una sorta di vocabolario completo e senza esclusioni, d’ogni possibile crinale difficile del nostro vivere e di come, dinanzi ad esso, si possa reagire e porsi.
E’ stato come seguire un romanzo d’appendice nella sua pubblicazione, un tempo, a puntate sui quotidiani, e ritrovarsi, ad ogni scena, ad un “colpo di scena”, lasciato sospeso sino al momento in cui quella particolare storia, non fosse ripresa dopo la pausa in cui la si era lasciata.
Ed è avvincente, seguire i romanzi d’appendice, però rischia di saziare troppo.
Come certi fumetti di Tom of Finland, che forse hanno ispirato la fisicità aderente, di tutti gli operai maschi che, a più riprese, interagiscono con l’atelier, per consegne o manutenzioni.
Questo modo, forse dolciastro, che il Creatore ha scelto, per raccontare questa storia, ha il sapore agrodolce della nostalgia, e però, nello stesso tempo, forse è proprio per la scelta di essere nel film mentre il film si srotola, che può credersi, anche oggi, possibile costruire comunità che, magari proprio dal conflitto sincero, sappiano distillare quanto di amore è necessario per vivere.
E certe volte, ce ne vuole una quantità straboccante.