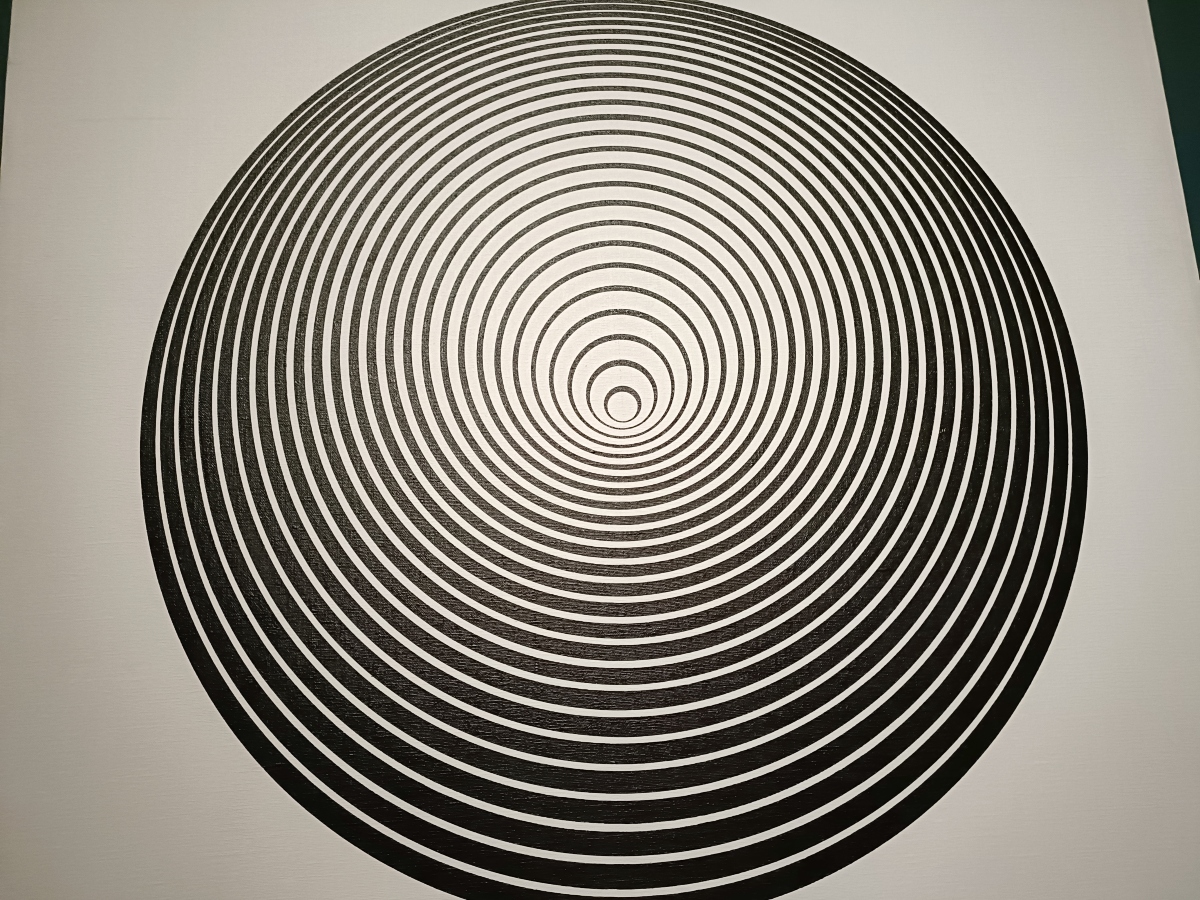Aveva inventato un piccolo marchingegno. Era una scatola metallica, piena di ingranaggi e vecchie valvole di televisione; transistors e circuiti stampati miniaturizzati.
Voleva realizzare uno strumento che permettesse di far scegliere a ciascuno, ogni volta che se ne avesse bisogno, la giusta decisione. Quella che avrebbe salvato il mondo, o quella che avrebbe consentito di studiare la materia verso la quale si fosse davvero portati.
Insomma un attrezzo che funzionasse come una specie di macchina della verità per la storia futura. Lo avrebbe regalato, se avesse funzionato, perché tutti potessero compiere scelte giuste nella vita, ponderate, precise, e positive anche per sé stessi.
Iniziò allora un periodo di sperimentazione su di sé . E si accorse che, talvolta, la scelta effettuata si rivelava davvero positiva; altre volte invece, la scelta produceva risultati contraddittori. Se erano positivi, portavano però con sé anche dolore, o magari paura; se erano negativi, esprimevano però, anche momenti di grande bellezza e trasporto, conoscenza profonda.
Allora si dedicò a riesaminare tutto il funzionamento della sua macchina, e anche tutte le decisioni assunte.
E si accorse, che, in realtà, tutte le decisioni che aveva assunto, erano tutte segnate dal suo cuore. Dal suo comando dolce e urgente. E si accorse che la macchina aveva tentato, senza riuscire, di fargli cambiare le sue scelte, che pure lo avevano esposto a acutissima sofferenza.
E allora comprese che, per lui, la scelta giusta era comunque il cuore; nessuna macchina avrebbe potuto vincere il suo cuore. A costo di piangere.
Forse sarebbe accaduto allo stesso modo per tutti, o per tanti. Non poteva saperlo, ma non poteva coinvolgere altri in alcun rischio.
Smontò la macchina, allora.
Ed iniziò a pensare subito, ad una macchinetta capace di fabbricare una nuvola nevosa. Da portarsi a spasso, come un ombrello; d’estate, ad esempio.
=======================================================================
Era da tanto tempo fermo, sotto il sole, il ragazzo. In testa portava una vecchia coppola di rafia intrecciata, e stava pescando, ormai da qualche ora, con una canna, in piedi sugli scogli alti in cima al mare.
Era una giornata senza cielo, oscurato da nubi di sabbia grigia e pietrosa di deserto, da cui filtrava la luce del sole, che si rifrangeva sui miliardi e miliardi di granelli di Africa sospesa sul fiato di scirocco, ingiallendo tutta l’aria, come una infinita lampada di fornace.
Il mare pareva addormentato.
Le onde, solo piccole vibrazioni di acqua lontana, arrivate sugli scogli, sembravano frenare, e inabissarsi sul fondo, senza rumore, per riprendere corsa, solo dall’altro capo del mondo.
Il silenzio era rotto, ogni tanto, dallo stridio di gabbiani alti, con le ali immobili ed aperte a catturare il vapore caldo, capace di sostenerle, che sembrava essudare dalla terra stessa.
Il ragazzo era davvero stanco, ed iniziò a guardarsi intorno. Qualche decina di metri, distante da lui, vedeva una confusa figura stesa su un asciugamano poggiato sugli scogli; una donna forse, che prendeva il sole. Raccolse allora l’amo della sua canna, e ripose in un secchio di plastica, le sue esche, e il coltello, che aveva portato con sé. Voleva andare via, passando però vicino a quel che aveva visto da lontano, stranamente attratto. Si avviò verso la figura che aveva visto.
Era una ragazza bellissima, coi capelli biondi e gli occhi scuri delle praterie d’alghe sott’acqua.
Il ragazzo s’incanto’, a guardarla. E non sapeva come poterle parlare. Si sentiva sudato, sporco, le mani puzzolenti di pesce e gambero d’esca.
Restò lontano un paio di metri e tese verso di lei, che lo guardava, una mano aperta.
Le chiese solo un pezzo di pane. Un pezzo di pane da mangiare.
E non ebbe il coraggio di chiederle altro.
======================================================================
Per le strade della città, le persone camminavano distratte, occupate a leggere i cellulari, o a far finta di non sudare. Il caldo scioglieva il catrame dell’asfalto, e sembrava di camminare in un fango rovente e appiccicoso.
L’uomo entrò in una libreria.
In realtà, a guardarla da fuori, non sembrava una libreria. Ma un piccolo e polveroso bazar, pieno di braccialetti di pasta di vetro, statuine, cocci, fogli di carta sparsi, e libri.
C’erano anche libri, grandi, rilegati in pelle di tutti i colori, dentro armadi di legno scuro.
L’uomo, chiese di poter accedere al reparto speciale, e venne accompagnato ad una piccola porta nascosta, sul retro, che dava su una scala stretta, a chiocciola, che scendeva per molti e molti metri, sotto il livello della strada, arrotolandosi su sé stessa, e diventando sempre più buia.
La scala consentiva l’accesso ad un ambiente molto grande, illuminato dalla luce verde fosforescente, di enormi lucciole che volteggiavano, numerosissime e silenziose, sotto una volta altissima, che poteva anche essere un cielo di notturne stelle irrequiete.
C’era uno strano omino, con le orecchie pelose e appuntite, dietro il bancone, tutto vestito di verde e rosso.
E fu a lui, che l’uomo chiese.
Voleva regalare un libro, e voleva che questo libro avesse solo pagine bianche, su ognuna delle quali, la storia si scrivesse da sola, con inchiostro rosso, e nero, e la storia che si scriveva mentre accadeva, doveva condurre al finale, che chi leggeva il libro avrebbe sognato.
Voleva regalare questo libro ad un suo amico. Un amico terribilmente solo.
=======================================================================
Non aveva mai saputo, quanto fosse grande il mondo, ogni volta che partiva per un viaggio.
In ogni luogo ove arrivasse, sempre, la prima cosa che faceva, dopo aver disfatto la valigia nel proprio albergo, era andare nel centro della città, e restar fermo, seduto ad un bar, o su una panchina, talvolta persino su un marciapiede, ad osservare tutte le persone che si muovevano.
Più che i monumenti, o i musei, o i panorami, pensava fossero le persone, a raccontare un luogo.
Ne osservava la fretta, o la lentezza nel camminare. Cercava d’ascoltare le parole che venivano dette. Contava le persone che entrassero in un determinato negozio, e poi magari in un altro, che vendeva una specie diversa di prodotti. Ne guardava le borse a tracolla, e i sacchetti della spesa, portati a casa camminando. Vedeva i bambini giocare, e gli sguardi che si cercavano.
Ma, soprattutto, cercava di individuare le coppie, che camminavano insieme, chiudendo poi gli occhi, e cercando d’immaginarne la relazione, il modo di stare insieme, le loro mani che si tenevano unite.
Poteva apparire quasi una pretesa presuntuosa, immaginare di capire, e provare a conoscere un luogo, unicamente osservandone, per caso, e per poco tempo, le persone che lo abitavano.
Però lui, tornava solo nei luoghi dove, secondo la sua personalissima valutazione, aveva percepito più trasporto, passione, amore.
Ci si trovava meglio. Meno solo.
=======================================================================
Gli piaceva la marmellata di fichi.
Quand’era il momento, girava per campagne sperdute, cercando alberi che crescevano spontanei. E, raccoglieva una buona parte dei frutti che riusciva a trovare, lasciandone sempre però, una parte importante sull’albero. Per il prossimo che fosse arrivato, o per qualche passero che aveva scoperto d’essere goloso.
Portava con sé, sempre, una busta di plastica, che riempiva, e poi tornava verso casa. Ad ogni frutto colto, dal ramo usciva una goccia di latte bianco, come un sangue denso e appiccicoso, che gli restava sulle dita. Profumava, quel sangue, che pareva quasi un incenso, per quanto inebriava.
E stava attento a non inerpicarsi mai. I rami del fico erano fragili, non in grado di sostenere il peso di un uomo. Le foglie, grandi e verdi, parevano spinose, ed era necessario non tagliarsi, perché quelle ferite, slabbrate, bruciavano davvero.
Puliva i frutti, e li univa allo zucchero, al limone, ad una stecca di vaniglia, e preparava la sua marmellata che poi poneva a riposare in piccoli vasetti di vetro.
Gli piaceva regalarli. O offrirli, per colazione, a tutti i ragazzi che venivano a trovarlo; lui vecchio professore ormai, che viveva, da solo, in una casa vicino al mare.
Ragazzi e ragazze, d’estate, passavano da lui per parlare, per raccontare, per ascoltare le sue lezioni di storia, o di letteratura.
E anche perché, le sue colazioni, di frutta, pane, marmellata e thè, erano leggendarie e buonissime.
Quei ragazzi, erano la sua strada per vivere, fin quando fosse stato possibile.
Ed erano la sua salvezza, per non perdersi dal dolore.
La donna che amava, non c’era più. Ma lui continuava a parlare con lei, sempre, e le raccontava i colloqui con i ragazzi, nella sua casa aperta.
La notte, sotto la luna. Mentre le cicale facevano brillare le stelle, lui parlava con lei, illuminando il buio.
Fino al giorno in cui, la porta di casa sua, al mattino, restò chiusa.
Quel giorno, il mare era scuro, in burrasca e maestrale, e il cielo basso.
Come un quaderno su cui non scrive più nessuno.
=======================================================================
Andava al lavoro in bicicletta.
Percorreva una strada di curve e alberi.
E la vide, quel mattino, d’improvviso.
Una giovane cerva, dal manto grigio. Gli occhi grandi, curiosi, più che spaventati da lui. Il collo, lungo e flessuoso, e le zampe eleganti. Restò ferma un istante, indecisa se attraversargli la strada, poi tornò indietro, scomparendo dietro la china di una piccola altura.
Prima di arrivare al lavoro, si fermò ad una cartoleria e comprò un piccolo quaderno e una matita.
Cercò di disegnare quegli occhi che aveva visto. Solo quegli occhi. Perché gli sembravano il primo sguardo della vita sul mondo.
Ma lui non era capace di disegnare così bene. E la bellezza, nella memoria, faceva male.
Perché non poteva toccarla.
=======================================================================
Il giovane era arrivato sino ad un prato di montagna. Un breve tratto stretto tra due colline basse, in lieve discesa, ancora colmo di papaveri fioriti, rossi, come le macchie di un sangue felice.
Andò a sedersi, tra i fiori.
Aveva con sé un palloncino, che teneva legato al polso sinistro, per non farlo scappar via. Prese dalla tasca un piccolo quaderno e ne strappò un foglio. Ci scrisse sopra solo due parole.
Poi, arrotolò il foglio, facendone un piccolo cilindro stretto che tenne fermo arrotolandoci intorno un filo d’erba secca, che lego’, rozzamente, alle estremità. E, infine, usò il filo col quale teneva fermo il palloncino, per legarvi il foglio col suo messaggio.
Slegò il nodo che s’era fatto al polso, e lasciò andare il palloncino.
Lo vide salire, lentamente, fino ad essere preso da una corrente, che lo portò via, lontano dalla sua vista. Neanche più un puntino, dentro il cielo azzurro, come un vetro terso.
Chiuse gli occhi allora, e si stese nell’erba.
Non seppe, quanto tempo restò così. Senza pensieri, a galleggiare nel prato, ascoltando i fiori mormorarsi colori e profumi.
Li riaprì. Forse era tardi a sera.
Il prato era colmo di palloncini di ogni colore, e, a ciascuno di loro, era legato un filo, con un piccolo foglio di carta attaccato.
Su ciascuno dei fogli, erano scritte solo due parole.
“Ti amo”.
( M’è venuta in mente, ascoltando “Message in a bottle”, dei Police).
=======================================================================
Gli dispiacevano, i giorni di sole intenso. Perché non si poteva giocare a pallone, nel pomeriggio dopo pranzo. Erano pomeriggi, allora, di lettura, dentro qualche ombra, in casa, tra lenzuola sudate e spicchi di luce che filtravano dalle persiane di legno.
Li passava ad innamorarsi. Di Sandokan, del Corsaro Nero, di Jolanda, la figlia del Corsaro Nero, o di Lady Marianna Guillonk, di Yanez, della tigre Dharma.
E quando andava al mare, immaginava quegli scafi di legno pesante, a vela; la loro capacità di tenere il vento e di affrontare la burrasca. E sentiva quanto coraggio ci volesse, per quegli uomini, a guardare ogni istante, il fondo di un abisso, al cui infinito potere, era legata la propria sorte indifesa. E non sapeva, se l’avrebbe mai avuto.
Dietro il banco della gelateria, c’era una ragazzina bionda, con un delizioso nasino a patata, che aiutava, d’estate, i genitori a lavorare nel negozio.
Per questo, in quei pomeriggi di sole intenso, in fondo, forse, lui non era poi così dispiaciuto, perché sapeva di poter attingere alla propria riserva segreta di monetine – messe insieme con qualche resto di spesa dimenticato in tasca, e con qualche piccolo lavoretto casalingo retribuito – per andare a comprare un gelato, sperando di dover fare una fila lunghissima, prima che arrivasse il suo turno.
=======================================================================
Era un serpente.
Nero, e strisciava sull’asfalto incandescente, come una crepa di terremoto cattivo.
Era la prima volta, che lui vedeva un serpente.
L’animale aveva una strana eleganza minacciosa, come un ballerino torvo, che ballasse da solo, dentro una immensa sala, con tutti gli occhi puntati addosso.
Nonostante la paura che gli accelerava il cuore, decise di avvicinarsi, per guardarlo meglio. Ma il serpente parve accorgersi, del suo movimento, e si fermò, raccogliendosi nelle sue spire, pronto ad attaccare.
Lui però, non cessava di avvicinarsi, e, addirittura, tendeva una mano verso il rettile, come volesse accarezzarlo.
Sentì il morso sul braccio, veloce e doloroso. Un colpo secco, che gli lasciò gocce di sangue sulla pelle, e la sensazione dei muscoli storditi, arresi.
Incredulo, vide crescere due ali sui fianchi del serpente. E lo vide volare via, mentre lui restava inginocchiato a terra, la testa sempre più annebbiata e stanca; la bocca totalmente seccata, e ogni fibra del corpo indurita, come se si preparasse a diventare pietra.
Si svegliò, di soprassalto, sudato e imprigionato dalle lenzuola, dalle quali finì col liberarsi a forza di strappi e movimenti convulsi sul letto. Aveva solo sognato.
Si alzò, e andò alla finestra a guardare il mattino. Tra i tetti e i campanili delle chiese, l’aria era tersa e già calda.
Sul suo braccio, i segni dell’ago con il quale, il giorno prima, due dottoresse avevano provato invano a prendere una vena, per le analisi del sangue che doveva fare.
Andò allo specchio allora e si tolse di dosso la maglietta, e cercò di guardarsi sulla schiena.
Cercava di capire se gli stessero spuntando due ali sulla schiena.
=======================================================================
Da bambino, pensava che l’orizzonte segnasse l’inizio di una infinita discesa. Bastava arrivare all’orizzonte, e poi la strada sarebbe stata facile e veloce, per arrivare dall’altra parte del mondo.
Del resto, se guardava un piccolo mappamondo che era in classe, dall’Italia, per arrivare sino al Polo Sud, era solo discesa.
Per questo, pensava sempre che, un pomeriggio d’estate, si sarebbe deciso a partire. Avrebbe scelto un orizzonte da raggiungere, e sapeva che non sarebbe stato facile, arrivarci; ma sapeva anche che, una volta lì, sarebbe stato come farsi spuntare le ali ai piedi, e, velocemente, avrebbe traversato l’intero mondo. Certo, un po’ lo spaventava il ritorno: tutta salita; ripida per di più e senza appigli, sul mappamondo.
Ma ci avrebbe pensato dopo. I ritorni sono sempre difficili, ma possibili. Immaginava che, una volta tornato a casa, dopo tutto il viaggio compiuto, nulla sarebbe stato come prima. Ma tutto nuovo. Persino la sua cameretta, gli sarebbe parsa diversa. Più grande, magari, più bella.
Per questo, un pomeriggio d’estate, decise di partire. E prese con sé la sua bussola di Lupetto. Doveva andare a Sud, per arrivare sino all’orizzonte e trovare l’inizio della discesa.
Fu a sera, dopo aver lungamente camminato, che arrivò al mare. Tramontava il sole. Lui, scendeva, per la discesa, oltre quell’orizzonte che ora, gli sembrava immensamente lontano.
Allora, capì di non poter arrivare sino all’orizzonte. Capì che, però, poteva immaginarlo, il punto in cui avrebbe incontrato la discesa; anzi, poteva inventarlo.
Nel punto in cui iniziava la discesa, appena dietro l’orizzonte, s’incontravano di nascosto, ogni tanto, sole e luna, che erano innamorati, l’uno dell’altra, ma non potevano dirlo, per non far invidia alle stelle. Era il punto in cui i venti andavano a riposarsi, e a raccontarsi tutte le storie che avevano incontrato correndo sul mondo. Era il punto in cui nascevano le onde, che portavano fino a terra, il richiamo dolce delle sirene.
Da uomo, quel bambino, continuava a pensare all’orizzonte. Popolandolo di meraviglie.
E ogni tanto, lo raggiungeva. Ma solo quando era insieme alla donna che amava.
=======================================================================
Era solo nella sua stanza il ragazzo. A sera.
Faceva più caldo, del giorno appena trascorso. Le nuvole sembravano essersi nascoste dal cielo, e spirava uno scirocco arido, sabbioso.
Le luci della sua stanza erano spente, e il tramonto iniziava a spandere una coltre rosa sulle tende.
Chiuse gli occhi, e immagino’ che tutto fosse totalmente buio, come fosse notte piena, senza luna, o lampioni.
L’orologio iniziò a segnare il tempo, all’indietro. Le pagine di un libro, si leggevano ad alta voce, da sole. Un piccolo aeroplano di legno, decollò da uno scaffale, ed iniziò a volare per la stanza, spargendo coriandoli. Un orso di peluche cominciò a scalare un armadio.
Il ragazzo cercò di fermare tutto. Voleva concentrarsi, su una piccola scatola che teneva nascosta sotto il letto, e nella quale teneva conservati alcuni suoi giocattoli di bambino.
E fu allora, che per la sua stanza, s’iniziarono a sentire le note di un valzer allegro.
Un soldatino di piombo, senza una gamba, ballava stretto ad una bellissima ballerina.
Più bella di un dipinto di Degas.
Il ragazzo, ad occhi chiusi, sapeva che non si sarebbero mai lasciati.
Nessun fuoco, nel buio della sua stanza, avrebbe mai potuto portarli via.
=======================================================================
Era un piccolo orecchino d’oro, a forma di cuore, e sporgeva leggermente dalla sabbia della spiaggia. Poteva affondare in qualsiasi momento, e perdersi, magari con un piccolo soffio di vento. L’uomo si abbassò, per raccoglierlo, e lo prese cautamente tra le dita. Lì intorno in spiaggia, non c’era nessuno; era primo pomeriggio, ed era davvero troppo caldo, per star fermi a prendere il sole.
L’uomo non avrebbe voluto portarlo via, da lì; forse qualcuno poteva venire a cercarlo.
Sedette, allora, in ombra, sotto un vicino sperone di tufo, sabbia cristallizzata dalla notte dei tempi, e decise di aspettare.
A sera ormai, una ragazza emerse dal mare. L’uomo s’era forse addormentato, qualche istante, e non s’era accorto che qualcuno nuotasse nei pressi.
La guardò.
Era una ragazza bellissima, dal seno pieno e le labbra di corallo. Indossava un costume intero, blu come il mare trasparente, che pareva esserle stato disegnato indosso.
La vedeva camminare cautamente, e cautamente smuovere la sabbia dinanzi ai suoi piedi, girando intorno.
S’avvicinò allora, e prima ancora di chiederle se cercasse qualcosa, vide che portava, ad un solo orecchio, un orecchino a forma di cuore.
Gli occhi di lei parevano respirare luce, mentre lo guardava; scuri e fondi come un mare tempestoso.
Cercava un orecchino, a forma di cuore, d’oro, che aveva perduto lì, la notte prima, quando era venuta a guardare la luna piena; una perla rubata al mare, e regalata al buio delle stelle.
L’uomo raccolse una conchiglia, e nel suo incavo, poggiò l’orecchino d’oro, e lo porse alla ragazza.
In silenzio, lei, lo rimise all’orecchio, e, sempre in silenzio, tornò ad immergersi in acqua.
L’uomo vedeva una leggera scia luminosa, solcare le onde, dritta verso l’orizzonte.
Finché scomparve, lontano.
=======================================================================
Nella sala d’aspetto dello studio medico, la bambina piangeva, e la madre non riusciva a farla smettere. Sembrava una sirena d’ambulanza nel traffico. Prima lontana, poi quasi silenziosa, ed infine vicinissima, lancinante.
L’uomo si portò allora davanti a lei, e la bimba, tirando su col naso, rimase, per un attimo sospesa, tra la curiosità, ed il bisogno di piangere ancora, con maggiore convinzione. L’uomo allora, con gesti ampi, per attirare l’attenzione della piccola, tirò fuori dalla sua borsa, un quaderno, dal quale strappò via un foglio e, dinanzi alla bambina che ora lo guardava attenta, iniziò a piegare il foglio, a seguirne le linee di piegatura, fino a tirar fuori dalle sue mani, un piccolo aeroplano di carta.
Iniziò allora a parlare alla bimba, e le raccontò che lui era un mago, e costruiva aerei di carta che volavano da soli, senza bisogno di motore; nessuno gli credeva, ma lui adesso, le avrebbe fatto vedere.
Il mago continuò a raccontare alla bambina, che ora aveva smesso di piangere, della sua magia e del segreto, della sua magia. Per poter volare da solo, il suo aeroplanino di carta, aveva bisogno di un particolare carburante; sulle ali, bisognava scrivere una parola bella, ed era quella parola, che avrebbe fatto volare l’aereo. E gli avrebbe tolto ogni paura di cadere.
L’uomo guardò la bambina, prese una penna, e scrisse una parola sulle ali dell’aereo.
Scrisse la parola “gioco”.
Poi, prese la bambina per mano, e la portò vicino ad una finestra, le chiese di soffiare sulla punta dell’aereo, e lo lanciò nell’aria vuota.
La bambina lo vide salire, in cielo, volando in cerchi concentrici sempre più ampi, sino a perdersi tra le nuvole, sino a sparire tra i raggi del sole. Allora la bambina sorrise all’uomo, e gli chiese di costruire un nuovo aereo. Di farla volare fino al mare lontano.
Anche l’uomo, sorrise, riportò la bambina dalla mamma e, mentre la bambina abbracciava la madre, d’improvviso, senza che nessuno se ne accorgesse, l’uomo scomparve.
Sulla sedia, accanto alla bambina, c’era un foglio di quaderno già piegato, pronto ad essere trasformato in aereo.
Ci voleva solo fantasia, e un gran desiderio di giocare ancora.
=======================================================================
Camminava curvo, con le mani in tasca. Le spalle leggermente ripiegate su sé stesse. E andava per la strada, contro il vento greco che spirava, portando con sé, l’aspro di sassaie lontane, spaccate dal sole, e da storie antiche.
L’uomo pensava ad una vecchia foto in bianco e nero, scattata quando lui aveva solo tre anni. Indossava, allora, una camicia bianca e un farfallino, e sorrideva, innocente, davanti ad una torta di compleanno con le candeline, pronte per essere soffiate da un desiderio .
E pensava alla propria espressione, se avesse potuto guardare il sé stesso di oggi, allora, quando era un bambino di un secolo trascorso.
Probabilmente non avrebbe capito, con chi aveva a che fare. Magari avrebbe pensato ad un parente lontano, che non conosceva, e che era arrivato fino a casa sua, per portargli un regalo.
E pensava anche, camminando più velocemente, nei momenti in cui il vento calmava brevemente il suo correre, che in realtà, era sempre andato avanti, senza sapere, cosa lo aspettasse. Solo cercando di non far mai male.
Quel bambino avrebbe visto un sé stesso sconfitto, senza essere mai stato vinto, ma senza grosse macchie addosso.
Allora, iniziò a camminare con la schiena più dritta, e le spalle aperte, e persino il caldo, pareva meno feroce.
Incrociò una giovane donna, sul suo cammino, e stupendo persino sé stesso, le si avvicinò un istante, e, scusandosi, le disse solo che era bello, vederla camminare, anche se lei, non sapeva nemmeno della sua esistenza.
Fece un piccolo inchino, con la testa, verso la donna, e andò via, senza dire altro, e senza voltarsi.
La donna sorrise, leggermente, senza essere sicura di non essere stata disturbata.
L’uomo, pensava solo che avrebbe voluto avere un fiore, da regalarle. Ma lui, in realtà, i fiori non li raccoglieva mai, e sapeva che neppure un piccolo fiore, avrebbe potuto porle tra le mani, anche se avrebbe voluto.
Anche se, per un solo istante, s’era sentito importante, a parlarle.
Immagino’ ora, mentre si allontanava, che quel bambino, felice di festeggiare il proprio compleanno, avesse alzato la torta, e gliela avesse tirata sul volto, ridendo del proprio sé stesso vecchio, come in una vecchia comica muta.
Come se, quel bambino, potesse ancora fare altre strade.
=======================================================================
Nelle orecchie, sentiva gran fragore.
Gli pareva d’esser vicino ad un motore che si sforzasse d’innalzare le ali, almeno poco sopra la cima di un monte coperto di boschi, per non precipitare, rovinosamente al suolo, e salvarlo invece.
Si sentiva protagonista d’un film d’avventure; in fuga precipitosa e malcerta dai cattivi, dotati certamente di mezzi tecnici superiori, ed inferociti dalla sua abilità a sgusciar loro sotto il naso, dopo aver scoperto la mappa d’ingresso alla grotta di Alì Babà.
Con lui era una splendida donna, che proteggeva, dalle mire schiavistiche del capo dei cattivi, e che si rivelava essere una ottima compagna di fuga, piena di risorse e trucchi e abilità segrete, oltre che, incredibilmente seducente.
Nel frastuono dei rami sfiorati e del motore urlante e delle lamiere ferite, avvertì un leggero odore di bruciato, come se qualcosa a lui vicina, ed assai preziosa, fosse stata colpita da proiettili incendiari, e stesse per precipitarlo in una definitiva caduta.
S’alzò di corsa dalla poltrona, dove stava leggiucchiando Facebook e s’accorse che la cappa della cucina, nonostante i fragorosi sforzi, non riusciva ad aspirare l’odore, ustionato, dei peperoni in padella che stava cuocendo.
Abbassò il fuoco, e aggiunse un po’ d’olio. Quando in cucina va male, bisogna sempre aggiungere un po’ d’olio, pensò con una punta di compiacimento.
La donna bellissima al suo fianco, lo guardava con un adorante commiserazione.
=======================================================================
Sentiva d’essere un ramo d’albero, dentro un fiume gonfio, dopo la pioggia.
Trasportato dai fanghi del fondale, che risalivano come un umore nebbioso e cattivo, e trascinato, da una riva all’altra, tra dolore e desiderio, dall’acqua che conosceva già, il suo fluire. Rinfrescato, rinfrancato dall’acqua nuova di cielo. Trascinato sul greto sassoso e affondato, senza respiro, dai mulinelli della corrente, che, veloce, voleva arrivare al mare e sperdersi.
Era stato strappato via da un vento tagliente, che, in un colpo solo, gli aveva portato via ogni spicchio di mondo che, intorno, conosceva, lasciandolo disarticolato, ferito, disorientato.
Solo.
Conservava però in sé un segreto.
Tra le sue foglie, un seme era venuto a maturazione.
E quel ramo d’albero, dalla corteccia che piangeva, poteva rinascere ancora, dentro una terra clemente.
=======================================================================
Camminava, per quella strada di periferia. Sul bordo delle rotaie.
Aveva intorno solo capannoni dismessi, che erano stati concessionarie d’auto o piccole fabbriche ormai chiuse. Sui marciapiedi, l’erba più tenace si scavava spazi e terra, tra bottiglie di plastica gettate via, e traini di camion, vuoti e arrugginiti, parcheggiati e dimenticati lì.
Il mattino era già alto e caldo, e piegava verso terra i rami degli alberi e dei cespugli, dietro cui erano sistemati vecchi materassi nudi e ingialliti e coperte incrostate di polvere.
Il rumore del traffico, pareva un vento lontano, intermittente e acre.
Lui cercava solo dei tratti di strada libera, dove respirare, prima d’andare a lavoro.
Da dietro una recinzione, con un balzo leggero, sbucò un gattino, macilento. La testa molto più grande del corpo affamato. I colori opachi. E dietro di lui, altri tre gattini, ciascuno di colore diverso, che sgambettavano agili, per provare a sé stessi d’essere vivi, e mostrare agli altri la propria forza consapevole.
Da ultima, uscì la madre. Anche lei piccola. Si muoveva lentamente, guardandosi tutto dintorno. I gattini, le si posero vicino, per sentirsi protetti.
La gatta si mosse verso di lui, e lui si sentì in colpa. Non aveva nulla, da dar loro, per consentirgli di mangiare. Soppesò mentalmente la possibilità di tornare a casa, e portar loro qualcosa, prima dell’inizio del suo orario di lavoro, e s’accorse che non sarebbe stato possibile trovare qualcosa da portare ai gatti, ed essere contemporaneamente puntuale nel suo ufficio.
Aveva con sé, in un piccolo zaino, solo una borraccia colma d’acqua.
S’avvicinò ai gatti, e si chinò verso terra. Aprì la sua borraccia, e lasciò scendere qualche goccia d’acqua sull’asfalto. I gatti, tutti insieme arrivarono verso di lui, con le code alzate.
E allora, lui fece scendere, lentamente, dalla sua borraccia, un rivolo d’acqua, al quale tutti i gatti s’appressavano per bere.
Mentre i gatti bevevano, sentì un rumore d’elicottero in cielo, ed alzò lo sguardo, vedendo in aria uno dei mezzi dei Vigili del Fuoco, impiegati per lo spegnimento d’incendi.
Quando tornò a volgere lo guardo verso i gatti, s’avvide, con terrore, che stavano bevando dalla sua borraccia, un leopardo femmina, e i suoi quattro cuccioli.
Gli parve di sentirsi addosso zanne e artigli, mentre s’alzava, e, lentamente voltava le spalle alle belve, dalle quali veniva un sordo rumore di gola, come un ruggito appena nato.
Ma, mentre camminava, le ferite non arrivavano.
Dimenticò lì, la borraccia.
=======================================================================
Era sul vagone della Metro, diretto al parcheggio dove aveva lasciato l’auto, prima di partire col treno, dalla stazione verso un’altra città.
Data l’ora, assai tarda, nel suo vagone c’era solo un’altra persona; una donna seduta lontano da lui, immersa nella lettura di un libro. Aveva la schiena poggiata lateralmente, sulla parete del vagone, e s’era portata le ginocchia quasi al petto, coi piedi poggiati sul sedile al suo fianco. Così rannicchiata, da lontano, gli diede l’impressione d’essere impegnata in una lettura dalla quale, quasi, dovesse difendersi.
Mentre il convoglio correva verso la fermata successiva, lasciandosi ai fianchi le pareti nere del tunnel, talora interrotte da veloci luci di posizione, gli sembrò che, proprio dalla parte dov’era seduta la donna, s’alzasse un fumo strano. Ebbe paura fosse un principio d’incendio. Ma poi, guardando meglio, ebbe l’impressione che, dalle pagine del libro, prendesse vita nell’aria una terribile bestia alata, dal muso di serpente e il corpo di leone.
Si ritrovò, in un istante, in piedi. Tra le braccia aveva un grosso scudo metallico, tondo, e una lunga lancia dalla punta di aguzzo bronzo. Le pareti del vagone parevano essersi dilatate e la lotta col mostro si svolgeva in un grande cortile, che a lui sembrava essere circondato da mura e torri di un castello.
Più volte, l’animale, volandogli intorno, provo’ ad azzannarlo. Ma l’uomo si difese, col suo scudo, ed infine affondò la sua lancia, direttamente nella bocca del terribile avversario, spingendola sempre più entro il suo corpo, fin quando la belva, non smise di dibattersi e gorgogliare, chiudendo gli occhi, vinta.
L’uomo cercò di vedere se la donna fosse ancora viva, e la vide, in piedi, regalmente vestita, e sorrise allora, pensando d’aver salvato una regina. Nel vagone, era rimasto a galleggiare il fumo, e l’uomo sentì lacrimare i propri occhi, che chiuse, un istante, per calmare il dolore.
Si sentì scuotere, d’improvviso; una donna, quella che stava leggendo il libro, gli teneva una mano sulla spalla, e lo guardava con espressione preoccupata. Gli chiese se si sentisse bene. La Metro era arrivata alla fermata di capolinea, e lui doveva essersi addormentato.
La donna si offrì di accompagnarlo, con la propria auto.
Lui, leggermente intontito e disorientato, accettò l’offerta.
Sotto uno dei sedili del vagone, mentre andava via, per un momento, prima che le porte automatiche si chiudessero, gli parve di scorgere una punta di lancia, sporca forse di sangue velenoso.
=======================================================================
Sulla terrazza del palazzo, erano stese, ad asciugare, le lenzuola bianche, quelle dei letti grandi.
Profumavano, di sapone per bucato, ed erano state lavate a mano, nei lavatoi dell’ultimo piano, dentro i lavandini di pietra nera, sfregandoli sulle assi di legno scanalate.
Col caldo del vento estivo, erano già quasi del tutto asciutte.
Il ragazzo era poggiato al parapetto del terrazzo, dando la schiena al vuoto sotto, e guardava le lunzuola muoversi leggermente, come un sipario che tremi dalla voglia di aprirsi . Pensava a quando la madre gli avrebbe chiesto di aiutarla a piegarli, una volta asciutti. Anche se avrebbero dovuto essere ancora stirati, una buona piegatura, avrebbe aiutato, ad appiattire tutte le piccole grinze provocate dalla torcitura del cotone, per far uscire l’acqua di lavaggio; e a lui piaceva, riunire tra loro i capi del lenzuolo, farli combaciare perfettamente. Quasi fosse un foglio di quaderno, col quale realizzare una barchetta.
Il sole era alto, e caldo e, in controluce, gli sembrava d’aver visto qualcuno arrivare in terrazza, e passare dietro i panni stesi, restando però , sostanzialmente, invisibile. Sembrava essere arrivata anche una musica, veloce, ritmica.
Si avvicinò alle lenzuola, ne scostò una leggermente, restando però coperto, e vide una ragazza che aveva portato con sé una radiolina a pile, e ballava, ascoltando la sua musica. Forse convinta che nessuno la stesse guardando.
Lui restò incantato dalle sue gambe perfettamente a loro agio nel seguire, a tempo, la musica, e lei gli parve più bella, e brava, delle ballerine che, il sabato sera si vedevano in televisione.
Non avrebbe mai creduto, che quella ragazza, che conosceva velocissima ad arrampicarsi sugli alberi, fosse stata così aerea, ballando.
Sentì di non essere stato invitato, a quella festa, che era solo della ragazza, e cercò d’andare via, senza essere visto.
Senza essere visto col volto arrossato dalla timidezza.
Mentre stava per uscire dal terrazzo, ed infilare il ballatoio che portava alle scale, sentiva ancora, la musica lontana, muoversi divertita, senza di lui.
In verità, gli parve di sentire anche la ragazza che lo salutava.
=======================================================================
L’ospedale era ancora in silenzio.
In cielo, le strisce rosa delle dita d’alba, brillavano, sotto la luce di uno spicchio di luna appeso al soffitto del mondo.
Lui camminava per i corridoi esterni, ascoltando il girare lontano di un carrello.
Faceva fresco, nonostante le infinite giornate di deserto trascorse.
Non ricordava neppure per quale motivo si trovasse lì. Aveva trascorso la notte senza dormire; sognando però.
Aveva sognato d’essere in montagna, seduto sotto una grande quercia, dai rami aperti, carichi di foglie verdi e muschio secco, e, dall’erba alta a lui di fronte, usciva una piccola volpe rossa, che lo guardava, curiosa, e diffidente. S’era fermata proprio dinanzi a lui, col muso ostentatamente rivolto altrove, ma le orecchie aperte nella sua direzione. E, nel sogno, lui le parlava, e sentiva la propria voce, carica di emozione e sincerità, invitarla ad avvicinarsi. Avrebbe voluto accarezzarla, farle sentire che mai, le avrebbe fatto del male.
Il sogno era diventato pieno di luce, che aveva trasformato tutto, in una bolla dorata e calda, abbagliante come un’acqua colma di sole. E in questa luce accecante, gli parve di veder alzarsi un’ombra, dal luogo dov’era la volpe, e venirgli incontro.
Era una donna, in realtà, bellissima, e lui le tese le mani, per prendere le sue, mentre si sentiva addosso la felicità d’essere riuscito a comunicare alla volpe, il proprio desiderio di rompere la distanza.
Il sogno poi, s’era spento, affondando in quella luce azzurra, e calda, e liquida.
E ora, si ritrovava a camminare tra i cantieri dei lavori in corso e le auto ferme.
S’accorse del ronzio dei condizionatori d’aria e, mentre cercava di ricostruire, nella sua mente, perché fosse arrivato sin lì, nei cespi di erba secca e spine che crescevano liberi al fianco di un parcheggio, gli parve di scorgere una volpe, che lo guardava, senza andar via.
=======================================================================
Il bambino era sulla spiaggia, seduto appena un metro oltre il segno lasciato dal mare, calmissimo, quando si ritirava dopo una dolcissima onda, ed era circondato da piccoli rastrelli di plastica, palette, due o tre secchielli di diverse misure, ma dello stesso colore.
Aveva le mani piene di sabbia, e le usava per scavare, lentamente, mentre con gli occhi guardava il mare e, ogni tanto, cercava la madre, seduta poco distante da lui. Il bimbo sentiva i propri occhi illuminarsi, quando incontravano quelli di lei, e l’avrebbe voluta vicino a sé. Solo vicino a sé, perché solo così, si sentiva davvero protetto e non avvertiva, da qualche parte dentro, lo smarrimento del brevissimo vuoto intorno.
Il bambino aveva la testa coperta da un cappellino celeste, con una visiera di cotone bianco e sorrideva.
Era libero di scegliere quale oggetto prendere, e quale gioco inventare, e, anche se sentiva di non dover oltrepassare di molto il luogo dove era stato portato, non immaginava un limite, al proprio desiderio.
Un secchiello di sabbia rovesciata, era un castello dove viveva una principessa di cui aveva sentito parlare. Un altro, un monte da scalare per arrivare a correre, da lì, fin sulle nuvole. La paletta scavava profondi pozzi d’acqua fresca da bere. Il rastrello, disegnava zebre libere sulla spiaggia.
La mamma si alzò, ed andò verso il bambino, che s’aspettava d’essere abbracciato. La donna, invece, si fermò poco distante da lui, ed iniziò, con le mani, a tracciare un piccolo solco tutto intorno a lui. E poi iniziò a scavare, lungo quel solco, e poi, con uno dei suoi secchielli, numerose volte, prese acqua di mare, e l’impasto’ con la sabbia, costruendo forme e tavole cui, il bambino, non riusciva a dare un nome, mentre restava fermo a guardarla, incantato, come se fosse stato dinanzi ad un prodigio, che si sentiva addosso, quanto fosse grande, ma la cui natura restava misteriosa, in attesa di una rivelazione.
Fin quando, la mamma, scavalcò quello che pareva essere un basso muro leggermente arcuato; appuntito davanti, ed arrotondato dietro, e andò a sedere proprio al fianco del bambino, che prese in braccio e posò sulle proprie gambe.
Adesso, la mamma e il bimbo erano pronti ad andare insieme per mare, con la loro barca, e la mamma raccontava al figlio, la storia di una spiaggia nascosta, dove viveva una maga, capace di trasformare, per un tempo anche lungo, gli uomini, e le donne che vi arrivavano, in uccelli, perché imparassero a vedere dall’alto, il mondo in cui vivevano; per amarlo di più, per imparare che, dalla nostra altezza, vediamo poche cose, ma se proviamo ad alzarci, il mondo si allarga, e ci rivela bellezze che non pensavamo di incontrare.
Il bambino sentiva il mare accarezzare i fianchi della sua barca, ascoltava la mamma, e chiudeva gli occhi, per volare vicino alle sue ali.
=======================================================================
Erano da poco passate le quattro del mattino. S’era vestito, indossando un paio di pantaloncini corti, scarpe da ginnastica e una maglietta di cotone a maniche lunghe, unica concessione al leggero fresco ancora notturno.
Cantava una vecchia canzone, sottovoce, mentre camminava per i vicoli spenti della città, e immaginava di non essere solo.
Era diretto verso la fontana della piazza grande.
Arrivato sul bordo della vasca, prese, dalla tasca dei pantaloncini, il suo taccuino.
Lo aveva interamente usato per scrivere una lettera. Una lettera innamorata.
Pazientemente, del proprio taccuino, strappò ogni pagina, e di ogni pagina fece una barchetta, che posò a navigare nell’acqua della fontana.
Presto, decine, e decine di barche piene d’amore, navigavano nell’acqua della fontana.
E prima che il cielo iniziasse a diventare celeste, lui andò via; sapeva che, presto, i fogli si sarebbero sciolti, e l’inchiostro dilavato. Ma sapeva anche che, per alcuni istanti, la vasca della fontana era diventata un mare colmo del suo amore e, da qualche parte, le sue parole, con l’acqua, sarebbero diventate nuvole, e anche il cielo, si sarebbe riempito d’amore e, con un po’ di fortuna, avrebbe piovuto e sarebbe tornato a terra, l’amore.
E l’erba, forse, sarebbe fiorita, d’amore.
=======================================================================
Aveva un cappello in testa.
Uno di quei vecchi cappelli in feltro, grigio, con un nastro nero, dal quale si dipartiva un’ampia falda.
Quando iniziò a piovere, l’uomo tolse il cappello dalla testa, e lo aprì all’acqua, che provò a raccogliere nella cupola.
Chi lo guardava, dall’altro lato della strada, o da dietro alle finestre, aveva quasi l’impressione che stesse chiedendo elemosina al cielo.
E il cielo iniziò a piovere forte, e il cappello dell’uomo, rapidamente, si colmava d’acqua, mentre il cielo tuonava, e sembrava spostare le cime degli alberi.
Quando il cappello gli parve sufficientemente pieno d’acqua, l’uomo, se lo rovesciò in testa, rigandosi tutto il volto, e il collo, e la camicia che indossava, di pioggia fredda. E ripeté questo stesso gesto, altre due, o tre volte, inzuppandosi tutto.
Chi lo guardasse dall’altro marciapiede della strada, o da dietro le vetrine dei negozi, avrebbe potuto pensare che l’uomo stesse compiendo una serie di gesti inconsulti, da persona che avesse perso la propria mente.
Quell’uomo immaginava, che le nuvole, gonfie di pioggia, avessero raccolto acqua dall’altra parte del mare, e l’avessero portata sin lì, per farla piovere sulla terra assetata, e su di lui, solo, da quando la donna che amava, era andata dall’altra parte del mare.
Forse quell’acqua raccolta dalle nuvole, col suo cappello, era acqua del mare dove lei aveva nuotato, o magari era l’acqua di una fontana dove lei si era specchiata.
E l’uomo, voleva solo bagnarsi di lei.
=======================================================================
Collezionava monete.
Ma non monete antiche, o rare. Si limitava a cercare le monete dei vari stati dell’Unione Europea che avevano aderito all’euro.
Le cercava nei resti di spesa, o nelle monete che gli davano al bar, quando prendeva un caffè.
Sapeva che erano 20, gli Stati europei che avevano scelto l’euro, e sapeva che, la somma delle monete di metallo, diverse, nei vari tagli previsti, era pari a circa 3,80 euro, complessivamente.
Per questo si era preparato bene, per l’estate. Aveva raccolto tutte le monete, di ciascuno dei Paesi, e ora le conservava tutte dentro una scatola di metallo, divise tra loro. Ogni Stato, aveva il suo mucchietto di monete ben impilato.
Partì, la mattina.
E traversò l’Europa, con la sua auto, per ciascuno dei 20 Stati.
In ogni Stato dove arrivava, prendeva il corrispondente mucchietto di monete, e andava in un negozio di fiori. E in ciascuno dei 20 negozi di fiori, scelse il fiore più bello, più colorato, e più profumato, che riusciva a trovare. Ogni fiore, poteva costare al massimo 3,80 euro.
E ciascuno dei 20 fiori, venne riposto tra le pagine di un taccuino. Uno di quei taccuini che, sulla copertina, hanno un piccolo laccio che chiudeva stretto il piccolo quaderno. In quel taccuino, ad ogni pagina, scriveva le note del suo viaggio e perché aveva scelto quel particolare fiore e quanto, di quel fiore gli parlasse di lei.
E quanto la amava, anche quando era lontano.
Tornò in Italia, dopo circa un mese.
Ora, gli restava solo di trovare il coraggio di consegnarlo alla donna cui pensava sempre.
=======================================================================
Camminava, per la campagna appena arata; davanti a sé, una bassa collina brulla, arsa di stoppie e pietre scaldate dal sole.
Sudava, ma decise lo stesso, d’inerpicarsi. Voleva vedere cosa ci fosse, oltre quell’orizzonte. Si sentiva come se fosse convalescente, e volesse provare a sé stesso, di star bene.
Percorse la collina zigzagando, senza salire dritto, ma seguendo certi piccolissimi sentieri, appena accennati nell’erba alta, e rincorrendo i propri pensieri, che cercavano forza in ogni passo.
Arrivò finalmente sul crinale, e sotto di lui, la collina scendeva dolcemente, verso un’ampia pianura, coltivata, in parte, e abitata anche: scorgeva piccole casette di legno, in coppia, dai tetti spioventi.
Lungo tutta la pianura, giganteschi angeli, dalle ali spiegate, sembravano vegliare sulla quiete del luogo.
Quasi non credeva ai suoi occhi.
Era come se avesse aperto una porta nascosta, che gli stava permettendo di guardare un cielo segreto.
Si guardò indietro, verso la strada appena percorsa, e tutto gli appariva consueto.
Le rocce, i piccoli cespugli, quasi tutti sfioriti; davanti a lui, invece, un mondo azzurro, di esseri inattesi, che muovevano lentamente le loro infinite ali, come se stessero preparandosi a volare.
Sedette un istante, in terra, chiudendo gli occhi, come se volesse capire se si trattasse di un sogno, o se tutto fosse vero.
Quando li riaprì, avvertì, innanzitutto, uno strano ronzio, e poi guardò, finalmente, raccogliendo il proprio coraggio, verso gli angeli.
Le altissime pale eoliche, si muovevano piano, catturando ogni piccolo refolo di scirocco caldo, e accumulando così energia.
Ma,vicino a lui, una donna stupenda, aveva aperto le sue ali, di piume bianche, e stava per alzarsi da terra.
E lui, come se quell’angelo stesse portando via con sé ogni suo respiro, s’alzò velocemente da terra, ed iniziò a correre verso di lei, lui.
Voleva che restasse a terra, urlava d’essere stato a lui, lei, affidato, e non poteva restare solo, sulla terra.
Mai più.
=====================================================================
Il sole era ancora alto, sull’orizzonte.
Ma già proiettava sul mare, e fino agli scogli di riva, un torrente di luce dorata, che si rifletteva sull’acqua, riempiendo l’aria di scintille infuocate.
Un uomo era seduto, da solo, su un asciugamano blu, e guardava le onde rincorrersi, sotto un debole vento di ponente, mentre il cielo iniziava a scurirsi.
Faceva caldo, dopo una intera giornata di sole che aveva arroventato le pietre.
Lentamente, l’uomo si alzò, dirigendosi, con difficoltà, al mare, dove entrò, bagnandosi sino alle ginocchia. Cercava di scorgere il proprio volto sulla superficie dell’acqua, uno specchio però, troppo mobile e scuro, per potersi ritrovare davvero. Solo ogni tanto, magari in un istante di risacca, l’uomo individuava la propria bocca, o gli occhi.
Non c’era nessuno intorno a lui, e allora, l’uomo, iniziò a parlare, ad alta voce.
Raccontò al mare di essere diventato invisibile.
Raccontò d’essersi accorto di questo mutamento, quando iniziò ad accadergli, e sempre più spesso accadeva, che le sue domande restassero senza risposta. Quando si accorse che le persone che parlavano con lui, ad un certo punto, iniziavano a scuotere la testa, come se rifiutassero la sua presenza, e portavano gli occhi lontano da lui.
E diventò una certezza, quando il suo telefono iniziò a squillare sempre meno, fino a restare sempre muto.
Nessuno gli scriveva più lettere, ed il postino sembrava aver dimenticato il suo indirizzo.
Pensò per un attimo di buttarsi in acqua, e congiungersi almeno con quella persona che vibrava tra le onde, davanti a lui .
Andò a posarsi al suo fianco un gabbiano. Grande, grigio e bianco; nere le punte delle ali . L’uccello lo guardava. Forse senza vederlo, visto che la vicinanza con un umano non lo infastidiva più di tanto
Apparentemente, almeno .
L’uomo uscì dall’acqua. Nella sua borsa, portava un pane; ne prese un pezzo, e lo gettò vicino al gabbiano che, sentendo il lievissimo urto del cibo sullo scoglio, si voltò e, raccolto il pane col becco, volò subito via. Senza mai cercare, con lo sguardo, l’origine di quel rumore.
L’uomo pensò d’essere davvero divenuto invisibile, o forse d’essere prigioniero di un sogno.
Si buttò in acqua. Voleva arrivare sino alla linea scura che non divideva il mare dal cielo.
==============================================================
Era una piccola finestrella alta, chiusa all’esterno, da una maglia di ferro intrecciata, a rombi e nodi. E separava la soffitta, dal tetto a terrazza, affacciandosi parzialmente sul paese che, da lì, pareva una ordinata distesa di dadi bianchi e ocra, che guidavano la vista sino al mare, appena oltre la ferrovia.
Entro la stanza, su vecchie reti metalliche, infossate al centro, c’erano due lettini singoli, addossati alle pareti. I materassi erano pieni di paglia secca, e capitava, che qualche sterpo dritto e duro, bucasse le federe, arrivando a ferire la pelle di chi si fosse steso.
Quella stanzetta era il rifugio del ragazzo, negli infiniti pomeriggi d’estate. Ci passava il tempo a leggere, e, certe volte, a lottare col suo cugino più grande.
Portavano entrambe lo stesso nome, e la loro lotta, una impari sfida a chi fosse più forte, finiva solo quando uno dei due immobilizzava l’altro.
Certe volte, il più grande lasciava vincere il ragazzo, che, così, credeva d’esser capace, di difendersi, e non si sentiva sempre umiliato dall’impossibilità.
Il ragazzo però, con una scusa sempre nuova, usata per mandar via chiunque fosse con lui, riusciva, quasi sempre, a restar solo, al tramonto, dentro quella soffitta.
Al tramonto, dalle maglie di ferro della finestra, entrava una immensa bolla di luce rosa, e rossa, e oro e grigia, e blu, e, se c’era qualche nuvola, pareva che, nella stanza, entrasse il vapore del cielo, e proiettasse, sulle pareti, ombre strane, come le foto di un fotoromanzo in bianco e nero, dove gli uomini baciavano le donne, che li abbracciavano.
Una sera, il ragazzo era stanchissimo, perché aveva passato buona parte della giornata in barca, a pescare col nonno, dopo essersi svegliato molto presto al mattino, ed era riuscito ad arrivare nella stanzetta, da solo, proprio qualche istante prima, del tramonto.
Il sole stava andando a dormire, e dentro la soffitta, entrava una nebbia dorata, che pareva ondeggiare, sotto un debole filo di vento greco.
Quella nebbia, disegnava nell’aria una donna che indossava un grande cappello, ed aveva un collo leggermente più lungo del consueto, che, al ragazzo, pareva assai elegante. La bocca, piena, mostrava un’espressione sorpresa, e, leggermente malinconica.
Gli occhi della donna, si perdevano oltre ogni parete.
Il ragazzo, quasi istintivamente, allungò il braccio per sfiorarle il volto, proprio mentre quella nebbia si scioglieva in infinite scintille galleggianti. Come un gesto di diniego della mano.
Il ragazzo si sentì ferito.
Era come se la sera, fosse venuta a rubargli, per sempre, il segreto delle ombre dei suoi sogni, disegnati sul muro al tramonto.
Forse, diventar grandi, era sapere che la propria fantasia spariva, col buio, lasciandolo solo.
Forse invece, per diventare davvero grande, pensò il ragazzo, e battere suo cugino, e poter sfiorare il volto di una donna, era necessario volerlo davvero, talmente tanto forte, da scacciare via il buio.
Sempre.
==============================================================
Avrebbe dovuto sentir tenerezza, per sé, per le persone che aveva intorno.
Per il tempo pesante trascorso.
Avrebbe dovuto prendere tutte le parole lasciate in sospeso, e trasformarle in mazzi di fiori cresciuti selvaggi al bordo delle strade che non era riuscito a percorrere.
E avrebbe dovuto indagare, negli occhi di chi incontrava, se qualcuno avesse potuto riconoscerlo, e raccontargli tutto quello che, senza di lui, era accaduto.
Avrebbe dovuto anche darsi una misura, e sentirsi addosso tutto quello che aveva vissuto, e che lo aveva deluso, e vuoto, lasciato.
Non riusciva a contare, tutto quello che avrebbe dovuto. E nemmeno tutto quello che non avrebbe dovuto.
Figuriamoci tutto quel che avrebbe voluto, e non era.
La luna di ponente, uno spicchio di luce timida, era poggiata sulle statue della facciata della chiesa conventuale, e ombreggiava le colonne scanalate, dandogli corpo celeste.
Quella luna che ancora custodiva il suo senno perduto di studente innamorato.
In un angolo di campagna, circondata dai muretti a secco e da alberi di fico odorosi di latte, accese un piccolo fuoco, che svelava tutto il buio intorno. E quando il fuoco iniziò a brillare libero, ci mise dentro il quaderno dove scriveva i suoi pensieri, ogni giorno.
Non voleva portare nulla di sé, dove avrebbe voluto andare.
Dove avrebbe iniziato ad andare, da subito. Appena spento il fuoco che anneriva le pietre.
Il mare di libeccio riempiva d’onde gli scogli, immergendoli di schiuma, e restò ad aspettare l’alba.
L’alba di un giorno nuovo, da sentire profondo dentro di sé, dentro la propria solitudine mai arresa.
Guardava dentro il cielo azzurro ora. Da qualche parte, affacciato in alto, doveva esserci qualcuno che guardava a lui, e si rannicchiò su sé stesso. Poteva dormire anche di giorno, cambiando abitudini e attese. Poteva dormire per sempre.
Fino a domani.
Senza più tenerezza. Senza più illusioni.
Ballando, sul vento, senza paura.
==============================================================
S’era fermato in un angolo di sterrato, accanto alla strada di lungomare, ed era sceso dall’auto.
Era ora di tramonto e la linea dell’orizzonte era ancora incendiata di sole arancio, mentre il mare già scivolava nella notte.
Conosceva bene quegli scogli.
Tanto tempo prima, era stato lì, con la donna che lo aveva vinto, innamorandolo fino a fargli sentire inutile, respirare senza sentire il suo profumo.
Da lontano arrivavano le musiche dei bar, e del passeggio delle persone in vacanza.
Scese, verso il mare, camminando sulle rocce appuntite dal vento, e si fermò quando il rumore dell’acqua finì col sovrastare ogni altro suono del mondo.
Era solo, adesso, come un pensiero sperso e inutile, e mise le mani in tasca, stringendo tra le dita, le chiavi dell’auto, quasi avesse paura di perderle.
Avrebbe voluto conoscere una qualche magia, perché lei arrivasse, lì dov’era lui, traversando strade e monti, e lo portasse fino al cielo alto, dove vedeva tremare le prime stelle. Immaginava che sarebbe comparsa, in silenzio, dietro di lui, e immaginava che lo avrebbe abbracciato, da dietro, e ne sentiva il volto poggiato sulle proprie spalle, e il profumo di quella giunchiglia che avevano visto insieme, un giorno, cresciuta dentro la città, e che sembrava una nuvola bianca dal cui centro si levava un bacio giallo.
Ma non conosceva nessuna magia. Solo il silenzio di quella sera affollata, lontano da lui.
S’accorse che aveva chiuso gli occhi.
E quando lì riaprì, sentì una leggera vertigine, e gli parve di scorgere un’ombra che si muoveva, sulla cima di una antica torre di avvistamento dei pirati saraceni.
Si sentì alzato da terra, volare verso il promontorio sulle cui pietre la torre era abbarbicata.
Era una donna, quell’ombra, sulla cima della torre. Vestita di veli bianchi, e prigioniera forse.
Caddero stelle dal cielo.
Allora l’uomo espresse il desiderio di veder libera, quella donna, da ogni prigione le fosse stata costruita intorno.
Dal mare, s’alzò un vapore di fiori bianchi e gialli, che lui respirava piangendo.
Tirò fuori dalla tasca le chiavi dell’auto, e, senza pensarci un momento, le scagliò lontano, in acqua.
Non voleva più andar via di lì. Fin quando lei non fosse andata a riprenderlo.
Gli parve allora, che dal mare, cadessero stelle in cielo.
==============================================================
Aveva deciso di porre i dolci, appena presi in pasticceria, nella propria auto, sul sedile posteriore, e non nel portabagagli.
Doveva viaggiare per centinaia di chilometri, e gli sembrava più prudente tenere quei dolci alla crema in un ambiente rinfrescato dall’aria condizionata, piuttosto che nel portabagagli, dove, col caldo di agosto, avrebbero potuto guastarsi.
Guidava la sua auto, mentre nell’abitacolo si diffondeva odore di vaniglia e mandorle. Odore di cioccolata e amarene.
Gli tornava in mente, allora, quando era poco più che un bambino e andava a piedi a scuola. Alle scuole medie inferiori. E la sua strada, da casa a scuola, passava sempre a fianco di quella pasticceria.
Quasi mai, aveva a disposizione il denaro necessario per comprare un cornetto alla crema, da mangiare durante l’orario di ricreazione. Ma gli bastava il profumo caldo, e dolce, che sentiva passandoci accanto, per mettergli allegria. E, per merenda, era buono anche il pane col pomodoro che gli preparava la madre.
Ora, nell’auto, quell’odore di forno e zucchero, riportava alla memoria quello dei quaderni e delle gomme per cancellare. L’odore aspro della palestra della scuola, dove si disputava il torneo di pallavolo, che lui, con la sua classe, aveva perduto sempre in finale, per tre anni di seguito.
Certe volte, aveva provato ad offrire una pastarella, da mangiare a metà, ad una sua compagna di classe, che aveva i capelli corti e i brufoli. Ma lei non aveva mai accettato.
In auto, l’odore di crema cotta, allora, gli pungeva ancora il cuore, come una mattina buia, senza una mano da cercare, per stringerla, nel letto.
Il viaggio si stava riempiendo, di tutte le possibilità che non avevano avuto modo di divenire reali; di tutte le strade che non aveva imboccato, scegliendo come aveva scelto, ad un bivio. E non s’accorgeva, dei chilometri che scorrevano, veloci.
Fuori dal finestrino le cime degli alberi si piegavano leggermente col vento, e lui pensò che non voleva più correre dietro ai ricordi.
Arrivato in città, prese una strada di periferia. Cercava un muro nascosto, sul margine di una campagna incolta e abbandonata. Lì, un uomo e una donna, avevano scritto sulle pietre i nomi l’uno dell’altra.
Ai piedi di quel muro, avvolto in un tovagliolino di carta bianca, posò uno dei dolci che aveva comprato. Quello che s’era fatto incartare a parte, in un sacchetto.
Forse le sarebbe piaciuto ancora, quel sapore mischiato e antico, di crema e cioccolata morbida; forse ci avrebbe fatto colazione, e poi lo avrebbe baciato, aprendo la porta di un giorno nuovo.
===============================================================
Aveva iniziato a piovere.
Dapprima gocce leggere, e la sensazione che cadessero su lastre arroventate, che trasformavano l’acqua, immediatamente, in vapore caldo, che restava a galleggiare e, a respirarlo, faceva sentire ancor più caldo. Poi, la pioggia, era diventata più fitta, e forte, e sollevava una polvere sottile, dalla campagna arsa, che si posava, come una cipria, sulla pelle, lasciando macchie di terra rossa sulle braccia.
L’uomo aveva con sé un ombrello, che aveva aperto, riparandosi.
Gli piaceva, la pioggia.
Era una bella occasione per urlare, senz’essere sentito, tutte le sue favole sbagliate e ubriache, dagli angoli delle strade, mentre le auto, correndo, gli schizzavano addosso acqua nera, e sapore d’asfalto. Nessuno si sarebbe accorto, delle sue parole, impegnati com’erano, tutti, a ripararsi dal cielo.
E quel giorno pioveva, pioveva davvero, come se le nuvole si fossero d’improvviso ricordate, come si pioveva; come se la pioggia, avesse deciso di mettere tutti gli innamorati sotto le coperte a guardare le finestre rigarsi d’acqua, e a baciarsi, per ogni goccia che scivolava via dal vetro; come se tuoni e fulmini avessero deciso di scuotere tutti i fiori e spargere ovunque il loro profumo colorato, perché tutti s’accorgessero di quanto facesse schifo l’odore di diesel.
Allora, l’uomo, sedette su una panchina di legno, nel parco, e, invece di tenere l’ombrello ritto sulla propria testa, per proteggersi, lo orientò per prendere il vento, e correrci insieme.
La panchina di staccò da terra, ed iniziò a volare, come una barca dalla vela latina, e, uscito dalla città, mentre la pioggia aumentava ancora di ritmo, l’uomo arrivò fino ad una spiaggia lontana.
Una donna passeggiava sul bordo del mare.
L’uomo la invitò a salire sulla sua panchina a vela, e il vento li portò via insieme.
Oltre le nuvole e gli alberi. Ad aspettare che si accendessero le stelle, abbracciati, sotto l’ombrello, a respirare il vapore delle loro labbra.
Certe volte, la pioggia, cambia il modo in cui la Terra gira.
===============================================================
Era entrato alla scuola estiva, deciso a non parlare. A non dire nulla, alla bambina sua amica, e a tutti gli altri bambini.
Il giorno prima, la maestra aveva fatto fare a tutti, un gioco con la palla. A turno, ogni bimbo, e ogni bimba, doveva lanciare, girato o girata di spalle, un pallone verso tutti gli altri bimbi radunati insieme. Il pallone, avrebbe dovuto essere preso al volo, senza farlo cadere in terra. Chi lo avesse lasciato sfuggire dalle mani, sarebbe stato eliminato. L’ultimo, o l’ultima, a restare, senza aver mai fatto cadere la palla, avrebbe vinto.
Tutti avevano giocato, felici, tranne lui, che era stato dimenticato in un angolo, e nessuno lo aveva cercato.
Neanche la bimba sua amica.
Per questo il bimbo, quel mattino, era entrato in classe, senza dire una parola e, senza dire una parola, s’era rimesso nel suo cantuccio.
Giocava da solo, ma, mentre il tempo scorreva, non smetteva un istante, di guardarsi intorno, cercando qualche segnale di attenzione da parte degli altri; non smetteva un istante di ascoltare, sperando di cogliere qualche parola che lo riguardasse, soprattutto se pronunciata dalla bambina sua amica.
Ma nessun gesto, o frase, si avvicinava a lui, che restava in silenzio, in disparte.
Quando arrivò l’ora della merenda, tutti i bimbi, sorridenti e vocianti, aprivano, sui banchi tutti uniti al centro dell’aula, i loro zaini, e tiravano fuori i piccoli dolci, e le bibite, che i loro genitori gli avevano preparato.
Lui, aveva deciso di restare in un angolo, a digiuno.
Fin quando la bimba sua amica si avvicinò a lui, porgendogli un cioccolatino.
Il bambino restò in silenzio. Indeciso, se rifiutare, o accettare.
Poi, le sorrise, la ringraziò per l’attenzione. E si scuso’ con lei, perché aveva perso un intero giorno di giochi insieme, solo perché non si era sentito importante.
Avrebbe voluto dirle tutt’altro. Avrebbe voluto raccontarle il suo dolore e la sua rabbia di escluso.
Ma, mentre le parlava, sentiva che era proprio vero. Non avrebbe voluto perdere neanche un altro giorno di giochi insieme.
E questa, era l’unica cosa importante.
Il cioccolatino però, non lo mangiò.
Sentiva di non meritarlo.
===============================================================
Erano arrivate folate di vento forte, caldo, che agitavano i pensieri e facevano venir voglia di proteggersi.
In fondo, proteggersi, pensava il ragazzo, era del tutto inutile. Sembrava che non ci fosse nulla, in realtà, da cui proteggersi. Quando il vento faceva una pausa, tornava ad essere un normale pomeriggio d’agosto, appiccicoso, e vagamente stancante.
Come essere obbligati a stare in spiaggia, mentre tutti si divertono, e si resti invece soli, a combattere coi propri pensieri.
Il vento, comunque, aveva suggerito al ragazzo, e alla ragazza che era con lui, di andarsi a sedere entro il gran porticato della casa, in un punto dove non arrivasse l’aria veloce che stava agitando i rami, di tutti gli alberi intorno.
Sul tavolo, ove erano seduti a parlare, c’era poggiata una scatola del gioco “Scarabeo”.
Lei propose di fare una partita.
Era molto più brava di lui, a trovare parole difficili e capaci di ottenere punteggi alti.
Lui, s’era perso ad ascoltarla parlare, come se fosse davanti ad una apparizione notturna, la cui voce lo guidava per boschi e torrenti, portandolo dentro mondi che gli davano le vertigini, per la loro purezza tagliente, cui poteva solo abbandonarsi.
Stava nettamente perdendo.
Gli restavano cinque lettere, con le quali comporre un’ultima parola. Prima che la sconfitta fosse matematicamente certa.
Tiamo.
Scrisse, e la guardò negli occhi.
==============================================================
Quasi l’intera notte al Pronto Soccorso, aveva passato, in attesa del suo turno ad essere visitato.
E quando ne era uscito, aveva sentito l’aria libera, e calda, che trasudava dalla terra, del mattino che ancora non era pronto.
Aveva ripreso la propria auto e, invece di dirigersi verso casa, aveva preso la strada della Grande Montagna.
Aveva incontrato un’istrice, mentre saliva. Aveva visto i suoi aculei ondeggiare, mentre gli traversava la strada, ed andava a perdersi poi in una macchia d’arbusti alla sua destra. S’era chiesto, un po’ stupidamente, come poteva fare l’amore, un’istrice; quanto avrebbe straziato, con le sue spine, il suo amante.
Sulla grande piana, il cielo iniziava ad inzuccherarsi. Da dietro l’ombra alta delle rocce, sorgeva un lampo rosso, che s’aranciava, salendo verso il cielo, e s’imbluiva, poi, immergendosi nella notte di stelle che si stavano nascondendo.
Pareva il sangue scosso, uscito dalla ferita irrimarginabile della sua paura, e accendeva il buio, che si stava mutando in celeste cupo, traversato a tratti, dal volo dei primi uccelli insonni, assetati di sole.
Lui si sentiva svuotato, quasi assente a sé stesso, però leggero, nonostante l’ansia non l’avesse abbandonato. Cercava di sentirsi il correre delle vene, stupendosi di continuare a non sentirsi soffocare, anche quando non s’accorgeva di respirare.
Si trovò un posto, ad un canto della strada.
Abbassò il sedile di guida, e si rannicchiò con le braccia strette al petto, e le gambe ripiegate.
Voleva dormire ora. Tutto il giorno magari.
E svegliarsi affamato a sera, desiderando un caffè e dei biscotti dolci.
Chiuse gli occhi, e immaginò che qualcuno gli ponesse sul corpo indifeso, una coperta, fino alla testa.
Che gli desse calore, e lo abbracciasse, come un angelo cui affidarsi.
Gli uccelli, avevano iniziato a cantare.
===============================================================
Aveva letto, da qualche parte, di un antico re che, per paura d’essere avvelenato, ogni giorno, beveva una goccia di veleno d’un serpente. Sperava così, d’abituare il proprio corpo al male, e difenderlo, per questa via, quando fosse arrivato un attacco pesante.
Forse era per questo motivo che l’uomo, ogni giorno, toccava con la punta delle dita, le ali di una farfalla.
Ogni giorno, usciva per i prati, e cercava farfalle, e, con pazienza, le sfiorava, senza far loro del male, rubando loro, qualche granello della polvere che faceva volare le loro ali colorate.
Arrivava talvolta a strofinare le proprie dita tra i fiori, e restare poi fermo, tempi instancabili, ad aspettare che una farfalla si posasse tra le sue mani, per carezzarla, leggerissimamente.
Ogni giorno della buona stagione. Ogni giorno cercava farfalle e spandeva, sulla propria pelle, la leggerezza delle loro ali.
Quell’uomo, immaginava gli fosse così concesso, alla fine dei propri giorni, proprio all’ultimo istante, prima d’andar via, d’avere una vita di un giorno ancora, proprio come una farfalla.
Una vita intera, trascorsa ad inseguire il profumo dei fiori, a bere al mattino le lacrime di rugiada della notte e ad essere poi baciato dal sole, e fino a notte; fino a diventare scintilla come le stelle.
Un giorno in più. Di vita.
===============================================================
Imperfetto.
Ogni volta che guardava il cielo, lo trovava imperfetto.
Senza nuvole, ma velato di caligine; nuvoloso, ma terroso; troppo limpido, o troppo annerito. Certe volte, le nuvole disegnavano mostri terribili.
Ma la verità, era che lei non era con lui, sotto il cielo.
Per questo, il cielo era imperfetto.
===============================================================
Non riusciva ad immaginare come potessero gli uccelli volare, dentro il temporale. L’acqua era fittissima, e, quando arrivava a terra, rimbalzava in mille schizzi alti.
Pensava all’acqua che appesantiva le ali, e feriva gli occhi forse, o magari ostacolava il respiro, come se gli uccelli fossero immersi dentro un fiume impetuoso.
Era certo che tutto fosse fermo, mentre l’acqua scendeva. La musica s’era interrotta, il traffico scomparso, i suoni, spenti.
Uscì di casa, senza un ombrello, con indosso però i suoi occhiali, per proteggerseli gli occhi, lui che poteva, al contrario dei passeri.
Arrivò sulla strada, e iniziò a sentire l’acqua corrergli tra i capelli e sul collo, per entrare poi sul suo petto, e dietro la schiena. Non sentiva freddo, nonostante la temperatura si fosse davvero abbassata, ma gli sembrava invece che la pioggia, arrivata sulla pelle, svaporizzasse subito.
Si sentiva caldo, vivo, mentre la pioggia batteva e il vento lo sferzava, di schiaffi veloci.
Voleva solo immergersi nell’acqua di cielo, galleggiarci dentro, e farsi portar via magari. Fino al fiume. Fino al mare scuro come una nostalgia profonda.
S’accorse, ad un certo punto, di tremare. Forse il freddo. Forse l’emozione.
Lei gli aveva appena inviato un messaggio sul cellulare.
Stava tornando. L’indomani si sarebbero visti, e il mondo avrebbe ripreso a girare.
==============================================================
Abitava in una vecchia casa di un condominio di periferia. Una di quelle case coi mattoni leggeri.
Talmente tanto leggeri che, certe volte, da una casa all’altra, si poteva sentire una mamma, imitare i rumori di un aereo al decollo, per convincere il suo bimbo a mangiare la pappa.
Il ragazzo era nella sua cameretta, quel giorno, e provava a studiare, nonostante il sole fosse riuscito a soffiar via le nuvole. Ma lui non poteva approfittarne. Settembre era vicino, e il suo anno scolastico precedente, era finito con dei debiti da ripagare, più per sua cattiva volontà, che per difficoltà ad imparare.
Si chiedeva, mentre studiava, se la ragazza che aveva visto – per la prima volta, qualche settimana prima, entrare nella casa a fianco, abitata da qualcuno dopo mesi dalla morte del suo vecchio proprietario – avesse anche lei, una cameretta tutta sua, che magari poteva avere in comune, con la sua stanza, una intera parete.
La parete contro cui era poggiata la sua scrivania, forse. E lui, a starci seduto, fissava il muro, come se potesse trapassarlo, come se fosse una finestra in realtà, che gli permettesse di guardare dall’altro lato del mondo e affacciarsi su panorami che, prima, non aveva neppure immaginato.
Gli era sembrato di sentire, qualche volta, piangere, da dietro quel muro. Certe volte al mattino molto presto, notte ancora. Altre volte a sera.
Gli era sembrato un pianto calmo, come se le lacrime uscissero da sole, senza un ordine o un preavviso; solo qualche singhiozzo, breve, mischiato con dei respiri forti, forse sospiri, forse il naso faceva fare lunghi giri, all’aria e ai pensieri, prima di arrivare dentro il petto.
S’era chiesto, la ragione di quel pianto.
Quando vedeva la ragazza, fuori di casa, lei appariva sorridente, decisa, forte. E strideva perciò, con quel che ascoltava attraverso il muro.
Talvolta, cercava di convincersi di star ascoltando una trasmissione televisiva, e che non fosse la ragazza a piangere.
Ma il tono, di quei respiri, a lui, sembrava davvero somigliare alla voce della ragazza, quando rispondeva brevemente al suo saluto, le volte che s’erano incrociati sulle scale di casa.
E proprio quel giorno gli sembrò di sentire più forte, il rumore del pianto.
Allora, il ragazzo, s’alzò in piedi, e, ad alta voce, sperando d’essere ascoltato anche dall’altro lato del pianeta, annunciò che stava ripassando uno sconosciuto autore letterario inglese, del secolo scorso. Inventò un nome.
E descrisse, scandendo bene le parole, la storia di un uomo che era abituato a risolvere da solo ogni problema; capace di assumere su di se le proprie responsabilità sin da piccolo, quando aveva dovuto occuparsi delle sue sorelline minori, perché il padre aveva abbandonato presto la propria famiglia.
Un uomo che, nel proprio intimo, semplicemente non considerava l’ipotesi di chiedere aiuto. Lo scrittore di cui raccontava, aveva affrontato grandi difficoltà, sempre riuscendo a prevalere, fin quando un evento tragico, non lo segnò pesantemente, bloccandolo.
Il ragazzo raccontava come, l’uomo che tutti credevano invincibile e cui tutti s’appoggiavano, avesse in sé una fragilità segreta e smarrita. Forse da lì venivano le sue poesie venate di malinconia e solitudine. Il ragazzo sperava d’essere ascoltato, dall’ altra parte del muro. Sperava che la ragazza comprendesse; riconoscesse simili alle proprie, alcune delle vicende che il ragazzo attribuiva strumentalmente allo scrittore.
Il ragazzo provava a dirle, attraverso il muro, che si poteva far finta di parlare con sé stessi, se si fosse provato imbarazzo a raccontarsi. Magari qualcuno avrebbe potuto ascoltarla, e risponderle senza esistere, come fosse una voce interiore.
Il ragazzo immaginava che lei accettasse di parlargli anche attraverso il muro che li separava; che lei prendesse, stringendola tra le sue, la sua mano tesa. Che parlasse davvero del suo pianto, come se lo stesse facendo ad uno specchio, liberandosene, cosi.
Il ragazzo sapeva, che esistevano persone che proprio non avevano nella testa, l’idea di poter chiedere. Magari per pudore, oppure per orgoglio che nascondeva il pudore. Persone capaci di rinunciare a sé stesse, pur di mantenere intatta la corazza che indossavano ogni giorno. Forse quella ragazza era così e lui voleva offrirle una porta da aprire, senza che lei si sentisse giudicata, o compatita; senza nemmeno che sentisse qualche obbligo verso di lui.
Lui stesso, somigliava moltissimo, allo scrittore inesistente di cui stava parlando, e che offriva alla ragazza perché lei abbattesse, il muro che li separava.
Ci sono barche, pensava, che per paura di non reggere più il mare grosso, finivano col temere anche di uscire dal porto. E ci sono barche, che non riconoscono, le proprie paure, e non le accettano, e restano ferme, come dentro un gorgo che non le lasci uscire, e perdono la rotta, e imparano solo a rifiutare le onde.
Il ragazzo sognava che qualcuno, magari quella stessa ragazza, chiedesse a lui, d’abbandonarsi senza timore alcuno, perché nessuno gli avrebbe fatto male, o avrebbe approfittato di lui. E per questo sperava che lo facesse la ragazza, per offrirsi di accoglierla, senza nulla chiedere in cambio.
Dev’essere bello, pensava, riabitare la propria pelle; crescerci dentro di nuovo; cambiare direzione magari, ma crescere.
E doveva esser bello anche divertirsi, senza più paure, dentro la propria pelle, smettere di piangere.
Il ragazzo, alzando ancora la voce, raccontò al muro, che lo scrittore, infine, aveva accettato di compiere il primo passo, e s’era liberato dalla malinconia e dalla paura; aveva scoperto di poter avere e magari continuare a dare, e nessuno l’aveva considerato vinto.
Il Nobel, inventò che aveva vinto.
Quel giorno, il ragazzo sentì smettere di piangere, e, poco dopo, qualcuno suonare alla sua porta.
=============================================================
In un piccolo paese di montagna, proprio sopra al Fontanile, dove un tempo si abbeveravano gli armenti – e in certi inverni colmi di neve, anche qualche lupo che, ogni tanto, per fame, calava più a valle – c’era un bellissimo orologio pubblico.
Un vecchio artigiano, alla fine dell’Ottocento, aveva voluto regalare al paese, un particolare meccanismo che segnava le ore .
Ad ogni ora nuova, dall’una di notte, e fino alle ventiquattro, si spandeva nell’aria una musica di carillon allegro, e si apriva, da un cassetto nascosto sotto il quadrante dell’orologio, una piccola piazza in miniatura, lungo la quale un meccanismo faceva sfilare ventiquattro statuine, raffiguranti personaggi noti del Paese, di cui oggi, s’era persa memoria.
Tra queste statuine, v’era quella di un giovane pastore, che era posta immediatamente dopo, la statuina di una ragazza che portava sulla testa, un cesto colmo d’uva.
Quell’orologio, con la sua musica allegra, aveva accompagnato tutti gli avvenimenti del paese. Guerre, burrasca, matrimoni e funerali, elezioni e parate, e, ormai, con la precisione del suo meccanismo, segnava le giornate di tutti quelli che erano rimasti, e non erano emigrati verso la grande città vicina, o oltre il mare.
Considerato ormai come un elemento naturale del paesaggio, era stato un po’ dimenticato e le sue statuine s’erano, da tempo, scolorite.
Nessuno sapeva, che il pastorello era innamorato della ragazza con l’uva. E che l’inseguiva, da oltre un secolo, senza mai poterla raggiungere, poiché le statuine erano fissate ai loro supporti, ad una distanza fissa, che nessuno avrebbe potuto modificare.
Era come se una voce, mentre lui cercava di avvicinarsi a lei, gli ricordasse, costantemente, che, per raggiungere il suo amore, avrebbe dovuto fare un passo in più.
Sempre un passo in più. Senza fine, un passo in più.
Ma qualunque passo il pastore cercasse di fare, la ragazza restava sempre ad un’ora di distanza da lui.
Poteva vederla, ma non prenderla per mano; poteva vederla, ma lei non avrebbe parlato con lui.
Era, quello del giovane pastore, un desiderio da oltre cento anni soffocato. Impossibile.
Forse fu un fulmine, a notte. O forse, dopo un così lungo e preciso funzionamento, l’artigiano che aveva costruito l’orologio, aveva pensato che tutto il meccanismo meritasse una pausa, ma, comunque, accadde che l’orologio si fermò, e il giovane pastore capì che forse poteva finalmente avvicinarsi alla ragazza che aveva tanto sognato.
Forse, è così che capita. Che l’amore possa essere capace di fermare il tempo.
===============================================================
Era da solo, nella sala.
A quell’ora, nel cinema, c’era solo lui.
Erano appena state spente le luci, ed iniziava la proiezione. Da una piccola finestrella, posta sulla parete opposta allo schermo, scendeva un corposo raggio di luce che conteneva in sé, suoni, rumori, storie, e ombre.
S’era seduto in prima fila, sovrastato dal grande schermo, che però poteva vedere interamente, senza problemi.
S’accorse, ad un certo punto, che la sala andava affollandosi, dietro e intorno a lui. Tantissime persone prendevano lentamente posto.
Erano giocatori di biliardo, pirati, sceriffi e famosi ladri; splendenti ballerine e commesse di negozio; antichi romani e regine persiane. Streghe e scienziate. Supereroi e maghi; guerriere e vagabondi. Picchiatelli e suonatrici di violino. Soldati innamorati e malavitosi sconfitti, vampiri e agenti segreti; donne angelo e marinai imprigionati, e… mille altri.
Negli spettatori che aveva intorno, riconosceva famosi personaggi di film trascorsi; protagonisti di storie comiche e di lacrime; di torte in faccia e di baci bellissimi, di amicizie infinite e voli senza cadute.
L’emozione gli faceva battere veloce il cuore.
Avrebbe voluto far loro mille e mille domande. Avrebbe voluto ringraziare tutte, e tutti, per i sogni che gli avevano lasciato tra le dita, sin da quando era bambino.
Ma fu sorpreso da un pensiero. E iniziò a cercare una giovane donna che, per lavoro, faceva la traduttrice.
Forse l’avrebbe trovata. O forse avrebbe fermato il taxi su cui viaggiava per dirle un’ultima cosa segreta. Una cosa che solo lui e lei avrebbero potuto ricordare, per il resto della loro vita che non era in un film.
Forse le avrebbe chiesto di scappare via insieme. Dalla città, dallo Stato, dal pianeta.
Forse l’avrebbe abbracciata, stringendola fino al prossimo diluvio universale.
O forse avrebbe acceso tutte le luci della sala, e sperato, con tutte le proprie forze, che lei non sarebbe scomparsa, dentro un corposo raggio di luce, proveniente da una finestrella sul muro. E che non ci sarebbero mai stati, i titoli di coda.
===============================================================
Camminava.
Camminava da molto tempo dentro la pineta. La luce era scesa, ed era buio ormai.
La luna galleggiava lontana, e alta, sulla cima degli alberi, e schiariva leggermente i suoi passi.
Non aveva paura. Non temeva animali, o agguati. Procedeva tranquillo, riconoscendo la strada che voleva compiere, da certi piccoli segni, che ricordava bene: delle rocce disposte in un certo modo; dei tronchi d’albero caduto; certi avvallamenti del terreno.
Era diretto in un luogo che solo lui, pensava di conoscere.
Arrivò ad una radura.
Le lucciole iniziarono a volargli intorno, per far luce. Due giovani cerve erano ferme sul limitare del bosco. Un capriolo era accucciato tra l’erba ancora alta. Un gufo e una civetta, erano appollaiati su un ramo d’albero proprio vicino alla sua testa. Il muso dolce di un’istrice spuntava da una buca nel terreno, mentre un tasso, lì vicino, raspava una corteccia. Forse, dov’era più buio, c’era un lupo timido, di cui, ogni tanto, vedeva gli occhi luccicanti.
L’uomo sedette su un cippo tagliato, di un vecchio faggio.
Tirò fuori un libro, e, tra luna e lucciole e cicale in cerca d’amore, iniziò a leggere, ad alta voce.
La storia strana, di un soldato ferito, che, la notte, usciva di nascosto dal suo ospedale da campo, e s’inoltrava nel bosco, camminando con difficoltà, fino ad arrivare ad una radura, dove, ad alta voce, leggeva un libro, da solo, nella notte, immaginando di raccontare una storia, strana, alla donna che amava, e che era lontana.
E c’erano degli animali ad ascoltare la sua voce, emozionata.
E c’era la luna.
Solo lei, non c’era. Perché era lontana.
===============================================================
Scendeva giù, il bambino.
Temeva, nello scendere, di incontrare tratti di lamiera strappati, che lo potessero ferire, nonostante i jeans; nonostante che, sotto il sole, la striscia ferrosa, dello scivolo in discesa, apparisse compatta e lucente, invitante come un frutto pericoloso.
Cercava di tenersi leggermente aggrappato ai bordi metallici dello scivolo, per frenarsi, se necessario; per paura di cadere da un lato.
Riempito di raccomandazioni dai genitori, il bimbo cercava d’essere attento a tutto, e non riusciva a provare, quasi mai, un abbandono gioioso, innocente e senza oscuri sensi di colpa, che gli facevano sentire sempre, di non meritare mai, quel che viveva.
Sentiva l’aria frescarsi leggermente nella discesa, che correva quasi ad occhi chiusi, e arrivò a terra, sorprendendosi di non esser caduto nella pozza di sabbia in fondo, ma anzi, d’essersi immediatamente rimesso in piedi, come quando saltava per colpire la palla di testa, nel campetto sterrato sotto casa.
E allora volle subito riprovare, e, di corsa, risalì le scalette, pronto di nuovo a scendere. Stavolta, sapeva che non ci sarebbero stati ferri a ferirlo, e lasciò che le mani si limitassero a sfiorare appena i bordi ferrosi che, ai lati, proteggevano la discesa, veloce tanto, ora, increspata appena dal suo sorriso, incredulo quasi.
Era bello, giocare, e voleva farlo ancora.
E ancora discese, più e più volte; sempre più veloce a risalire la scaletta per arrivare in cima alla scivolo, e con le braccia allargate poi, come ali aperte, mentre scendeva velocissimo.
Si fermò solo un istante.
Una bambina col broncio era arrivata vicino allo scivolo. E il bimbo restò incerto su cosa fare, un solo istante però. Poi le fece un segno con le braccia, invitandola a salire, lei per prima.
La bambina venne giù veloce dallo scivolo, e lui la guardava come se fosse un arcobaleno coi capelli scompigliati.
Ora, toccava di nuovo a lui.
E il bimbo si sentiva felice, come se, dopo tanto tempo, qualcuno si fosse accorto di lui, e proprio con lui, volesse giocare.
Allora scese, con le braccia aperte, e gli occhi chiusi.
Era una rincorsa presa per volare, e il bambino volò.
Sul castello, sui fiori, sugli alberi, sulle casette di legno.
Volava in un cielo pulito, e fresco, e non voleva mai più tornare a terra.
===============================================================
È dolce, il succo di limone, appena spremuto. Senza edulcorarlo. Senza aggiungere acqua.
Molto più dolce, di quello che sentiva, camminando su un sentiero sterrato sotto il sole, in salita.
Lassù in alto, sapeva esserci un piccolo fontanile, antico, sicuramente più dei suoi ricordi.
Un tempo, si nascondeva lì vicino, sotto una piccola macchia d’alberi spersa nella collina pietrosa, e aspettava arrivasse il branco dei cavalli dal pascolo.
Ne sentiva il tuono, lontano, degli zoccoli pesanti, e il respiro poi, forte come un vento caldo.
Certe volte, il grande cavallo bianco, a guida del branco, saltava, dentro il piccolo fontanile, per sentire refrigerio e bere, e per riaffermare la propria supremazia, su tutti quelli che avrebbero potuto avvicinarsi all’acqua, dopo di lui.
Avrebbe voluto accarezzare quei cavalli, ma ne aveva paura. Grandi, liberi, indocili.
Ora, non s’avvertiva pioggia vicina, e il fontanile era secco, proprio come la sua bocca, inasprita dalla solitudine.
Era rimasta solo una striscia d’acqua, sul fondo della pietra, nella quale si rifletteva il cielo, mentre lui non vi trovava il proprio volto.
Una infinita nuvola bianca, addossata alla montagna, sembrava disegnare la testa di un grande cavallo che lo guardava dritto negli occhi, come se stesse raccogliendo le forze per correre via, disperso dal vento.
S’accorse allora, che proprio lì vicino, era nato, chissà da quanto tempo, un grande rovo di more, carico di frutti, azzurri e rossi. Gli venne voglia di mettere le mani tra le spine. Carezzò i frutti, senza prenderne nessuno; come non aveva saputo carezzare i cavalli.
Le sue braccia erano ora piene di graffi e sangue.
Ma lui non si sarebbe mai più fermato, nel carezzare i propri sogni.
===============================================================
Era la prima volta, che saliva in barca da solo. Infilò la corda dei remi, con una cappiola, agli scalmi della barca, lisci di fatica e sego.
Sciolse l’ormeggio, e, con le braccia poggiate sulla banchina del molo, si diede una spinta per uscire dal corridoio delle altre barche ferme a dondolare, col mare leggero.
Iniziò a remare, per allontanarsi dal porto, in piedi, e a piedi nudi sul tavolato della barca. Iniziava a sentire il vento libero, ed era contento, perché era vento che spingeva a terra: avrebbe faticato, ad uscire, ma il rientro sarebbe stato più agevole e veloce.
S’allontanava lentamente dalla costa, col ritmo del suo respiro, mentre sentiva i remi entrare in acqua, e i muscoli tendersi, per la spinta, e poi gocciolare, i remi, appena usciti dalle onde, e il cuore attendere, sospeso.
Una rondine di mare, bianca, andò a poggiarsi sulla prua della barca, e lo guardava. Lui smise di remare, mise la barca a corrente, perché beccheggiasse meno, e si avvicinò all’uccello, che non volò via. Allora lui, con un coltello, tagliò un piccolo pezzo del filo trasparente da pesca, e, dalla tasca, tirò fuori un quadernetto e una matita.
Scrisse due righe appena. Scrisse che quel mare non poteva contenere la sua felicità quando la guardava.
Lego’ ad una zampetta della rondine il suo biglietto, e prese l’uccello tra le mani; le sussurrò all’orecchio il nome di una ragazza e, con un gesto che somigliava ad una preghiera al cielo, la slanciò perché volasse.
Si perse, ai suoi occhi, la rondine.
Non era importante, trovasse la finestra della ragazza, e non era neanche importante che lei sapesse della sua felicità.
E non era nemmeno importante, che la ragazza sapesse della sua esistenza.
Lo sapeva il mare; lo sapeva il cielo; lo sapeva il suo cuore, che non voleva tornare al porto.
===============================================================
La notte era piena di stelle appese alla sfera celeste.
L’uomo, seduto sui gradoni, coperti d’erba selvaggia e muschio secco, dell’antico teatro romano, poteva disegnare con un dito, antiche divinità e animali fantastici.
Nello spazio tra la cavea e il palcoscenico, due statue, decapitate, giacevano a terra; sciolti i vestiti di marmo, abbandonate, le braccia.
Un gatto nero si aggirava tra i posti a sedere, inseguendo le braci dei propri occhi.
Tutto intorno la città era silenziosa, dentro le sue mura di tufo giallo e conchiglie fossili. Le ombre, sembravano vibrare col vento.
L’uomo guardava, da tempo, fisso verso il palco, come se aspettasse, da un momento all’altro, l’apertura del sipario e l’inizio della rappresentazione; e dal palco, infine, parve alzarsi una leggerissima nebbia, che nascose l’ingresso in scena, d’una bellissima donna, armata d’una lancia e di scudo, e protetta da un grande elmo sormontato da piume d’aquila.
La donna si pose al centro del palcoscenico, ferma e muta, come se attendesse le parole dell’uomo.
E l’uomo avrebbe voluto pregare, quella dea, perché gli restituisse la ragione, e la casa. Ma non osava, intimorito.
Sapeva anche, che tutta la ragione che avrebbe potuto vedersi restituita, e tutta la ragione che la dea avrebbe potuto in più donargli, non sarebbe stata sufficiente, a colmare il vuoto che sentiva nelle gambe e nello stomaco. Sapeva che nessuna ragione avrebbe potuto guarirlo dallo smarrimento che cancellava il suo volto dagli specchi. E sapeva di non conoscere più, una strada che lo conducesse alla sua casa.
E proprio perché sapeva questo, non desiderava offendere la dea, chiedendole qualcosa che non lo avrebbe comunque salvato. Sarebbe stato punito, altrimenti, più di quanto già non soffrisse ora.
E guardava la dea, sapendo che avrebbe dovuto esser lui, a parlare, nonostante fosse lei sul palcoscenico.
Ma restava muto, come se fosse consapevole dell’inutilità di tutte le sue parole; come se ogni cosa che potesse pensare, o fare, cadesse in terra, frantumandosi, mentre provava a volare.
La dea sorrise, al suo povero silenzio, e posò le armi in terra, e con un veloce gesto della mano, sciolse la spilla che, sulla spalla, le fermava la tunica restando, in un istante, completamente nuda, più luminosa d’una bruciante torcia di secco legno.
L’uomo vide nuovamente alzarsi, dal palcoscenico, una vaga nebbia fumosa, dalla quale parvero uscire le ali una civetta veloce, diretta oltre i monti lontani.
La donna era scomparsa.
L’uomo tremava, e pareva non riuscire a rialzarsi. Un desiderio, si staccò da lui e cadde nel cielo.
Lontano, un gatto miagolava la sua ricerca d’amore.
===============================================================
Era al computer. E scriveva.
Scriveva una nuova storia. Raccontava di un uomo tremendamente solo. Ma così solo, che nemmeno la sua ombra, gli stava vicino. Si proiettava a metri e metri di distanza, e lui la guardava, magari dall’altro lato di una strada, mentre lei, che avrebbe dovuto stargli attaccata, camminava invece dov’erano le vetrine dei negozi, e si fermava, a guardarli, mentre lui proseguiva, da solo, senza nemmeno poter muovere un braccio contro il sole, per far finta che l’ombra lo abbracciasse.
E mentre il ragazzo scriveva, aveva iniziato a piovere, via via sempre più forte.
Oltre le pareti della sua stanza, il cielo sgocciolava come un rubinetto dimenticato aperto, e i tuoni facevano tremare i vetri delle finestre.
Stava diventando sempre più buio, e la storia che il ragazzo scriveva, raccontava di panchine dove quell’uomo immaginato, da solo, si fermava a leggere un libro e di alberi, che, da solo, quell’uomo non poteva riuscire, ad abbracciare per l’intero tronco, e di strade, che da solo, quell’uomo camminava, coi lampioni spenti e le finestre dei palazzi intorno, chiuse, e nessuno che lo guardasse, o aspettasse .
Forse fu un fulmine, ma il computer si spense di colpo, e quando l’elettricità riprese a funzionare, lentamente, il computer si riavviò.
Ma tutto quel che aveva scritto, s’era perduto, senza possibilità di recuperarlo.
Il ragazzo provò, più e più volte, a ritrovare quel testo, senza riuscire.
E col computer buio, finì col sentirsi ancora più solo, senza neppure la compagnia, di una storia inventata per arrivare ad un lieto fine, cui lui stesso faceva fatica a credere, ma che gli serviva per desiderare d’arrivare al domani.
Restò sorpreso, per questo, quando dal computer, dopo l’assenza di elettricità, col video ancora totalmente buio, parvero materializzarsi delle parole; un messaggio.
Qualcuno, forse una ragazza, lo salutava, e gli chiedeva se stesse bene: se tutto fosse in ordine.
Il ragazzo si sentì per un attimo in Paradiso. Qualcuno s’era accorto di lui, e il suo cuore sembrava aver voglia d’uscire dal petto e correre per la città facendo acrobazie con la bicicletta che lo aspettava in garage.
Si spense del tutto però il computer, e non c’era verso di accenderlo di nuovo. Il ragazzo non poteva ora rispondere a nessuno. Era come trovarsi davanti ad un albero colmo di fiori, da cui cadevano incessanti petali, senza poter essere raccolti, e spazzati subito via da un vento grande.
Allora il ragazzo salì sul tetto della propria casa, e da lì, sotto la pioggia, iniziò ad urlare al vento. Immaginava che qualcuno potesse ascoltarlo. Lui era lì, voleva che tutti lo sapessero, e se qualcuno lo avesse cercato lui avrebbe aspettato.
S’era fatto davvero buio ora, e freddo. Sul tetto della casa arrivava una musica lontana. Forse, in qualche casa vicina, si ballava, o forse erano le stelle che cercavano una loro armonia.
Rimase solo, il ragazzo, fino al mattino dopo sul tetto, e non seppe mai, se qualcuno, quella sera, avesse davvero voluto parlare con lui.
E non seppe mai, se quell’uomo, di cui scriveva, avesse ritrovato la propria ombra, o se invece, fosse rimasto senza.
Solo e povero, senza neppure un’ombra cui raccontare una storia.
===============================================================
Era su un autobus urbano, e stava andando dall’oculista, per un controllo.
Era primo pomeriggio, e c’era poca gente, sul mezzo pubblico, e, per questo, aveva potuto sedersi, durante il percorso. Ad una fermata, era salita una donna, che gli era passata accanto, per andare a sedere su una poltroncina alle sue spalle. Forse, non portava un profumo, ma all’uomo sembrò, per un attimo, d’essere immerso tra cespugli di gelsomino.
Scese, nei pressi dell’Ospedale, e attese il suo turno nel corridoio antistante l’ambulatorio.
Quando venne il suo turno, il dottore, lo fece prima accomodare su una sedia, e gli fece porre gli occhi dentro una speciale apparecchiatura, poi, dopo averlo esaminato, lo fece girare verso il muro che era alle sue spalle, dove erano due diversi riquadri luminosi; ciascuno dei quali, sul lato di sinistra, aveva impresse delle lettere, scritte a grandezza decrescente, dall’alto, verso il basso.
Il dottore gli porse una montatura da occhiali, in plastica, entro la quale aveva inserito delle lenti, ed iniziò a chiedere all’uomo, di riconoscere le lettere che, volta per volta, egli, con una penna telescopica, indicava.
Alla prima lettera, l’uomo rispose di vedere una ballerina di flamenco, tutta vestita di nero, e con le scarpe coi tacchi, che stava facendo prendere fuoco ad un palcoscenico, con la sua danza.
Alla seconda lettera, l’uomo rispose che stava vedendo una farfalla blu, immersa in un mare di papaveri rossi che si piegavano al ritmo del vento.
Alla terza lettera, l’uomo rispose che era di fronte ad una donna importante, forse una giornalista, o forse una donna d’affari, in tailleur grigio, che stava andando ad un appuntamento di lavoro, con la sua valigetta piena di appunti e documenti.
Alla quarta lettera, l’uomo rispose che bisognava scansarsi, perché stavano per passare, in vespa, un uomo e una donna, senza casco, però.
Alla quinta lettera, l’uomo rispose che, davanti ai suoi occhi, c’era una finestra, e oltre la finestra, c’era il mare, e oltre il mare, c’era il cielo, e oltre il cielo, c’erano le lacrime di una commozione bellissima.
Il dottore pensò, che l’amore, non è cieco.
Ma forse, è pieno di fantasia.
=============================================================
Aveva iniziato in una radio, il cui vero proprietario, era una parrocchia.
Non è che avesse proprio iniziato.
Aveva seguito il fratello maggiore, di un ex compagno di classe delle Scuole Medie. Sapeva, che lavorava in quella radio, perché aveva ascoltato il suo programma, una sera che, appena finito di studiare una declinazione di latino, era voluto restare chiuso nella sua stanza, e aveva acceso un apparecchio radio, che consentiva anche di registrare e ascoltare musicassette, che i suoi genitori, gli avevano regalato, il Natale precedente.
Gli era piaciuta, quella musica altalenante e diversa, da tutto quanto sin lì, era abituato ad ascoltare. Ma, soprattutto, gli era piaciuta la possibilità di parlare, tra un disco e l’altro; di raccontare qualcosa, sulla musica che s’ascoltava, o su qualsiasi altro argomento. E lui, aveva voglia di raccontare. A sedici anni c’erano interi universi da esplorare, che spuntavano fuori, sempre più numerosi, ad ogni passo delle sue strade. Gli piaceva tantissimo l’idea di poter parlare con le persone, sia pure da lontano. Già s’immaginava un suo ipotetico ascoltatore; magari qualcuno a lui simile; magari un compagno d’istituto.
Aveva guardato come, il fratello del suo amico, parlasse, in diretta, nel microfono, con le cuffie in testa, per ascoltarsi, e per ascoltare la musica prima che partisse, decidendo così il momento migliore, per mandarla in onda e, contemporaneamente, cambiasse i dischi da uno dei due piatti dello stereo, posti ai suoi lati, e scegliesse quale traccia ascoltare, e come muovesse i cursori del mixer, per far ascoltare, ora la sua voce, e ora la sua musica, senza interferenze.
Non era facile, come aveva immaginato.
Quella radio, aveva anche un piccolo studio di registrazione, dove, ogni tanto, si registravano promozioni commerciali e lui insistette tanto, da ottenere di poter utilizzare quello studio, per registrare dei provini di un programma tutto suo, quando nessuno lo usava..
Dalle finestre di quello studio, poteva vedere un angolo di camera dove una ragazza studiava, seduta ad una scrivania, e, ogni tanto, immaginava che ci fosse lei, all’ascolto del suo programma alla radio, e per lei sceglieva una musica che immaginava le potesse piacere, anche quando, magari, non la conosceva.
Passo’ tre stagioni, dentro quello studio; preparandosi, studiando la musica che avrebbe voluto far ascoltare, guardando tra gli scuri di legno delle finestre.
Fu un giorno di settembre, che, con una musicassetta in mano, dove aveva registrato il provino intero, di un’ora, di un suo programma, andò a bussare alla porta di quello che faceva da Direttore della radio.
Da allora, tutte le sere, tra le sette e le otto, era in radio, a parlare, e a far ascoltare la sua musica.
Immaginava sempre, d’essere su una grande terrazza, e di essere il dj di una grande festa; una di quelle di cui aveva sentito parlare, senza mai potervi partecipare.
E poi, guardava tra gli scuri della finestra.
===============================================================
Da una finestra, usciva una musica dolce, di chitarra. Andava avanti, indietro, e sembrava tenere a sé legato un cuore, che voleva volar via, ma si sentiva attratto, da quel suono altalenante, come un gioco di domande e risposte, che s’alternavano, salendo sempre più in alto; oltre il fumo di un camino, disperso in cielo, ma senza slegarsi mai, l’una dall’altra, cercandosi anzi, aspettandosi.
Lui passava sotto quella musica, ed immaginava di poterla raccogliere, con le mani, e lasciarla libera poi, sul cuscino di lei che riposava, stanca delle sue ferite.
Immaginava profumasse quella musica, di bucato bianco e fresco, come un vento di tramontana, che avrebbe portato via ogni sudiciume, e ogni ombra cattiva.
Quella musica le avrebbe aperto le mani, da troppo tempo chiuse, per difendersi, per non pensare, per punirsi di qualcosa che non aveva mai commesso .
Immaginava quella musica aprire porte, e serrande chiuse, e cuori feriti e far fiorire tulipani neri ad ogni stagione.
Allora scrisse, scrisse un lungo biglietto, in cui raccontava tutto quello che avrebbe potuto essere, e tutto quello che non era stato mai, e tutto quello che avrebbe voluto fosse stato e tutto quello che avrebbe fatto, perché fosse davvero, domani.
E poi affidò la sua carta alla musica, dolce, di chitarra e ritmo, che usciva dalla finestra, perché corresse, come un sedicenne in vespa, innamorato, fino alla sua ragazza, e la tenesse per mano, ogni volta che lui non c’era, e ogni volta che sognava di esserci.
Sedette, per qualche attimo, sotto quella finestra da cui usciva musica. Ci avrebbe aspettato il prossimo sole, là sotto, che lo scaldasse e illuminasse.
La notte era lunga da scorrere, come un sogno rotto, ma lui non aveva paura del buio. Ballava poi, con la sua ombra, senza stancarsi e senza lasciarle mai le dita.
In fondo, il giorno, poteva anche non arrivare mai. Aveva musica, e i suoi desideri erano vicini, come le stelle oltre le nuvole, e lui voleva solo, dormire mai più.
===============================================================
Aveva preso un cuscino, e, a piedi nudi e col pigiama indosso, a notte ancora alta, era sceso dal suo letto, cercando di fare il minor rumore possibile, per non svegliare i propri genitori.
Percorse tutto il corridoio lungo di casa, al buio, sino alla porta d’ingresso, cercando di non urtare nessun mobile, e, arrivato lì, girò la chiave nella toppa, lentamente; ad ogni scatto metallico della serratura, si fermava, e quasi tratteneva il respiro, per ascoltare se, dalla stanza da letto dove i suoi genitori dormivano, provenissero rumori che preannunciavano il loro comparire.
Uscì sul ballatoio.
Le setole dure dello zerbino, gli fecero una specie di solletico doloroso, sotto la pianta dei piedi, e, dopo aver richiuso la porta d’ingresso, tentando di far tutto in un silenzio di sonno profondo, s’avviò per le scale, verso la terrazza di casa.
Al tetto di tegole spioventi, s’accedeva attraverso una scala a pioli, fissata ad un piccolo lucernario, che il ragazzo aprì, sentendosi arrivare addosso, il respiro di un cielo, per la prima volta leggermente fresco, dopo giorni e giorni di calore opprimente.
Poggiò il cuscino, sul dorso della canna fumaria di un camino, e vi si adagiò sopra, con la schiena rialzata; i piedi nudi poggiavano sulle tegole di terracotta, sorreggendolo. Dopo essersi sistemato, sospeso in aria, per la prima volta guardò il cielo.
Il chiarore della città, illuminava dal basso e confinava il nero del cielo, ad una immensa cupola lontana, in alto, macchiata di stelle sparse, che parevano solitarie e piccole scintille di un fuoco scappato via col vento.
Il ragazzo immaginava che tutto quel buio, fosse solo un’ombra, rimasta a testimoniare, per una intera notte, il passaggio di una infinita balena volante, la cui pelle durissima, aveva portato via luminosissime schegge, dalle stelle che sfiorava, nuotando dentro uno smisurato cielo dalle onde basse e tranquille.
Avrebbe voluto cavalcare, quella infinita balena, per poter visitare altri mondi e cieli verdi o rossi, traversati dai rami blu di alberi carichi di frutti, e sapeva, che se fosse stato possibile, sarebbe stato un viaggio senza tempo, forse senza possibilità di ritorno.
Decise che, con la sua piccola lancia a remi, di ramponiere fragile, non avrebbe provato, a salire sul dorso di quella balena.
L’indomani, sarebbe stato il primo giorno del nuovo anno scolastico. E lui, voleva esserci.
Il ragazzo sperava che, quest’anno, lei avrebbe accettato di sedersi accanto a lui, in classe; l’aveva vista da lontano, qualche giorno prima, e s’era accorto che, ora, indossava un paio d’occhiali,
che la rendevano ancor più bella di come l’avesse ricordata per tutta l’estate trascorsa.
===============================================================
Era appena uscito dal casello autostradale e la sua auto iniziò a far fumo dal motore. Fino a spegnersi.
La strada era leggermente in salita e l’auto non riusci’ ad arrivare in un luogo tranquillo dove fermarsi.
L’uomo provò, inutilmente, a spingerla. L’auto era troppo pesante e rischiò d’essere travolto. Risalito, e sfruttando la pendenza della strada, tornò leggermente indietro, riuscendo a fermarsi in un posto dove era agli altri visibile, senza intralciare eccessivamente il traffico.
Il mattino ancora non iniziava, ed era una domenica; avrebbe dovuto aspettare almeno un paio d’ore, prima di poter chiamare qualcuno che, con un carro attrezzi, lo venisse a recuperare.
Ogni tanto, passava qualche auto. I guidatori, rallentando, lo guardavano perplessi, e incerti. Forse era lì fermo in quel luogo pericoloso, perché aspettava qualcuno. Oppure, aveva un problema. Poi proseguivano, senza fermarsi. Qualcuno, andando via, faceva suonare il clacson.
Il cielo iniziava a schiarirsi, e le stelle ad andare a dormire.
Faceva freddo.
Cominciavano a sentirsi i primi uccelli cantare e l’uomo immaginava il momento in cui sarebbe arrivato qualcuno col carro attrezzi per portarlo via. Sapeva che si sarebbe sentito in colpa. Come se l’avaria dell’auto fosse una punizione per qualcosa che avesse fatto, o anche solo pensato. Si chiese allora, se davvero fosse responsabile di qualcosa.
Non aveva risposte. O forse ne aveva troppe. Sentiva di non esser quasi mai riuscito ad essere come avrebbe voluto. Il meglio che avesse potuto.
E gli sembrava piccola, per questo, la punizione che stava subendo.
Cercava di guardare qualcosa dentro la propria auto, per un po’ di tempo, in modo che, ogni volta che guardava il cielo, lo ritrovasse sempre più chiaro, e pulito. Gli sembrava che la luce, gli desse speranza. Si sentì fortunato, a non essersi fermato in una delle gallerie dell’autostrada.
Dall’altro lato della strada, era uscito un gatto, dai rovi, e s’era fermato a guardarlo.
Gli sembrava quasi, che ridesse di lui.
Il gatto, con le sue zampe, poteva andare ovunque. Lui, con la sua auto, poteva solo restar fermo.
Avrebbe voluto carezzarlo, quel gatto, e chiedergli di restare con lui, ad aspettare.
Ma era solo.
E doveva aspettare.
===============================================================
Lungo la linea dell’orizzonte, il cielo grigio pareva ammassarsi come un lenzuolo sfatto, annerendosi.
L’uomo camminava sulla battigia, a piedi nudi; esattamente sul confine delle onde che si perdevano nella sabbia. Affondava leggermente nella sabbia bagnata, lasciando orme che, presto, il mare cancellava, ad ogni soffio di vento, fino a cancellare la sua presenza stessa..
Guardava in basso, e sembrava contare ogni passo che, proseguendo per un paio di chilometri ancora, forse più, lo avrebbe condotto infine sulla riva opposta del piccolo golfo. Conosceva il posto, alla fine del suo cammino, situato proprio dov’era uno stabilimento balneare, all’inizio dell’altro braccio di mare.
Lì, le sdraio, avevano ancora l’intelaiatura di legno, tenuta insieme da un telo di nylon, a righe celesti e bianche, ed erano disposte in modo da sfruttare la copertura delle piccole acacie, cresciute numerose, in quel tratto di spiaggia, e che proiettavano un’ombra di rami taglienti e sfilacciati, che però raffreddava leggermente il sole, ora perso, dentro una caligine umida e giallastra.
Non c’erano ombrelloni aperti, e, dal piccolo bar, realizzato col legno di vecchi pescherecci, la vista arrivava fino all’isola, lontana, col suo faro, che, da lì, pareva un piccolissimo fiammifero, lasciato acceso sghimbescio, in mezzo al mare, qualche istante prima che le onde potessero tuffarsi su di lui, sommergendolo.
Da un vecchio juke box, uscivano canzoni estive fuori stagione.
Era lì, che aveva appuntamento con le Forze dell’Ordine.
Non aveva voluto arrivare alla Caserma; una costruzione moderna e bruttissima, che pareva edificata col preciso intento di deturpare la scogliera opposta, dalla parte del vento che non arrivava mai. Gli sarebbe sembrato d’oltraggiare i luoghi dove faceva il bagno da ragazzo.
Aveva deciso di costituirsi; ma aveva chiesto d’esser prelevato in un luogo a sua scelta.
Ed aveva scelto quel breve tratto di mare, dove, sapeva, le onde, poggiandosi delicatamente sulla sabbia, talvolta, lasciavano a riva i gusci madreperlacei delle conchiglie di abalone, che, sin da bambino, bucava con la delicatezza necessaria a non infrangere quel delicato arcobaleno, per farci passare dentro sottili fettucce di cuoio, e confezionando così, collanine, che regalava sempre alla stessa bambina, divenuta ormai donna.
Riconosceva d’aver commesso molti reati, contro i propri sogni, e, soprattutto, d’esser colpevole di abbandono di sé stesso, lasciato sperso e dimenticato, da qualche parte, come un pupazzo di pezza sfilacciata.
Magari, qualche anima buona, mentre scontava la sua pena in una casa circondariale, gli avrebbe portato qualche quaderno bianco, sui cui fogli avrebbe potuto scrivere canzoni, lasciate libere in mare come foglie d’autunno, e destinate alle sirene che salvavano marinai dal naufragio.
===============================================
Aveva trovato, in mare, una piccola pietra; non più grande di un pollice.
Era coperta d’alghe brune di velluto, che avevano avuto l’incredibile forza di mettervi radici entro, trasformandola in un bozzolo morbido.
Decise di raschiar via tutte le alghe, e, per farlo, usò un pezzo di ramo secco che aveva trovato in spiaggia, dal bordo sufficientemente duro.
Ci lavorò sopra per una buona mezz’ora, e, alla fine, si ritrovò tra le mani, quella che sembrava essere una piccola statuetta, rappresentante, forse, una donna.
Si distinguevano i fianchi arrotondati e il seno nudo; forse era vestita con un panneggio che le arrivava ai piedi, di cui si distingueva qualche incisione longitudinale, che seguiva le linee del corpo; il volto era liscio, per l’usura del mare salato, e conferiva alla statuetta, un aspetto enigmatico, come qualcuno che si specchiasse al buio, senza poter distinguere i propri tratti, ma solo un’ombra tondeggiante, appena incisa dalla luce degli occhi, e della bocca.
Duemila anni prima, o più, forse, un uomo, o un ragazzo, stava traversando un tratto di mare in barca. O forse, un uomo, o un ragazzo, stava camminando per una strada alta, posta su una scogliera a strapiombo sul mare. O magari, un uomo, o un ragazzo, stava camminando per certi tratti di città, in cui il mare entra profondo, disegnandone il porto e le mura.
Forse quell’uomo, o quel ragazzo, portava con sé, magari avvolta in panni preziosi, o chiusa in una scatola istoriata, una piccola statua che rappresentava una donna. Forse, quell’uomo, o quel ragazzo, in barca, o camminando per la strada, o tra le vie di una città, stava portando con sé quella piccola statua, per donarla ad un tempio.
Su una tavoletta d’argilla, quell’uomo, o quel ragazzo, al momento di donare la statua al tesoro del tempio, avrebbe scritto una sua preghiera votiva, che accompagnasse il dono con la richiesta di poter accedere a qualcosa, o a qualcuno.
Forse, quell’uomo, o quel ragazzo, chiedevano salute, per la donna rappresentata nella statuetta. Oppure quella donna rappresentata nella statuetta era la ricerca di una promessa d’amore.
Guardava la pietra modellata che aveva nelle mani, della quale non sapeva ascoltare la storia, trasportata fin lì, da tortuose correnti di lingue perdute; oscurata da un numero infinito di onde e di vento trascorso, macerata dal sale e dalla sabbia di fondo, e si sentiva, tra le dita, uno strano calore, come se da quel corpo provenisse il battito di un cuore emozionato.
Salì sulla bicicletta che aveva lasciato sulla strada e arrivò fino alla città vecchia, dove era il piccolo museo del paese. Chiese di poter parlare con la direttrice del museo, e le consegnò la statuetta, dopo aver ricevuto un attestato di consegna.
Poi, scelse, tra gli ulivi, in campagna, una pietra piatta, grande, coperta di muschio arancio, seccato da mille e mille estati, e ci poggiò sopra, il legno col quale aveva raschiato via le alghe dalla pietra. Come se stesse posando, finalmente, la statuetta di una donna, sull’altare di un tempio.
Forse quell’uomo, o quel ragazzo, cui la statuetta era forse caduta in mare, avrebbero avuto accolta la loro preghiera, ora, dentro il mare di stelle della notte, in cui nuotava; dentro l’oceano del tempo trascorso, e di quello che sarebbe dovuto venire.
===============================================
S’era appena svegliato.
Era notte alta ancora. Appena cosciente di sé, si sentiva il sogno interrotto ancora tra le dita. Era in mare; mare alto e nero, e non si vedeva il fondo, e stava nuotando. Nuotava lentamente, quasi solo con la spinta delle braccia. Doveva tenersi le forze, per affrontare le correnti del canale e oltrepassarle, e arrivare fino allo scoglio, dimenticato dalla terra, in mezzo al mare, dove potersi fermare e riprendere fiato.
Nuotava sapendo di non poter guardare, sotto di sé, dove potevano agitarsi immensi mostri; invincibili squali affamati o dinosauri predatori sopravvissuti agli asteroidi.
Eppure continuava a nuotare, sospeso in un tempo che sembrava girare su sé stesso e, ogni volta che alzava lo sguardo dall’acqua, per guardare verso lo scoglio che lo aspettava, gli sembrava di vederlo sempre alla stessa distanza, come se ogni suo sforzo di muoversi, fosse inutile, e qualcosa lo trattenesse, senza farlo andare mai.
Il cielo era scuro ancora, abbassato dalle nuvole grigie, che s’intravedevano in controluce. Si sentiva il respiro affannato, mentre però gli si spandeva dentro la sensazione d’essere al sicuro, nella sua camera. Si alzò dal letto. Aprì la finestra, e uscì sul balcone. Gli arrivano i rumori lontani della città. Qualche auto che correva via veloce.
Poco lontano, sentiva il vento muovere le foglie di in albero che sapeva carico di mele, che stavano diventando rosse.
Gli venne naturale, allora, scavalcare il balcone, e iniziare a nuotare dentro la notte.
Lentamente, usando quasi solo la forza delle braccia, per godersi quella sensazione liquida di galleggiamento magico.
Sapeva che, stavolta, sarebbe riuscito, ad arrivare all’albero di mele.
Ne sentiva già il profumo, leggermente aspro.
===============================================
Il passero era sulla cima di un immenso ippocastano, la cui chioma verde, si muoveva leggera al vento, facendo oscillare con sé l’uccello che, però, restava fermo sul ramo che aveva scelto.
Nessuna paura, per il piccolo passero, che, al bisogno, sarebbe volato via, senza certo cadere, anche quando il vento, gli avesse scardinato la presa.
Sapeva, dove avrebbe trovato cibo.
Da un balcone vicino, un uomo scuoteva nell’aria un lenzuolo bianco, appena asciutto. Era lui, che su un piccolo davanzale della propria casa, era solito sbriciolare un pezzo di biscotto dolce, per restare poi, dietro il vetro della finestra, ad aspettare che il passero arrivasse, per vederlo beccare il cibo, e guardarsi intorno continuamente, guardingo, e andar via infine, veloce, come un pensiero felice.
Quel mattino l’uomo, dopo aver sbriciolato il biscotto, restò dietro la finestra, lasciandola però aperta, e quando il passero arrivò, lui, subito, avvicinò la sua mano, fermandola, a poca distanza dall’uccello, che non scappò via, ma continuò a beccare.
L’uomo, avvicinò allora un dito alla testa del passero, che si fece accarezzare, mentre tutto il mondo intorno, restava in silenzio. A questo punto, l’uomo, circondò l’uccello con la sua mano, e lo prese, delicatamente. Ne poteva sentire tra le dita il piccolo cuore battere velocemente, agitato.
Subito, lego’ alla zampetta dell’uccello, un piccolo cilindro, che conteneva un minuscolo pezzetto di carta, sul quale aveva scritto la prima sillaba del nome della donna di cui era innamorato e la prima sillaba del proprio nome, come se fosse un unico nome nuovo, che indicava l’unione di due diversi pensieri che insieme, profumavano di ali colorate e forti.
E subito lasciò libero il passero, che si perse oltre le fronde dell’albero.
Lui voleva, che quel nome unico, volasse nel cielo, e riempisse di sé tutta l’aria che si poteva respirare.
===============================================
Gli piaceva guidare il suo piccolo furgone, adibito ad autobus di una linea in subappalto, per le strade di piccole frazioni di montagna. Dieci, quindici gruppi di case sparse; qualche chiesa, una stalla e il fontanile, vecchi conventi disabitati, riuniti tutti sotto il nome di un unico paese che, fisicamente, col proprio nome, magari non esisteva nemmeno.
E gli piaceva guidarlo quando arrivava il primo buio, e, tra le curve, le ombre degli alberi, e delle case costruite a ridosso della strada, sembravano portare verso mondi antichi e lontani, quando le auto erano ancora pochissime, e tanti andavano a dorso d’asino, sopra grandi basti di cuoio.
Gli piaceva perché ogni pezzo di strada in bilico sul vuoto, e senza guard rail, gli
ricordava quando, bambino, per una di quelle strade di montagna, i suoi genitori lo portavano al paese dove era cresciuta sua madre, e dove finalmente poteva giocare libero per i prati; ma anche dove, una notte, ricordava, d’aver incontrato per la prima volta una porta mai più aperta, quando dopo una telefonata notturna, tutti corsero verso l’unica luce accesa di quel buio; quella di una casa sul bordo del castello, e dell’unica stanza illuminata dell’abitazione dei suoi bisnonni; dove il nonno di sua madre, aveva, da poco, chiuso gli occhi.
E quando guidava il suo bus, con la notte che arrivava, gli piaceva essere sempre cauto, per via degli animali, che potevano passargli la strada, e per evitare di trovarsi troppo improvvisamente davanti a qualcuno che ancora camminava a piedi, per quelle strade d’asfalto che ricopriva vecchie mulattiere.
E, infine, gli piaceva passare per quelle strade, perché una volta, ad una fermata, era salita una donna bellissima, e, da allora, tanto tempo prima, ogni giorno, sperava di vederla di nuovo, a sera, quando stava per fare notte, perché invece lei, faceva luce.
Per questo, più di tutto gli piaceva; perché era come immaginare che tutta la propria vita, improvvisamente, diventasse bellissima, ad ogni curva di più, ad ogni salita di più, ad ogni discesa, più ancora.
E allora, gli veniva quasi, di guidare ad occhi chiusi
==============================================
Il bambino aveva giocato tutto il pomeriggio a calcio. Aveva cercato di farsi vedere, dalla bambina con le ali. Era riuscito anche a segnare due gol. Ed era accaldato, a fine partita, sudatissimo. Ma non poteva bere l’acqua della fontana. La mamma s’era raccomandata di non bere, quando era sudato; gli avrebbe fatto male l’acqua, nello stomaco. E il bambino provava a figurarsi amara, l’acqua.
Cambiavano le vocali, pensava il bambino, e l’amore, diventava amaro.
Bevve lo stesso, l’acqua freddissima, della fontana.
E guardò il sole tramontare; sapeva che anche la bambina, lo avrebbe guardato, magari per sbaglio, e forse avrebbe potuto vedere i suoi occhi, in cielo.
===============================================
Aveva un manto pezzato, il cavallo; bianco e nero, a macchie, che sembravano slabbrarsi, in direzione della coda dell’animale, come se, il colore, si spandesse con la velocità, lasciando di sé una scia polverosa che indicava la direzione della corsa.
Non poteva dirsi, se fosse il nero, ad aver macchiato il bianco, o se invece fosse stato il bianco, a lasciare le sue ombre sul nero; quel cavallo sembrava fosse nato solo per correre; fermo, pareva sgraziato, quasi costretto a muoversi lentamente, per non lasciare troppo indietro i monti, da cui s’allontanava, verso le valli più nascoste.
Sembrava chiaro però, che fosse lo stallone dominante del branco. Gli altri animali parevano alzarsi dal loro brucare, solo quando s’accorgevano si muovesse lui, e si spostavano nel pianoro, solo quando lui decideva di andar a cercare un pascolo migliore.
L’uomo sedette in terra, proprio in cima ad una piccola cupola del terreno, e, dopo aver predisposto un piccolo cerchio di sassi, accese un fuoco, alimentato da pezzetti di legno secco raccolti in terra e stoppie, ancora bagnate dalla notte.
Aveva freddo, e bisogno di riscaldarsi.
Il cavallo vide il fuoco, dentro il grigio sospeso del mattino, quando il sole è ancora un desiderio. E si avvicinò.
L’uomo lo vide arrivare, curioso, e decise di restare seduto.
Quando l’animale si fermò a guardarlo, da un paio di metri di distanza, l’uomo restò ancora fermo, ed iniziò a cantare, con voce inizialmente bassa, ma poi sempre più distinguibile, una vecchia canzone, che raccontava di un drago triste, che con la sua tristezza ostile, teneva prigioniera una regina, oscurandole il sole e i sorrisi; facendole apparire triste, ogni sogno e ogni pensiero.
Il cavallo sembrava seguire, i versi della canzone e, impercettibilmente, s’avvicinava all’uomo sempre più.
Quando fu vicino abbastanza, l’uomo si alzò, aprì le braccia e strinse a sé il potente collo del cavallo, e ne carezzò il muso. Si guardarono negli occhi.
Forse la regina aveva già trovato il modo di sconfiggere il suo drago della tristezza, ma l’uomo e il cavallo, insieme, erano decisi a raggiungerla.
Ovunque fosse.
===============================================
Lungo il binario, nella stazione della città, sostavano numerosi viaggiatori in attesa. Ciascuno teneva vicino a sé il proprio bagaglio. Molti fumavano. Qualcuno parlava col proprio compagno di viaggio.
Si mischiavano profumi e impazienze. Incertezze sul posto prenotato e cellulari accesi, per comunicare coi propri fantasmi.
All’inizio della pensilina, ogni mattina, alle 8, si fermava un uomo.
E, ogni mattina, portava con sé un fiore. Una rosa, spesso, o un tulipano. Una margherita talvolta, o una giunchiglia fragile.
Aspettava l’arrivo del treno regionale.
Su quel treno, sapeva, viaggiava una donna, che viveva in un paese vicino, e che aveva conosciuto un giorno al bar della stazione. Le aveva offerto un caffè. Ma lei aveva rifiutato, perché non era interessata a sconosciuti, e risposto che pagava sempre da sola, le sue consumazioni.
Lui aveva pensato che, per farsi conoscere da lei, almeno avrebbe dovuto farsi vedere.
Per questo, ogni mattina, all’ora giusta, si faceva trovare in stazione, con un fiore, e faceva in modo di incrociarla, quando lei scendeva dal treno, e, passandole accanto, le chiedeva sempre, se potesse offrirle un fiore, e un caffè. E se, vedendolo, gli sembrasse un po’ meno sconosciuto.
Ogni mattina.
===============================================
Alta in cielo, era la luna, in mezzo a scintille di stelle, mentre sull’orizzonte del mare, i fulmini lasciavano cadere sull’acqua, la furia di una luce feroce.
L’uomo restava seduto, su un balcone, e ascoltava le onde riprendersi la spiaggia di ombrelloni chiusi, come alberi d’inverno secchi. Era un fragore sordo, come il suo cuore strappato via, pulsante ancora, e gettato in un tombino scuro.
Diede un morso alla mela, che aveva con sé, e ne sentì il sapore dolce e duro, della buccia rossa. Pensava alle prime parole di un libro che aveva letto da bambino, mentre era malato, e che lo condussero allora, per mano, dentro una storia di pirati e colonie, e a fianco d’un amore incandescente, ucciso dall’indifferenza, ma capace di restargli attaccato addosso, come il brivido di quella notte umida e sola.
Si sentiva le dita appiccicose del frutto nudo e immaginava i gabbiani nascosti alla tempesta, e gli scafi in acqua, ora, col mare gonfio e i lampi che ne slabbravano la schiuma, come un primo sguardo del mattino, appena sveglio, dentro un letto grande e vuoto, e la voglia di serrare gli occhi e dormire, per una volta, e far finire tutto.
Nessuno camminava sul lungomare.
Indossò una maglietta e un paio di scarpe, e uscì.
Il silenzio del lido non ricordava più i giochi di bambini e ragazzi sotto l’estate, e i suoi piedi affondavano nella sabbia scura. Arrivò dove le onde disegnavano archi di conchiglie e sentì l’acqua sommergergli le caviglie. Non voleva fermarsi più e non voleva più avere paura.
Dietro di lui, la città era piena di luci pallide; davanti a lui, il mare nero, ma senza minacce, solo libero, da porti e rotte tracciate.
Si lasciò cadere, e si stese sulla sabbia ardente di gelo. Aveva sonno ora, finalmente. Si pose su un fianco, rannicchiato, e chiuse gli occhi, aspettando un sogno che lo portasse via da lì.
===============================================
Conosceva bene, quel tratto di autostrada. Lo aveva percorso decine e decine di volte, per arrivare alla piccola casetta di legno dei suoi bisnonni, sui monti, a fianco dei recinti dov’erano allevate le galline, e dove c’era anche qualche cavallino che correva a fianco della sua mamma.
Arrivava al paese, perché era innamorato di una ragazza che viveva lì, dietro una finestra da cui sporgevano grandi fioriere colme di piccoli garofani di montagna, color rosa scuro.
Non ne conosceva neanche il nome.
Si limitava a camminare, avanti e indietro, e a correre talvolta, lungo la strada principale del paese, dov’erano un ristorante e un fontanile, sperando che lei, da dietro la finestra, lo guardasse. E magari decidesse di uscire dalla sua casa, e lo fermasse, per parlarci.
Ma non accadeva mai.
E però lui continuava a tornare al paese, ogni volta che poteva.
Come quella sera, che era di nuovo in autostrada. E mentre guidava, diceva a sé stesso, che se avesse guidato, per tutta la galleria, ad occhi chiusi, lei, finalmente, avrebbe aperto la finestra.
Chiuse gli occhi un istante solo, per sentirsi immediatamente perso, e impaurito. Senza alcun punto di riferimento e senza nessuna certezza di continuare ad andar dritto, con la certezza anzi, di ascoltare, da un momento all’altro, il rumore stridente delle lamiere, lungo una delle pareti della galleria.
Li riaprì subito, gli occhi, e riprese il controllo di tutto. Come appena svegliato da un incubo.
Stranamente però, iniziò a sentirsi sereno. Era entrato, per un attimo, nella propria paura, e ne era uscito.
Chiuse gli occhi di nuovo allora, tenendoli serrati più a lungo, anche se rallentò un po’ la velocità. E di nuovo li riaprì. Scoprendo che non aveva invaso la corsia di sorpasso, e che procedeva bene.
E di nuovo, senza pensare nulla, chiuse gli occhi.
Gli sembrava che le ruote dell’auto corressero su binari elettrici luminosi, che s’alzavano da terra e piegavano verso un cielo carico di stelle lucenti, dai riflessi blu e arancio; e sentiva come se stesse correndo con tutti i finestrini aperti, e l’aria, notturna già, gli regalava fresco e acqua.
Il rumore del motore dell’auto era lontano, come una voce dimenticata, e nemmeno il proprio corpo sentiva più. Solo le mani, ferme sul volante. Strette.
La ragazza era uscita, e sedeva sugli scalini d’ingresso della propria abitazione.
Gli sorrideva.
E allora, decise di riaprire gli occhi. Forse, la galleria era finita.
===============================================
Pioveva, e pioveva forte.
S’era fermato sotto un cavalcavia, per ripararsi dalla pioggia, visto ch’era uscito senza ombrello, e vestito come se ancora fosse piena estate.
Sentiva, sopra la propria testa, passare le automobili veloci, e lasciare dietro di sé una scia d’acqua, arrabbiata, sibilante.
Nonostante tutto, gli piaceva, esser lì, al riparo, mentre sentiva il vento soffiare, forte, tra griglie di metallo e alberi prigionieri dell’asfalto.
Si sentiva un po’ protetto, e in fuga, come se, tutto quel cielo che lacrimava, se lo fosse lasciato indietro, lontano, ed ora qualcuno lo avvolgesse con un abbraccio, mentre guardava l’acqua scendere, sempre più fitta, tanto da sembrare quasi una parete grigia, mobile e ondosa.
Cominciò a chiedersi, trascorso un po’ di tempo, se da qualche parte nel cielo, ci fossero ancora, celeste e sole, e si sentì addosso una specie di frenesia; come se sentisse il bisogno di essere nuovo, e pulito. Come se avvertisse un senso di profondo dolore ribelle, a tutto quanto il mondo gli stava rovesciando addosso.
Allora raccolse in sé ogni forza, e uscì sulla strada, oltre la copertura del ponte d’asfalto, piegò le gambe, e poi iniziò a salire. Poggiava i piedi sulle gocce di pioggia, e saliva, di corsa, come fosse una scala a pioli, ma senza nulla cui poggiarsi, e saliva, dentro il blu liquido, e lucente, e saliva, quasi senza prender fiato, rubando l’appoggio, per un istante, alle righe di pioggia fitta, e certe volte, sembrava nuotare, e risalire, dal fondo del mare, verso la superficie.
L’aria pareva più leggera, via via che saliva, e gli pareva che i propri vestiti, da zuppi, stessero lentamente, ma costantemente, asciugandosi.
Ed infine, uscì nel celeste, a respirare di nuovo; oltre le nuvole e il vento, sotto una infinita cupola di cielo e raggi di sole, lenti e caldi.
Non sentiva stanchezza.
Solo le proprie ali di cera, gocciolare.
===============================================
Era uscito di casa, a notte alta.
Ma aveva fatto solo pochi passi, e s’era fermato davanti ad un grande pino.
La notte aveva odore di deserto lontano e le stelle tremavano, perse nel buio. L’aria era ferma, senza un vento che sfiorasse la pelle, e, nella testa, sentiva il ronzio delle parole che, da mesi e mesi, cercava di dirsi, senza riuscirvi .
Dei rami d’albero, e dei loro aghi pungenti, vedeva, in realtà, solo delle ombre, contro la luce dei lampioni, ma nel silenzio del sonno del mondo, quei rami si muovevano, da soli. Parevano cercare qualcosa. Tentavano l’aria, come se volesse l’albero spostarsi, dall’aiuola ove era confinato, e andar via, altrove.
Restò sorpreso, ed impaurito, da quella vita inattesa, che non voleva restare ancorata al luogo dov’era nata, ma pareva volersi liberare, e inseguire luoghi impensabili. In fondo, anche lui stesso, era andato via dal paese dov’era nato, e aveva imparato altri luoghi, senza sentire più le proprie radici, anzi, senza sentire più radici.
Gli pareva che l’albero lo invitasse, ad avvicinarsi, come se avesse qualcosa da dirgli, o da dargli.
Ma lui restò fermo. La notte che lo avvolgeva, sembrava essersi fermata, e lo portava indietro, fino a tempi senza fuoco o case; solo il rumore leggero dei rami, che roteavano nell’aria, muovendosi goffamente.
Vinse il proprio timore, allora, e si avvicinò all’albero . Gli parve di sentire una voce, terrosa, gocciolante.
Quella notte l’albero, gli spiegò che non avrebbe parlato dei cerchi di vita e tempo che aveva dentro e che erano trascorsi; ma del sole e della pioggia del futuro.
Che è l’unico posto libero e nuovo che possiamo provare ad abitare, e che possiamo vivere, se avessimo il coraggio di avvicinarci ai sogni che gli altri sognano di noi, a notte alta.
===============================================
Il bambino camminava col nonno nel parco. Gli teneva la mano antica e grande e cercava, sgambettando, di tenere il suo passo.
Arrivati ad una panchina, posta sotto un immenso ippocastano, sedettero. L’uno vicino all’altro. Il nonno pose la propria mano poco sopra la testa del bambino, e spiegò al piccolo che lo faceva, perché in quel periodo, cadevano dal cielo, ricci pieni di castagne finte, e magari qualcuna poteva colpirlo, e fargli male; invece, in quel modo, una castagna scortese, avrebbe colpito la mano del nonno, invece della sua testa, senza dargli dolore, perché il nonno era forte. Il bimbo chiese allora al nonno, se potesse lui, salire in cielo e proteggerlo dalle castagne che cadevano.
Allora il nonno ritirò la mano dalla testa del bambino, e, con un foglio di carta che prese da una tasca della propria giacca, modellò un aeroplanino.
Il nonno spiegò al bimbo che, se fosse salito su quel piccolo aereo, avrebbe potuto volare in cielo, e arrivare fino a prendersi un pezzetto di nuvola, come uno zucchero filato.
E poi, il nonno spiegò al bimbo che l’amore, ha questo di bello: che vuole scambiarsi con l’amore dell’altro e dare di più e, già solo per questo, protegge la persona amata. E che perciò, non c’era più bisogno, di mani sulla testa.
Il bambino allora, pensò che avrebbe fatto bene a salire su quell’aereo, e che avrebbe potuto tranquillamente farsi dare da una nuvola, un po’ di zucchero filato.
===============================================
Quando era ponente maestro, il mare durava tre giorni.
Questa era la regola che gli aveva insegnato il nonno. Non si poteva uscire in mare per tre giorni, perché il mare sarebbe stato cattivo. Onde arrabbiate e schiumanti; alte, frequenti e scure, come il cielo basso che bruciava le nuvole fino al nero.
Il buio, somigliava alla notte che aveva dentro; e dentro, era freddo che pizzicava le gambe nude e rendeva celeste l’acqua delle fontane.
In quei giorni di vento, l’uomo si recava sugli scogli, a sentire l’odore del mare, e il rumore fosco del vento; come se, guardare coi propri occhi, potesse abbassarne la furia. Come se potesse mettere a confronto la tempesta che gli svuotava le viscere, con gli schizzi d’acqua bianchi e fumosi, che portavano lontano la salsedine, certe volte fino al suo volto, imbiancandolo. E come se, in quel confronto, l’uomo confidasse che la potenza del proprio vento, più furibondo del mare stesso, abbassasse la cresta del mare, impaurito di fronte all’impeto dei propri agitati pensieri .
E guardava, costantemente l’orologio, quasi fosse possibile farne correre più veloci, le lancette, ed arrivare prima al mare placato e dolce.
Ma i suoi appuntamenti d’amore, non arrivavano mai, prima del loro momento, per quanto lui provasse ad aprire le vele del tempo, per prendere tutto quel vento, di poppa, e scorrere veloce, il più veloce possibile, fino al momento dell’incontro; fino al momento in cui avrebbe potuto vedere ancora le fiancate della propria barca, scivolare leggere nell’acqua, rubandone quella forza misteriosa che consentiva loro di restare a galla e creare per lui un piccolo mondo terrestre, in mezzo al cielo.
Stavolta, avrebbe contraddetto il nonno, però.
Aveva deciso di uscire in mare, già al primo giorno di vento.
Non gli importava della paura; non gli importava di vedersi salire le onde ben sopra la prua della propria barca; e non gli importava di sentire le sirene chiamarlo in mare, per perdersi tra le loro braccia affamate.
La barca lo aspettava ormeggiata ad un vecchio muro basso, appena accanto al ponte che conduceva alla città vecchia, sotto le cui palastre il mare raggiungeva il lato di scirocco, chiuso in parte dal mastio del castello che si sporgeva a protezione della città vecchia.
E ondeggiava, mossa dalle onde rapide e profonde che arrivavano, sia pure fortemente attutite, dal mare esterno, oltre i moli della Capitaneria di Porto.
Scese in barca, e tolse le scarpe, per sentire sotto i propri piedi nudi, le schegge del legno vecchio e le macchie di vernice bucata, e per farsene trasmettere, dalla pelle, le vene di linfa ancora viva. Dal piccolo cassero di prua, tolse i giubbotti salvagente, e li poggiò sulla terraferma, lasciandoli lì, rossi, col loro fischietto appeso, inutili, ora.
Sciolse gli ormeggi.
S’avvicinava, l’incontro col mare, appena oltre la protezione del braccio di molo.
L’uomo chiuse gli occhi, allora, mentre sentiva, per la prima volta, la prua della barca alzarsi, e poi ricadere, piatta, con un urto secco, sulla superficie piegata del mare. Dietro le palpebre chiuse, scosso dal rollare dello scafo, sentiva i raggi di sole polveroso, che, a sprazzi, riuscivano ad oltrepassare il fitto intreccio ammassato di nubi, e lo chiamavano ad aprirli, gli occhi, per guardare il mondo.
Ma lui sapeva che sarebbe arrivato comunque, ad un lido d’alghe secche e sabbia bianca, nudo e sporco, percosso dalla tempesta.
Ancora vivo. Sempre innamorato.
===============================================
L’uomo poggiava la testa sul cuscino, rialzato contro la spalliera, e stava steso su metà letto; il suo piede sinistro poggiava leggermente a terra. Accanto a lui, era steso un bambino, con le coperte rimboccate sin sotto il collo, e gli occhi azzurri, apertissimi nella penombra della stanzetta, illuminata solo da una piccola abat jour. Il bimbo succhiava il pollice della propria mano destra, e ascoltava.
L’uomo gli stava leggendo la favola di un quartiere, che aveva fondato una squadra di calcio mista, di ragazzini e ragazzine, che partecipava ad un campionato in cui avrebbe giocato contro le squadre di ragazzi provenienti dai quartieri di tutta la grande città. In questa squadra c’era un ragazzo che giocava col numero dieci, e una ragazza che era la centravanti.
Il ragazzo passava sempre a lei la palla, quando erano in attacco, e lei, con la leggerezza di una farfalla e la velocità di un piccolo falco, finiva sempre col fare gol, come per una specie di magia felice.
Il giorno della finale del campionato, però, dentro un grande stadio pieno di persone, il ragazzo e la ragazza sembravano scomparsi; portati via forse da un dispettoso spiritello dei boschi, che invidiava la loro gioia.
Il bambino, nel letto, s’immaginava eroe, che correva a liberare i ragazzi, che potevano giocare la loro finale, e anche se erano entrati nel secondo tempo della partita, con la loro squadra in svantaggio, riuscivano a ribaltare il risultato e a vincere la coppa della grande città.
Forse la storia finiva così, o forse i bambini, nella favola, erano scappati via perché non gli piaceva vincere, ma solo giocare.
Mentre il cielo scuro della notte, iniziava a piovere e tuonare, come uno stadio in festa, in fondo, s’addormento’ il bambino.
Ma non sogno’ d’essere eroe.
Sognò d’essere un numero dieci che passava sempre la palla alla stessa ragazzina bionda, che faceva sempre gol, e sempre la loro squadra vinceva.
===============================================
Si sbiadiva la notte, mentre l’uomo camminava da solo, sul ciglio della strada; le stelle parevano tremare, col cielo che prendeva luce, da est.
L’ombra dei monti ritagliava il bordo del mondo, dando quasi l’impressione di scoprire giganti pietrosi che si svegliavano, col cielo che s’aranciava alle loro spalle.
Una farfalla volava appena sopra l’erba, felice, il suo solo giorno di vita.
Gli uccelli cominciavano a rompere il silenzio, cautamente, con la stessa timidezza d’un risveglio accanto alla persona amata.
E avrebbe voluto davvero, l’uomo, in quel momento, poter sentire la tenerezza del desiderio d’abbracciare qualcuno. Continuava a camminare però, deciso, come se avesse un appuntamento; come se qualcuno, finalmente, attendesse proprio lui.
Disegnava un arco rosa, ora, la luce del sole, appena sotto la notte che si ritraeva, lasciando spazio a colori vertiginosi, come un fuoco che ardesse di pensieri furiosi, rotolanti.
Sulla cima d’una collinetta erbosa, un cavallo guardava il mattino, mentre il vento gli muoveva leggermente la criniera. Quando l’uomo si avvicinò, il cavallo chinò la testa, per farsi accarezzare. Il suo respiro scaldava l’aria intorno.
Era lo stesso cavallo nero, che conosceva, e aspettava, sin dai propri sogni di bambino, quando immaginava di scoprire con lui, terre nuove e mai prima traversate.
Il cavallo si lasciò montare, mentre l’uomo gli parlava piano, ringraziandolo di accettare il suo peso.
L’animale prese a camminare, piano, eretto, verso l’alba, e l’uomo iniziava a scoprire che il mondo, nonostante la notte, esisteva ancora.
==============================================
Era seduto in terra, e poggiava la schiena sul tronco di un grande albero.
Sotto di lui, correva il nastro di una stradina di montagna, dove non passava quasi nessuno.
S’alzò il vento, per un istante, e, dall’albero, iniziarono a cadere foglie dorate.
Su ognuna di loro, aveva scritto, con una matita, uno dei suoi sogni, che ora galleggiava lento nell’aria, fino a posarsi ai suoi piedi, immobile.
Ne raccolse qualcuno, e cerco di leggere a quale dei suoi sogni si riferisse.
Le scritte erano tutte sbiadite dal sole e dalla pioggia.
Cominciava la stagione fredda, e, per scrivere nuovi sogni, sarebbe stato necessario sentirsi primavera dentro.
===============================================
Era dentro il letto.
La febbre lo faceva sudare, e si sentiva tutto appiccicoso e dolorante.
Aveva rotto una noce, conservandone intatta una delle metà. Poi, aveva preso un cartoncino bianco, leggero e, con una matita, aveva disegnato sulla sua superficie il contorno del guscio, ritagliandone poi la sagoma; con delle gocce di colla liquida, aveva fissato sul guscio, la striscia di cartoncino sagomata, adattandone la grandezza. Quindi, l’aveva bucata, al centro, con uno stuzzicadenti, cui aveva fissato prima in triangolo di carta, perché simulasse una vela latina.
Aveva approntato la sua nave ora, che era pronta ad affrontare le onde delle coperte del suo letto, e i gorghi.
Si sarebbe spinto a raggiungere i bordi del mondo conosciuto, navigando anche di notte, alla luce dei lampioni lontani, oltre gli scuri delle finestre.
Doveva raggiungere l’isola dov’era stato portato il suo cuore; rapito e buttato via.
Non c’era sulle carte geografiche quell’isola; forse avrebbe potuto raggiungerla solo inseguendo certi venti del mattino. Quelli che sembrano portare l’alba fin nelle stanze degli ammalati, per regalargli un giorno in più e una possibilità ancora di guarire.
Sembravano parlare, quei venti, e lasciavano sgocciolare le parole sulle labbra arse dal termometro, rinfrescandole.
Ma ora aveva la sua nave dalla carena rugosa e viva.
E nessun fortunale, lo avrebbe fermato.
===============================================
Nessuno lo aveva mai accarezzato.
E lui non lasciava che nessuno, lo accarezzasse.
Non desiderava abbandonarsi, e nemmeno sentirsi indifeso. E men che meno, voleva che le carezze gli piacessero o che, addirittura, potesse sentirne il bisogno.
Non voleva avere desideri, che non potesse soddisfare. E non voleva soffrire, per quel che non poteva avere.
Forse sarebbe stato bene, se qualcuno lo avesse accarezzato. Magari avrebbe potuto chiudere gli occhi, e sentire che tutto il mondo, era fatto solo di carezze. Magari avrebbe potuto sentirsi importante, perché c’era al mondo qualcuno che volesse carezzarlo.
Ma sentiva che era una trappola. Che nessuno sarebbe stato lì, ad accarezzarlo, ogni giorno, e ogni giorno non voleva sentirsi esposto e fragile.
Forse sarebbe stato bello, essere accarezzato.
Come una specie di festa segreta che canta dentro il proprio cuore.
Non lo sapeva, e non voleva saperlo.
Il cane camminava solo, dietro una macchia di ginepro, e s’allontanava dalla città e dagli umani. Dai boschi vicini, arrivavano odori antichi, che sembravano aspettarlo, sotto la luna che cresceva limpida nel vento freddo.
===============================================
È un fenomeno particolare, la pareidolia.
Consiste in una umana tendenza, a dar forma compiuta a immagini naturali che nulla abbiano a che vedere con quanto la nostra mente invece ricostruisce.
Capita ad esempio, con le nuvole; quando diamo loro forme animali, di un orso, o di una balena, o le fantastiche forme di un drago volante.
Spesso, questo processo, individua volti umani: in rocce, o montagne, o magari nella corteccia di alcuni alberi.
L’uomo camminava per la città e, ad ogni negozio di fiori, i suoi occhi, dentro i mazzi, o le composizioni floreali, vedevano il volto della donna di cui era innamorato. E gli capitava anche col guardare certe vetrine di librerie e anche nei negozi di pastelli e matite di ogni colore. La ritrovava sempre; il volto di lei, pareva sorprenderlo ogni volta che, camminando, per un istante lasciasse il pensiero della donna, un angolo prima; subito il suo sorriso si apriva tra i rami degli alberi e sorrideva anche lui allora, mentre gli altri lo guardavano straniti, interrogandosi su quali pensieri, quell’uomo inseguisse, che lo facessero sorridere, senza apparente ragione alcuna, mentre il mondo continuava la sua rumorosa corsa.
In un giorno di pioggia gli parve che le increspature dell’acqua, scolpissero nel fiume il suo volto, che la corrente portava via, lontano e immagino’ arrivasse sino al mare, e s‘imprimesse nella sabbia, sugli scogli; tra le onde.
In fondo, lui voleva solo abitare un mondo che gli consentisse di guardarla sempre.
===============================================
E poi, c’era questo paesino strano.
Appena all’ingresso, quando ancora era strada provinciale, s’incontrava la prima stalla di leoncapre: erano delle capre dotate di corna regolamentari, ma anche di una folta criniera, e ruggivano, quando volevano essere munte, e non puzzavano, come capre, ma profumavano come i fiori che trovavano al pascolo.
E poi c’era subito una piccola piazzetta, dove s’affacciava la bottega del caffelatte sbarbato. Era una bottega assai particolare, perché non aveva tavolini da bar, ma solo poltrone su cui sedersi, davanti ad un grande specchio, per farsi radere la barba al mattino, mentre si faceva colazione, col latte delle leoncapre, il caffè, e i buonissimi biscotti alle noci, che la nonna del padrone della bottega, ogni giorno, sfornava croccanti. Sempre sulla piccola piazzetta, c’era un fontanile, che, nei giorni duri d’inverno sottozero, faceva sgorgare dalle sue cannelle, una grappa milleerbe miracolosa, che persino i lupi, di notte, venivano a bere per scaldarsi, e ululare poi, parecchio divertiti, alla luna.
Dopo la piazzetta, c’era una curva e, su una roccia, s’alzava un castello.
In realtà, della vecchia rocca che un tempo dominava il paese, era rimasto solo un moncone merlato, ai cui piedi s’apriva l’unica osteria di quel borgo, dove si cucinavano galline molto anziane, e si vendeva un vino rosso buonissimo, del quale però, si poteva bere un bicchiere solo, perché era fortissimo, e, già al secondo bicchiere, la testa cominciava a girare; per questo l’oste, per il bene del cliente, di nascosto, poi annacquava il vino, altrimenti dalla sua osteria, ogni sera, avrebbe dovuto riportare a casa gli avventori, addormentati sul basto del suo mulo Giggetto.
Sotto al castello, oltre la strada e dentro un burrone precipitevole, c’era la chiesa, dove ogni domenica, il prevosto teneva messa, e ogni domenica provava a salire sul pulpito, posto in cima a delle bellissime scale a chiocciola in legno di fico, con l’intenzione di declamare una potente predica ispirata alle Letture della funzione, e ogni domenica, non si sa perché, cadeva per terra dal pulpito, ledendosi dolorosamente il capoccione.
Ma il vero motivo per cui io, dalla grande città, ogni volta che potessi andavo al piccolo paese, era nascosto dietro le finestre dell’ultima casa abitata, prima che ricominciassero i boschi di noccioli e mele selvatiche.
Viveva lì, una ragazza misteriosa, che non usciva mai di casa, e di cui nessuno aveva mai udito la voce. Si sapeva solo che era così bella che, certe volte, l’alba, sorprendendola sul balcone ad innaffiare i fiori, o a stendere i panni appena lavati, si vergognava, di non essere stupenda come lei, e tornava indietro, dimenticandosi di far sorgere il giorno, quel giorno, che, perciò, restava notte, tutto il giorno.
Io non la vidi mai, quella ragazza, anche se ero sicuro, d’essere innamorato di lei. E la immaginavo più bella di qualsiasi diva del cinema e più dolce di una mano che mi accarezzasse.
Solo perché immaginavo che lei mi parlasse, di lei m’ero innamorato. Nessuno aveva mai sentito la sua voce, ma a me parlava. E io la sua voce, la sentivo; dentro di me. Mentre raccoglievo le more o scappavo dalle vipere, e, certe volte, anche mentre mungevo le leoncapre. E dedicavo a lei tutti gol che facevo, anche quando giocavo a pallone nella grande città.
È vero.
Non l’ho mai vista quella ragazza, ma sono sicuro che c’era lei, tra i petali dei garofanetti montani; nell’acqua limpida e gelida che a primavera scorreva sui sassi bianchi; nelle corse dei cavalli liberi e nel canto dei passeri al mattino.
E lei mi parlava.
Era l’unica, che mi parlava.
===============================================
S’era messo in testa di costruire un programma informatico, capace di prevedere, data una certa velocità del vento, e la sua direzione, in rapporto con una determinata specie di albero, quali fossero tutti i movimenti possibili delle sue foglie.
E, naturalmente, anche dei rami, dell’albero.
La difficoltà più grande, consisteva nel riuscire a prevedere come, ciascuna foglia, fermando in parte il vento che la attraversava, finisse col condizionare, e determinare, in parte, il movimento di ogni altra foglia dell’albero.
Scoprì di non riuscire a farlo, coi soli, sia pure potentissimi, mezzi della Matematica, e della Fisica.
Allora, gli venne di pensare che esisteva una sorta di principio fondamentale, secondo il quale, il movimento di ogni singola foglia, di un singolo albero, fosse in realtà determinato, sicuramente dalle caratteristiche specifiche di quell’albero, ma anche dai diversi e autonomi movimenti di tutte le foglie di quell’albero. Vale a dire cioè che, per quanto ciascuna foglia potesse sentirsi libera, autonoma, ed indipendente, il suo movimento era in realtà il frutto del movimento del tutto.
Che faceva anche rima, oltre a procurare un certo mal di testa.
E finì col chiedersi se – sapendo che, da qualche parte del mondo vi era certamente qualcuno che avesse tra le dita una felicità bella, e pulita – il vento di scirocco, non portasse anche fino a lui, un movimento, magari minimo, di felicità che lo attraversasse.
===============================================