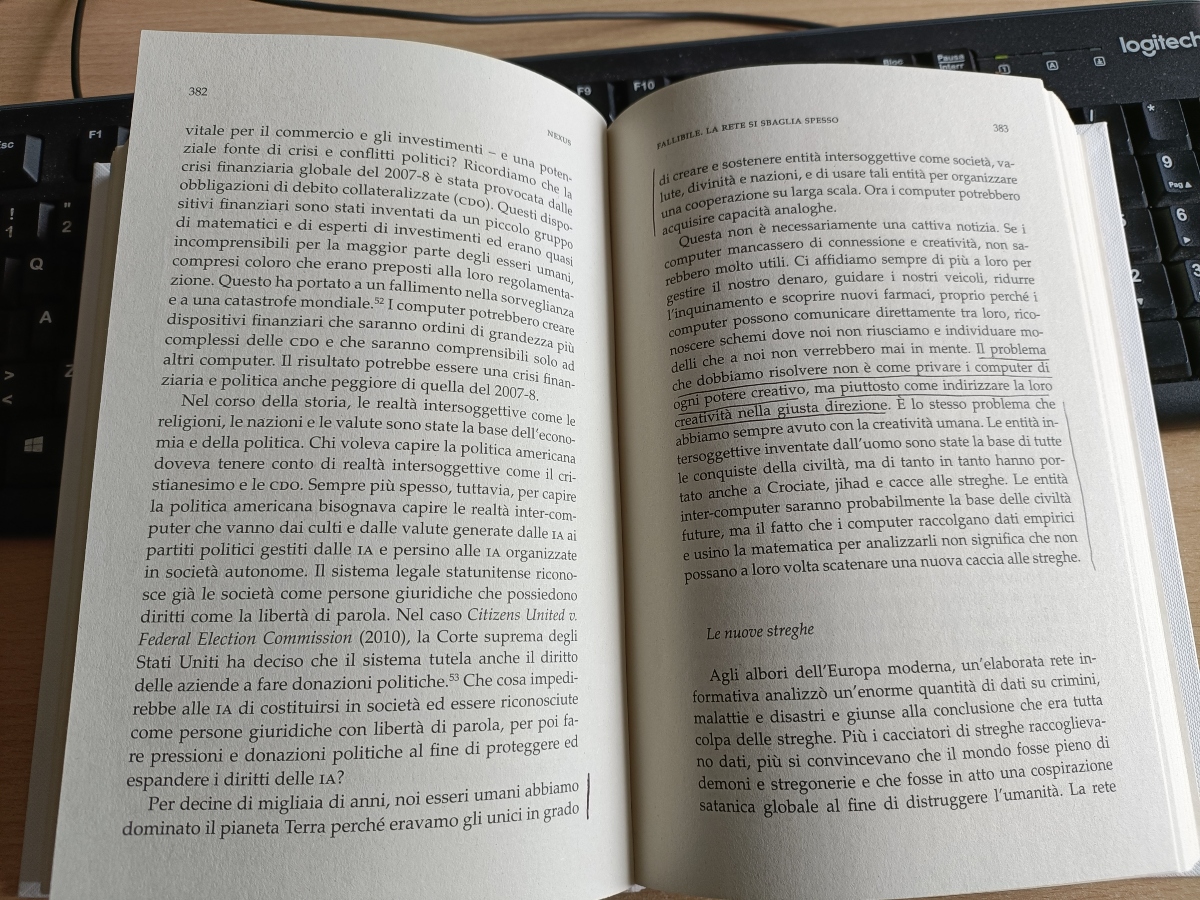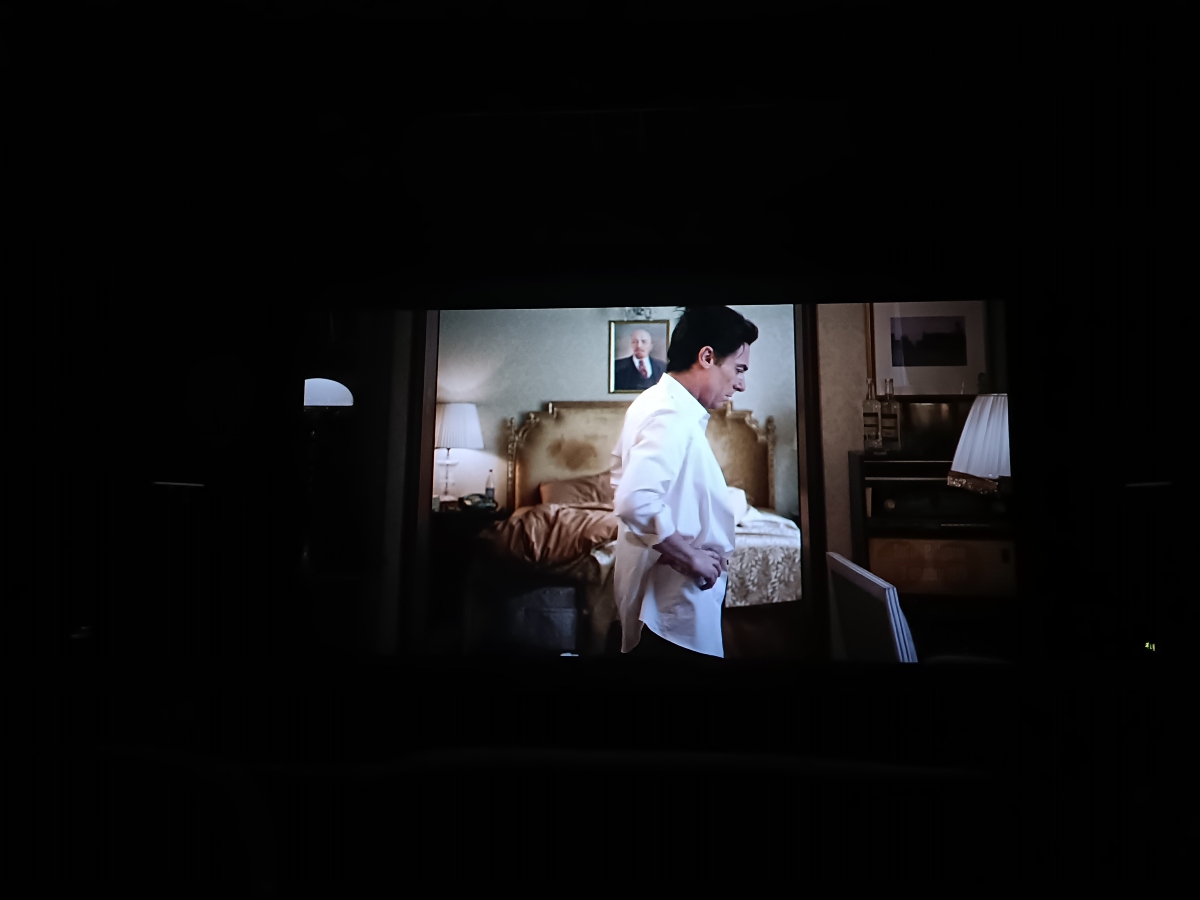C’è una domanda, che varrebbe la pena scandagliare sempre.
E riguarda la persistenza della fascinazione per i fascismi, anche nel nostro tempo. E non parlo dei fascismi, diciamo, “contemporanei”, nelle loro varie incarnazioni; fatti cioè di gestione liberista nell’economia, e autoritarismo, anche quando sia di derivazione religioso-fondamentalista.
Parlo proprio dei fascismi che Mussolini ha inventato.
Un impasto di violenza, populismo, modernità industriale e capacità comunicative che si riallacciano ad archetipi ancestrali: al capo branco, a solidarietà cieche, a riti di iniziazione.
Marco D’Amore, recupera un libro di Ermanno Rea: “Napoli ferrovia”, e mette in scena una storia complessa, e densa, anche nella sua ricerca grafica e stilistica; anche nei suoi azzardi narrativi, di piani temporali che s’intrecciano e si confondono e che rendono l’intero film una costante sfida con lo spettatore, un continuo spiazzamento che vortica sul filo della follia, dello straniamento.
Marco D’Amore sceneggia, dirige ed interpreta “Caracas”, riempiendolo di urgenza comunicativa, dirigendo la luce sulle contraddizioni, dalle quali non emerge una chiave di lettura della storia, o di Napoli, o della parabola vitale di Giordano Fonte – un Toni Servillo che, ancora una volta, inventa per sé stesso un nuovo registro espressivo, sospeso tra sogno e ricordo, e realtà, troppo vivida e dura, per essere sopportata – ma una voglia di racconto, forse persino eccessiva; rigorosa però, nella sua scelta di non giudicare mai, i suoi personaggi, e di non commentarli, o rappresentarli in modo univoco e monocorde.
Marco D’Amore, prende la sua storia e la offre, mentre si fa, davanti ai nostri occhi, lasciando a noi, la scelta, persino dei finali possibili, o delle possibili letture della storia, che di per sé registra in noi sin da subito un proprio sfasamento temporale, visto che è stata raccontata da Rea circa sedici anni fa, individuando però già alcuni nodi con cui ancora oggi ci confrontiamo, e noi ce la ritroviamo illustrata come se fosse stata scritta ieri, con tutto il carico sottinteso di cambiamenti veloci che hanno attraversato la storia d’Italia, e del mondo, in questi ultimi sedici anni.
Di “Caracas”, il personaggio che dà il nome al film, non sappiamo la nascita e non sappiamo la storia, che, in taluni momenti, pare invocare con forza la propria inesistenza; il proprio essere uno specchio deformato nel quale lo scrittore tornato a Napoli ( Giordano Fonte/Toni Servillo/Ermanno Rea ), si specchia, riconoscendosi.
Forse è un orfano, troppo buono, fuggito dall’orfanotrofio e che, per difendersi dalla solitudine e dall’assenza d’amore, diventa cattivo, e violento, trovando rifugio nelle catacombe in cui costruiscono un proprio mondo alieno, fascisti e nazisti di oggi. Ansiosi di mostrare la propria alterità coi propri tatuaggi e coi propri riti e con la propria violenza, motivata dalla difesa della cristianità, e della civiltà occidentale, con la quale peraltro il fascismo vero, non solo aveva poco da spartire, ma ne era ignorante avversario.
Il fascismo come rifugio per ancorarsi a certezze che la modernità e la complessità del mondo mettono profondamente in discussione. Il fascismo come protezione dal male che è fuori di noi. Il fascismo che si presenta come una tentazione forte di abbraccio protettivo, di fronte al quartiere che cambia, sotto la pressione dei nuovi cittadini arrivati dall’estero, con le loro culture; con le loro religioni ed usanze; persino con il loro ripercorrere, dalla povertà alla possibilità di un futuro, le strade che già il popolo, e i poveri di Napoli, avevano compiuto dopo il Secondo Dopoguerra.
E’ questo il fascismo, compreso il suo male irriducibile, che indaga Ermanno Rea, e che Marco D’Amore mette in scena, colorandolo di modernissime contraddizioni, concedendosi però, qualche ammiccamento alla propria storia di Ciro l’Immortale ( come nella scena iniziale in cui sopravvive ad un atterraggio, col paracadute ).
Il personaggio di Caracas, si trova a diretto confronto qui, con quello che dovrebbe essere un proprio nemico strutturale: l’Islam ( anche se lui ascolta in televisione i deliri retorici di Mussolini indirizzati contro la perfida “razza ebraica”), ma verso di esso, anziché il livore del sentirsi invaso, prova una fortissima attrazione, che non è solo per la ragazza musulmana in lotta con la propria identità religiosa – in nome della propria possibilità di entrare dentro le meraviglie della civiltà dei consumi, dalla cui libertà, anche sessuale, è conquistata, cadendo però, con l’eroina, nei suoi eccessi nichilistici e autodistruttivi – ma per la sua tendenza radicale all’assoluto e alla purezza.
Caracas trova nell’Islam quella concreta capacità di aiutarsi che è propria spesso di comunità chiuse, e che difendono sé stesse dal confronto con l’esterno ( al di là della positiva valenza, comunque, dell’aiuto reciproco ).
Significativo, mi pare che inneggiare al duce, dentro l’accolita fascista che si carica per un attacco violento ( una sorta di “notte dei cristalli” contro i negozi degli stranieri, con devastazioni e violenti pestaggi ), sia rappresentato allo stesso modo in cui si festeggia la presa del potere in Afghanistan da parte dei Talebani, dopo l’abbandono del paese da parte dell’esercito USA nel 2021, peraltro, usando – se non ho mal compreso – la parola “huriya” che significa “libertà”. Proprio mentre invece, quello che si afferma è la moderna incarnazione di un fascismo, da parte di una teocrazia, per la quale la parola “libertà”, e la parola “dittatura”, applicata con le armi da una morale imposta, sono, nei fatti, sinonimi.
Una rappresentazione plastica di come oggi, le ideologie, anche religiose, siano permeabili, e abbiano da sé allontanato l’assillo della coerenza, in nome solo della possibilità di tutto in sé comprendere e fornire così una rassicurazione identitaria costante ai propri aderenti.
Della civiltà occidentale, è proprio la sua caratteristica fondamentale, a restare fuori dalle possibilità esistenziali di chi sente fortissimo il richiamo dell’autorità assoluta e indiscutibile: la percezione del limite e della propria costante ricerca, in assenza di certezze definitive. E’ questo, a fare paura; ed è contro questa paura che ci si affida alla religione e all’ideologia autoritaria e totalitaria.
E questo grumo di esperienza odierna, lo scrittore che avrebbe voluto smettere di scrivere, incontra ed indaga, mentre ritrova sé stesso in una Napoli che pare essere immobile e che invece cambia continuamente, anche quando perde l’odore del proprio mare.
E questo intreccio di vitalità e di paura, rimette in discussione le volontà dello scrittore che, come in una trance ipnotica, insegue per Napoli i suoi personaggi; le loro diverse età, ed il proprio passato stesso, e Marco D’Amore, con grande intraprendenza, ci mostra l’incedere della storia, mentre essa vive, e si fa, con le sue sospensioni, le sue incertezze, le sue possibilità diverse ed alternative e persino con le sue citazioni da commedia scarpettiana, quando lo scrittore riesce ad intrufolare una brigata di svelti guaglioncelli, dentro il suo lussuoso albergo, facendosi forza del proprio status di “Maestro”, nei confronti del portiere che dovrebbe sorvegliare l’ingresso, e che invece in un’altra scena che racconta, questa sì, forse, una realtà, lo sveglia, parzialmente, mentre è travolto dal vortice della scrittura e da giorni, immagina la sua storia e la scrive, e la vive nella sua stanza d’albergo devastata.
Lo scrittore qui, rincorre la propria identità che, mentre la vecchiaia sembra aver cristallizzato nel rifiuto a continuare, la materialità della città invece, stimola ancora a raccontare, indagare, inseguire, mischiarsi.
Una grande storia, che meriterebbe un gran finale.
Ma la vita ha le sue strade. Certe volte consentono la redenzione e la felicità; altre permettono, forse, solo la redenzione, ma senza alcuna felicità.
E lo scrittore, s’allontana, dai suoi personaggi.
Recupera la propria funzione di costruttore di storie, che non chiedono commento, o spiegazioni, ma restano negli occhi di guarda, e scolano, come una notte di pioggia, o come il sangue che esce dopo una coltellata.
Marco D’Amore, non giudica i suoi personaggi, ma tutti li guarda con comprensione umana, salvo che per l’oscenità della violenza gratuita e profanatrice.
Forse il bisogno di raccontare in alcuni momenti tradisce qualche ansia e la necessità d’ancorarsi a citazioni di grande cinema o di grande fiction televisiva, e però è ancora alle prime prove cinematografiche e le possibilità di crescita, a me sembrano davvero grandi.
Io ho visto un film importante.
A margine, vorrei solo dire che il biglietto per vedere un film, a 8,50 euro, è un sicuro viatico per farli chiudere, i cinema.
Con due biglietti, oggi, ci si paga un abbonamento mensile ad una piattaforma che consente di vedere, a qualsiasi ora del giorno e della notte, secondo nostro capriccio, centinaia e migliaia di contenuti d’intrattenimento o d’informazione.
Bisogna abbassare i prezzi, e riempire le sale.
Così come è la situazione oggi, confina il futuro del cinema ad una élite sempre più ristretta di persone , peraltro in una condizione in cui sarà possibile realizzare un numero sempre minore di opere, da parte di artisti e lavoratori dello spettacolo.
E questa a me sembra una enorme perdita di libertà; oltre che una follia sul piano economico, industriale e, soprattutto sociale e culturale.