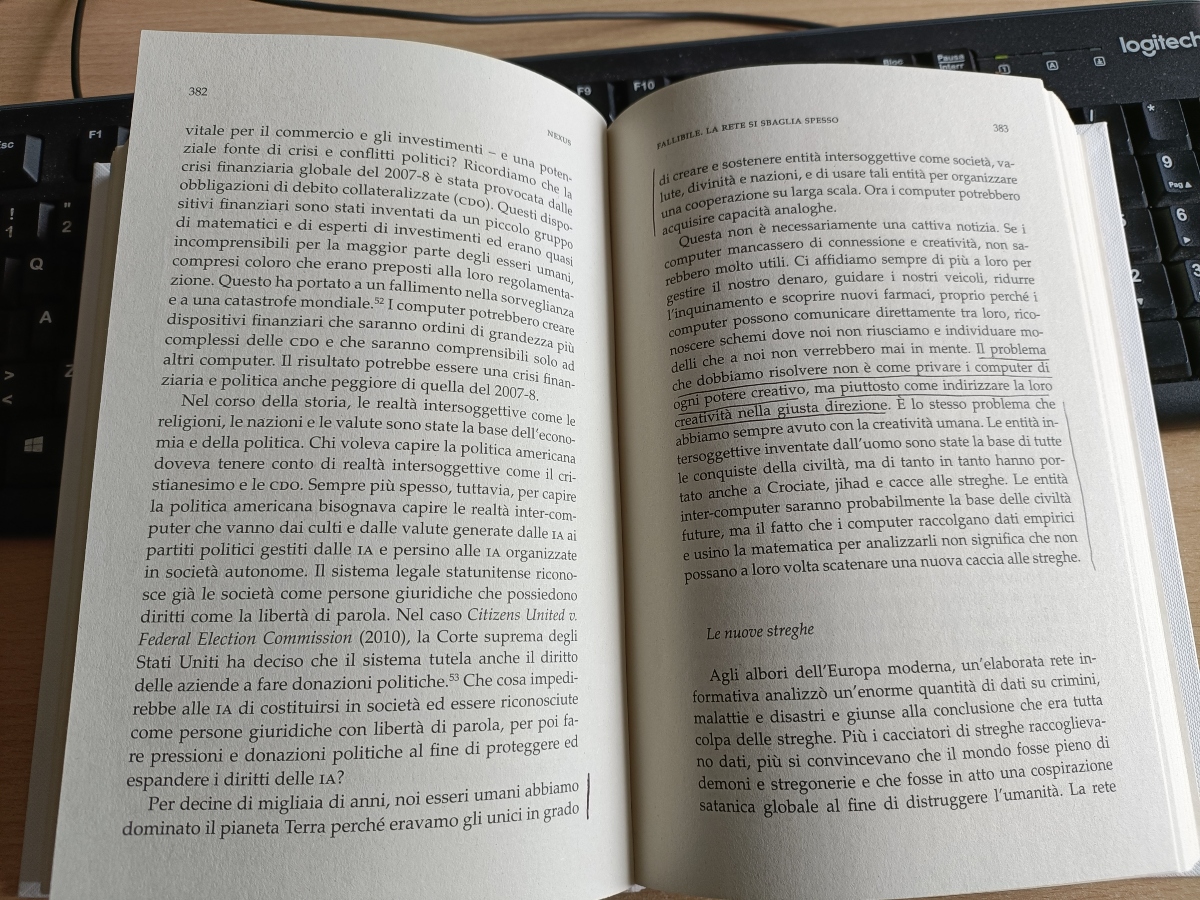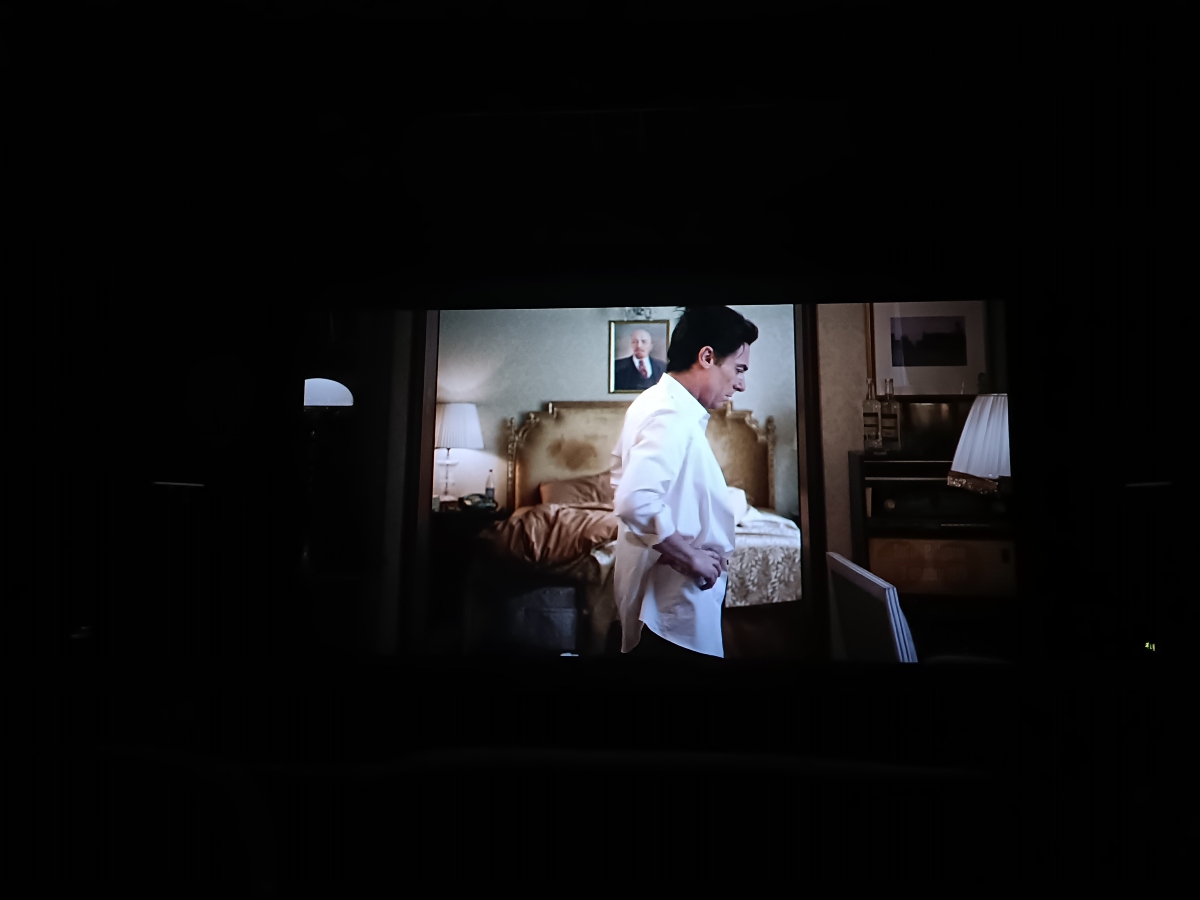L’alluvione di immagini, di informazioni, cui possiamo accedere; la ripetitività degli stimoli e dei richiami; la tendenza ormai affermatissima, a mettere in dubbio la veridicità di ciascuna delle immagini, e delle informazioni cui abbiamo accesso e il conclamato uso propagandistico, spesso occulto, di quelle stesse immagini e informazioni che ci inseguono, qualunque sia il mezzo che usiamo: social, televisioni, giornali, radio, newsletter etc, in larga parte, produce in noi anestesia ed indifferenza.
Talvolta qualcosa buca il muro del potentissimo rumore di fondo cui siamo sottoposti, e s’impone alla nostra attenzione, spessissimo, per indurci a schierarci, da una parte o dall’altra, perché quasi tutte le informazioni cui abbiamo accesso “valgono”, solo se polarizzano, se inducono interazione, rilancio, condivisione, dibattito, e insulto; e l’insulto stesso e il rumore mediatico stesso, diventano notizia ed informazione: spessissimo per indurre in noi una risposta emozionale, il più istintuale possibile, e non razionale.
In tutto questo, in larga misura, s’è smarrita la gerarchia d’importanza di una informazione. Un cane bruciato vivo, fa più rumore mediatico di intere categorie sociali che evadono sistematicamente le tasse nel nostro Paese. E forse è una scelta, perché questo accada in questo modo.
Se posso permettermi la radicalità di una affermazione, la quasi totale indifferenza che riguarda la sorte dei bambini, nelle guerre che stiamo vivendo, almeno in quelle che stiamo vivendo più vicine a noi – in Ucraina e in Medio Oriente, per non parlare di quel che accade alle bambine in Afghanistan – è testimoniata anche dall’uso social che viene fatto delle immagini di bambine o bambini morti o traumatizzati, che a me appaiono essere sostanzialmente esposti su un banco del mercato, cercando di lucrare attenzione, senza nulla aggiungere alle cause che si vorrebbe porre all’attenzione di chi le guardi.
Quanto suona distante, allora, un uomo, un semplice uomo che definisce sé stesso “socialista, agnostico, di lontane origini ebraiche”, che, guardando quel che accadeva nel suo mondo – distantissimo dal suo status di operatore di Borsa nella Londra dei tardi anni ‘30 dello scorso secolo – sente dentro di sé l’urgenza d’agire, in prima persona, nel deserto dell’indifferenza della politica ufficiale, per dare riparo e salvezza, ai bambini cecoslovacchi, molti dei quali ebrei, su cui si sta già abbattendo, e sta per abbattersi in modo definitivo, la tremenda ferocia della guerra che Hitler stava aprendo nel cuore dell’Europa.
Nel 1938, a Monaco di Baviera, Francia e Gran Bretagna accettano che Hitler possa annettere alla Germania una parte della Cecoslovacchia, i Sudeti, cedendo alle sue mire espansionistiche travestite da preoccupazione per le minoranze tedesche lì residenti. Il giullare Mussolini, che voleva evitare guerre ad ogni costo, data la sua impreparazione strutturale, nonostante la retorica guerrafondaia, si autoattribuisce la palma di “pacificatore”, per il sostanziale cedimento di Francia e Gran Bretagna alle pretese naziste. Hitler fa penetrare le sue truppe, che occupano la regione, causando, tra l’altro, decine di migliaia di profughi; intere famiglie con bambini che cercano rifugio a Praga, in condizioni di disperato abbandono.
Suona familiare, oggi, questa situazione ?
Suona familiare a quanti predicano la pace con Putin ? La storia non torna mai, sui suoi passi, ma indica delle tendenze, avverte dei pericoli. Dovrebbe farlo. Nonostante il mutare delle condizioni, le analogie restano impressionanti.
Nicholas Winton, interpretato da uno strepitoso sir Anthony Hopkins, è un uomo comune. Qualsiasi uomo comune, possa venire in contatto con un campo profughi, non può, io credo, non restare toccato, nel profondo della propria umanità, dalla sofferenza di bambine e bambini che s’accalcano intorno a lui per ricevere una piccola scaglia di cioccolato, di cui mai, può esservi abbastanza. I gesti semplici, come quelli del tendere la propria mano per aiutare qualcuno in difficoltà, sembrano essere oggi divenuti indicibili; irrappresentabili.
Prima di tendere la mano, bisogna essere informati su chi abbia ragione o torto; su chi porti su di sé colpe storiche, o sia innocente. Su chi sia svogliato, oppure complice di una situazione. Oggi, prima di tendere la mano, spesso, si fa ben bene di conto su quale sia il proprio interesse; la propria convenienza, ad ogni livello.
Suona forse un po’ familiare ? In un tempo in cui i campi profughi sono una triste consuetudine. In Libia, in Siria, in Kurdistan, in Afghanistan, in Armenia, in Libano, ovunque…
Oggi, l’idea che attraversa la società, è che chi abbia bisogno, abbia bisogno perché ha colpa, di qualcosa. Magari del solo fatto d’essere nato.
E invece in passato, c’era quest’uomo, non l’unico certo, per fortuna, cui basta guardare, per sentire dentro di sé la necessità di agire. Un imperativo morale.
Ed è singolare, come in un mondo in cui il fragore delle armi si sentiva bene, e ben era presente, il primo punto, dal quale partire per aiutare dei bambini, rispetto ai quali nessuno dovrebbe nemmeno porsi delle domande, sia costruire per loro una condizione burocraticamente sostenibile e credibile.
Per salvare delle vite umane preziose, come quelle dei bambini, e delle bambine, si devono ottenere timbri e definizioni; devono essere depositati dei soldi in cauzione; si deve sollecitare la privata carità di famiglie disponibili a farsi carico dei minori, dando loro la possibilità di “sceglierseli”. Winton inventa una modalità burocraticamente credibile per salvare dei bambini dall’orrore che sta per abbattersi su di loro.
Non suona familiare ?
In tempi in cui i minori non accompagnati sono una specifica figura burocratica tra i migranti dei nostri giorni, e la loro stessa esistenza si presta non ad interrogativi sulla loro reale vita, ma a polemica politica, a business, a strumentalizzazioni, e arriva all’occhio attento della criminalità organizzata che da ogni occasione sa trarre schifoso profitto. In tempi in cui nella nostra città l’unica preoccupazione che ci interessa rispetto ai minori stranieri, è se possano essere un problema per la sicurezza della comunità, e non la loro condizione materiale e spirituale, o le condizioni in cui operano le comunità che li accolgono.
In tempi in cui la fuga dalle guerre in corso, è considerata una colpa, come quella dei migranti respinti in mare in Grecia, o bloccati dalla Turchia, coi soldi dell’Unione Europea, che così chiude tutti e due gli occhi sulla dittatura di Erdogan, o fermati dalle recinzioni in Polonia, o in Ungheria.
In tempi in cui un Presidente del Consiglio dei Ministri contratta una improbabile deportazione in Albania dei migranti cui chiedere coattivamente di pagarsi le spese del ritorno in patria.
La condizione umana, e quella dei bambini in particolare, è ignorata, nell’indifferenza ostile di molta parte della pubblica opinione, e nella assurda sottovalutazione operata dalla politica che non si interroga sulle nuove forme che assume il mondo, e per esse non cerca soluzioni che mettano al primo posto la salvezza della persona, la sua dignità, il suo diritto al futuro.
E quanto può suonare familiare, e stridente, oscenamente stridente, il racconto di un uomo, e insieme a lui di altri uomini e donne, che mossi solo dall’imperativo morale, rischiano sè stessi per salvare vite innocenti, mentre lo stato di Israele, nato dopo l’immondo Olocausto di ebrei, sinti, rom, omosessuali, oppositori politici, slavi e portatori di handicap, non ha alcuna cura, nel muovere guerra a quelli che considera suoi nemici, di salvaguardare le vite innocenti di donne e bambini, mentre bombarda Gaza. Quale Giardino dei Giusti, ci sarà a Yad Vaschem per i bambini palestinesi ?
Non si consuma un Olocausto, a Gaza.
Ma un orrendo criminale massacro ad opera di una setta fondamentalista di destra che ignora le garanzie che chiede per sé stessa.
Il film che ci racconta la normalità del Bene, ci racconta persino dell’incredibile paradosso dell’uomo che va ad offrire la sua storia alla libera stampa, e trova le porte chiuse, mentre invece un programma di televisione sensazionalistica, che siamo abituati a considerare dispregiativamente, ha invece l’acutezza di comprendere la portata della vicenda che ha dinanzi e la spinge ai suoi esiti più emozionanti e forti, coinvolgendo il mondo, e svelando una storia nascosta che fa onore, non solo agli uomini e alle donne che l’hanno resa possibile, ma all’intero genere umano, che dei gesti e delle azioni di umanità si fregia, per distinguersi dalla ferocia animale, innocente, peraltro, perché tesa al solo soddisfacimento dei propri bisogni primari.
La regia di James Hawes, che aveva tra le mani una vicenda così potente, riesce a non nuocerle, ma a porsi al servizio di essa, e dell’understatement del suo protagonista, a distanza di decenni, ancora incredulo, di cosa abbia potuto compiere, ancora disperato, per non aver potuto portare a termine la propria missione. Un film che racconta, con grande delicatezza l’umanità migliore, mentre tutto intorno a noi si fa sentire l’orrenda puzza di morte che sembra affascinare questo nostro tempo, già dimentico dei milioni di morti di soli ottanta anni fa.
E’ la madre di Winton, interpretata nel film da Helena Bonham Carter, che davanti al burocrate ministeriale, offre la propria intransigenza capace di azioni eclatanti, a sbloccare la possibilità di salvezza per centinaia di bambini, e io non so immaginare Winton, e sua madre, di fronte alla politica inglese di oggi, che costruisce piattaforme galleggianti, dove stoccare il materiale umano residuo delle migrazioni, per poi deportarlo in Africa; e non so immaginare l’egoismo insensibile di tanta parte delle nostre società oggi che, invece di porre a sé stesse, l’interrogativo su come rendere migliore la propria vita e quella degli altri, pensa che la propria sfruttata vita possa essere mantenuta un gradino sopra la soglia della decenza, solo contro, gli altri.
“One life”, è un film che emoziona. E mi pare tanto.