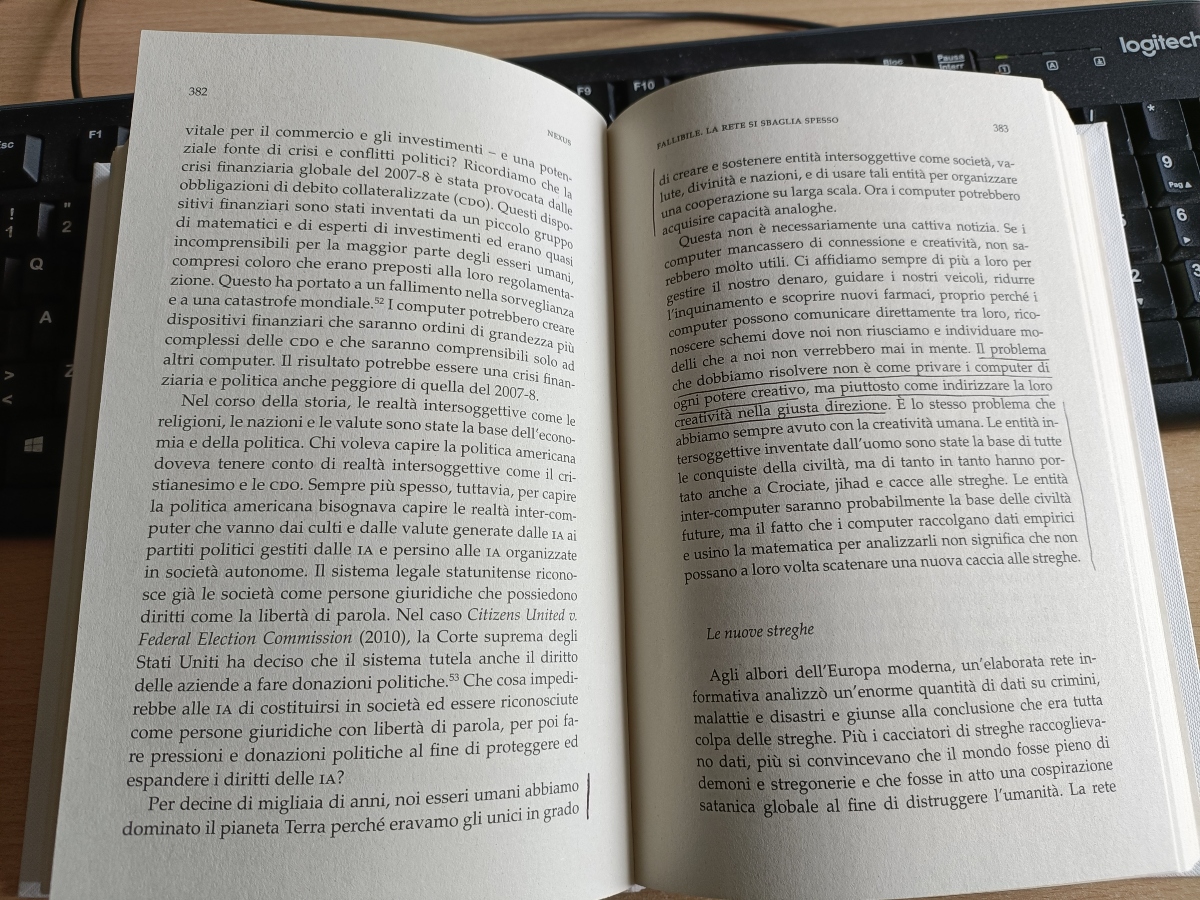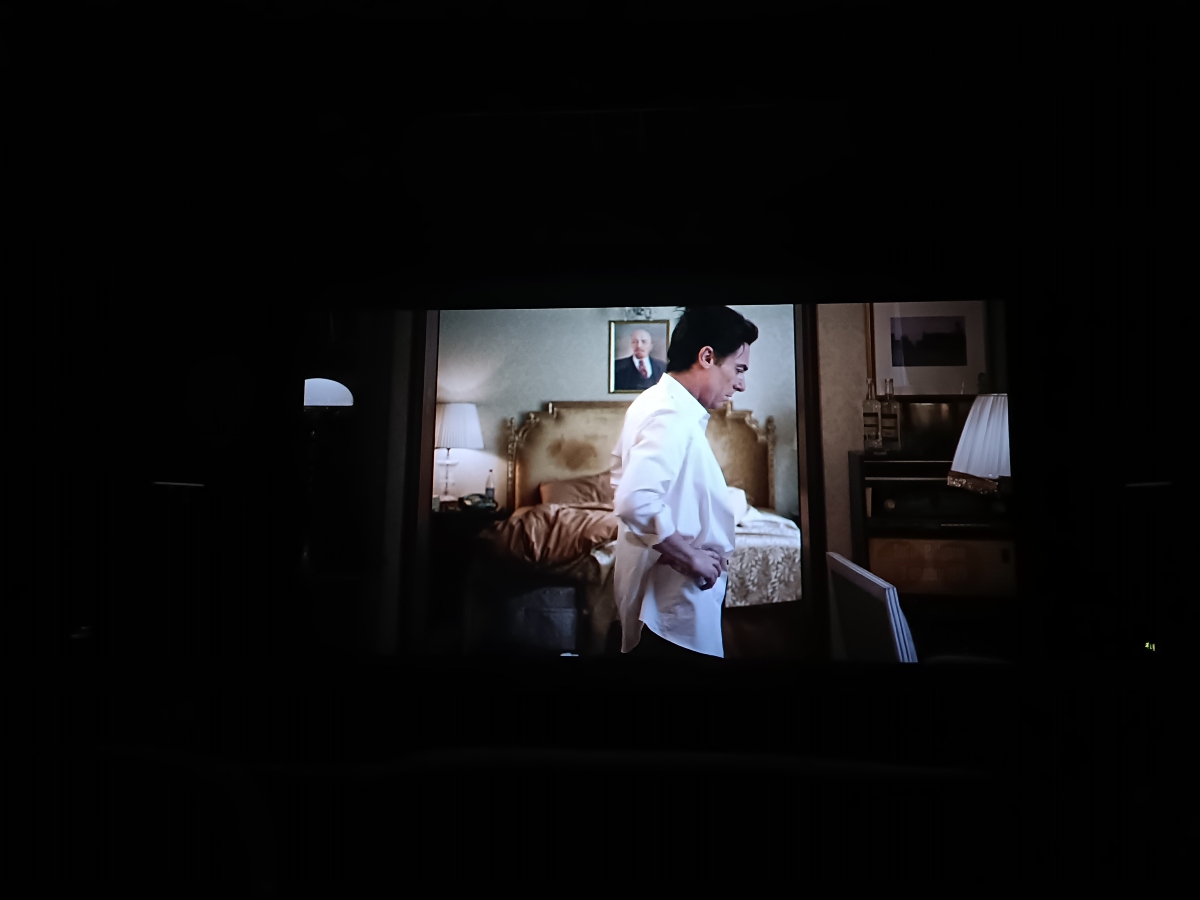Nell’”Opera da tre soldi”, di Bertolt Brecht, si scrive: “ Che cos’è un grimaldello, di fronte ad un titolo azionario ? Che cos’è l’effrazione di una banca, di fronte alla fondazione di una banca ?”
Non so se Antonio Albanese, nel suo film “Cento domeniche”, abbia avuto presente questi versi, spesso ripetuti e rielaborati, ma penso che si sia confrontato, in profondità, con una serie di meccanismi molto evidenti, nella nostra società, ma visti molto chiaramente, ( anche se non poteva, all’epoca, prevederne tutte le implicazioni e articolazioni ), solo da Pierpaolo Pasolini, e poi pressochè ignorati, nel discorso pubblico e nell’attenzione degli intellettuali, negli ultimi decenni; tanto da farci trovare impreparati a comprendere una serie di dinamiche, ancora in atto, e che hanno antropologicamente mutato il nostro modo di essere.
Antonio Albanese costruisce una drammaturgia progressiva, sempre più claustrofobica, partendo da un dato, direi sociologico: lo stratificato sentire, pensato giusto e apparentemente tra tutti diffuso, di una piccola comunità; pensato come “naturale”, come assolutamente appartenente cioè alla cultura di un’area geografica precisa del Paese, che potrebbe essere la provincia lombarda, o veneta, ad esempio, e ne esplora, lentamente, le contraddizioni ed i lati oscuri.
Questa concezione del mondo, e della vita, e del ruolo dell’uomo, nel mondo e nella vita, si articola in una serie di capisaldi.
A partire dalla coscienza del valore del proprio impegno nel lavoro. Il protagonista del film, interpretato da uno splendido Antonio Albanese, pare essere il figlio di una antica cultura contadina ed artigiana insieme, sempre pronta ad intervenire, per dare ordine e misura alle cose, ma anche a sentirsi parte integrante di un mondo produttivo, nel quale la subordinazione alla proprietà d’impresa è sentita e vissuta con la stessa “naturalezza”, con cui ci si senta legati agli anziani della propria famiglia, ai genitori. Non c’è spazio per una rivendicazione collettiva, o per una coscienza sindacale che renda chiara la differenza d’interesse materiale tra proprietà d’impresa e Lavoratori; è introiettata anzi una diffidenza di fondo per l’autorità statuale che chiede il rispetto di astratte leggi e regole, incomprensibili, per chi trovi naturale prestare il proprio lavoro, anche gratuitamente, dopo il pensionamento.
E nasce da qui, da questa introiezione del valore fondante e “naturale” della gerarchia, l’idea che quelli che appaiono come principi morali, e certi modi di comportarsi, non possano essere messi in discussione: che le scelte di chi diriga un’impresa, o una banca, siano “naturalmente” benevole nei confronti di chi sia sottoposto. Non c’è bisogno di sapere, in una società che trova “naturale”, smettere di studiare a sedici anni, ed andare a lavoro per guadagnarsi da vivere, e migliorare, il più possibile, il proprio benessere materiale, quale unica misura del proprio essere parte di una comunità.
Studiare, ed informarsi, implicitamente, parrebbe persino mettere in discussione, la relazione che ci lega a chi ci paga lo stipendio, o amministra i nostri soldi, così oculatamente, da consentirci di affrontare le scelte della quotidianità, a partire dall’affrontare le spese per il matrimonio della propria unica figlia, con tranquillità assoluta; anzi, nonostante si sia genitore divorziato, il modello educativo, e culturale, che in ogni modo si è provato a trasmettere, è quello della famiglia tradizionale, e nella quale le tradizioni sono rispettate, a partire dall’obbligo per il padre della sposa di assumersi le spese del matrimonio.
Ed ecco allora che un piccolo mondo, in cui equilibri e relazioni, sono percepiti come immutabili ed indiscutibili, subisce, d’improvviso, l’impatto della finanziarizzazione dell’economia.
Di quella idea cioè, secondo la quale, la ricchezza, ed il benessere, si staccano dal mondo della materialità, della produzione fisica di un bene o di un servizio, ed entrano dentro un sistema dove è solo il denaro a contare; dove è solo la continua, inesausta, indifferente accumulazione di denaro, a contare. E questa idea, diviene una rivelazione, che squarcia il velo delle nascoste differenze di classe, e rende esplicito che ci sono alcuni che sfruttano, e tanti che sono sfruttati.
Ma per gli sfruttati, la rivelazione è ancora più amara e catastrofica, perché non si abbatte solo sulle loro condizioni materiali, e sulle loro certezze, ma proprio su quel sistema di valori che, mentre era vissuto come giusto, era in realtà una velenosa falsa coscienza che consentiva la pace sociale in un sistema che, comunque, prevedeva sempre che ci fosse chi godeva di profitti, e chi doveva lavorare per allargare quei profitti.
Aver lavorato tutta una vita, non assolve neanche lo sfruttato, o l’artigiano, che in ogni caso guardavano al sistema, e alla banca garante di quel sistema, come ad una inesauribile possibilità di benessere materiale, persino quando modesto, senza attriti, senza conflitto, e senza che fosse mai esplicitato che in quel benessere materiale ci fosse già, una parte perdente, ed una vincente.
La regia di Antonio Albanese dipana la storia con precisa coscienza dei suoi momenti di svolta e di cambiamento, mostrandola come un cielo chiaro che, sempre più si raggruma di nuvole, prima di scaricare una tempesta indifferente: quella del denaro, che premia sempre i più ricchi e sempre i più poveri colpisce, e nella quale, nonostante si sappia con assoluta certezza chi sia vittima, non si può, fino in fondo simpatizzare con le vittime, complici, in una certa misura di quel sistema cui avevano ideologicamente aderito, fino a che consentiva loro una tranquillità materiale che non richiedeva di farsi domande.
Quel sistema giustificava anche l’uso delle armi, nella forma della caccia, ribadendo, anche per questa via, la sua gerarchizzazione. L’uomo, anche il subordinato, può comunque scaricare sulla natura la propria ansia di potere e di controllo; può esplicitarne, uccidendo senza responsabilità, le forme del proprio dominio.
Le armi, però, sono solo uno strumento, anche se mortale, e, come tutti gli strumenti, si prestano a molteplici usi, e, quindi, anche l’idea che possa essere “naturale” mangiare una polenta con gli uccelletti, contribuisce al divenire sempre più ferrigno della condizione del protagonista e della comunità insieme, che, non l’umana avidità, ma il progressivo stringersi verso le sue estreme conseguenze di un sistema, quello capitalistico, conduce sempre più allo stato di residuo, di scarto di un processo i cui effetti benefici, stavolta, possono liberamente essere concentrati nelle avide mani di chi, senza mai comparire, governa processi globali del tutto insensibile a qualunque considerazione morale. Nessuna coperta ideologica, da pietosa Democrazia Cristiana, ha più bisogno adesso di celare e redistribuire, sia pure in minima parte, la ricchezza che pure si creava.
Ognuno è solo, e ognuno prova a salvarsi anche divenendo parte di un sistema colpevole, senza ribellarsi, senza disobbedire agli ordini; e sarebbe interessante una statistica che metta a confronto il numero di quanti, all’interno del Terzo Reich, si ribellarono al nazismo, col numero di quanti, dentro il sistema capitalistico governato dalle banche e dalla finanza, ad esso si sia ribellato: temo che avremmo tutti delle sorprese assai sgradevoli.
Di rilievo mi pare anche la costruzione umana del personaggio del protagonista operata da Albanese. Un uomo che pare assumere sempre su di sé, intera, la responsabilità delle cose che gli accadono. Si chiede, e chiede agli amici, urlando, se possa egli considerarsi colpevole di quel che gli accade. Ma già conosce la risposta. E’ la risposta che danno a sé stessi le persone che non cercano giustificazioni o scorciatoie. E che finiscono, a torto o a ragione, con l’incarnare per intero il peso di una vicenda. Fino alle conseguenze più estreme. Senza apparentemente ribellarsi ad esse, ma anzi offrendosi quasi come capro espiatorio.
E’ quello che succede alle persone buone. Non sante, o speciali.
Solo buone, cui, quando crolla il mondo che li teneva in vita, non avvertono più un senso, nel vivere.
Una ultima considerazione, credo importante.
Nella stagione del film di Paola Cortellesi, il film di Antonio Albanese non ha avuto lo stesso impatto e lo stesso successo.
Si potrebbe lungamente disquisire sulle capacità realizzative dell’una, o dell’altro; o sui meccanismi perversi della distribuzione cinematografica; o sul tempismo dell’una, o dell’altro, rispetto alle questioni sociali che pongono, ma, temo, che la verità sia un’altra.
Temo che ciascuno di noi sia come il protagonista del film di Antonio Albanese.
Una persona che abbia la percezione della immutabilità della realtà, e ad essa aderisca, o di essa sia rassegnata. Una persona che non creda più, che le cose possano andare diversamente. Una persona che dia come dato “naturale” di realtà, la delocalizzazione delle imprese e un mercato finanziario senza vincoli o limiti di sorta, che premia solo il più spietato e sommerge tutti gli altri.
Voglio dire cioè, che quella mutazione antropologica raccontata da Pier Paolo Pasolini, è ormai ampiamente avvenuta, e forse siamo alla vigilia di una sua ulteriore torsione, determinata dagli effetti delle tecnologie comunicative, del cambiamento climatico e della cosiddetta intelligenza artificiale.
Da uomini, e donne, pienamente inseriti in una società del consumo, verso un mondo di uomini e donne, contenti d’essere servi. E i contenuti del film di Antonio Albanese, paiono essere già ampiamente metabolizzati e considerati anch’essi, il nostro “stato naturale”.