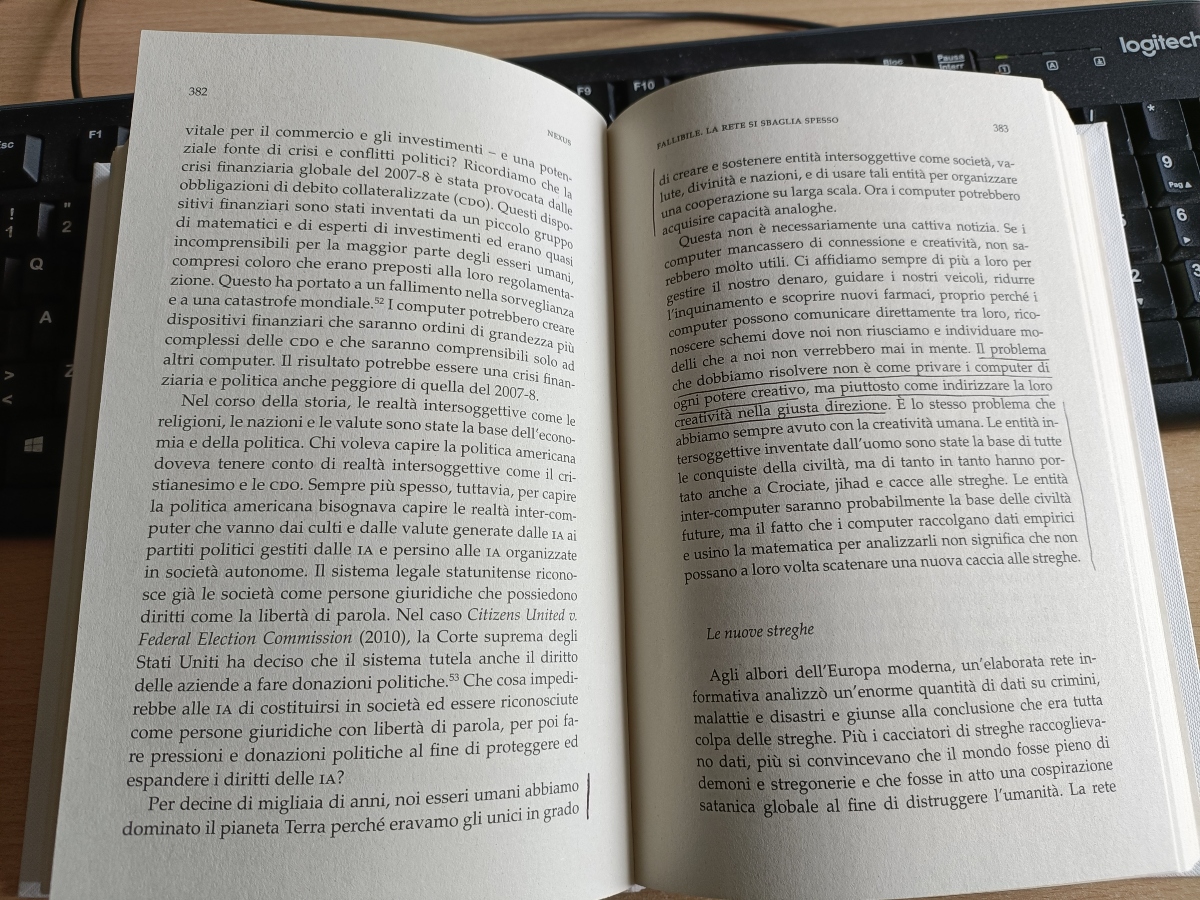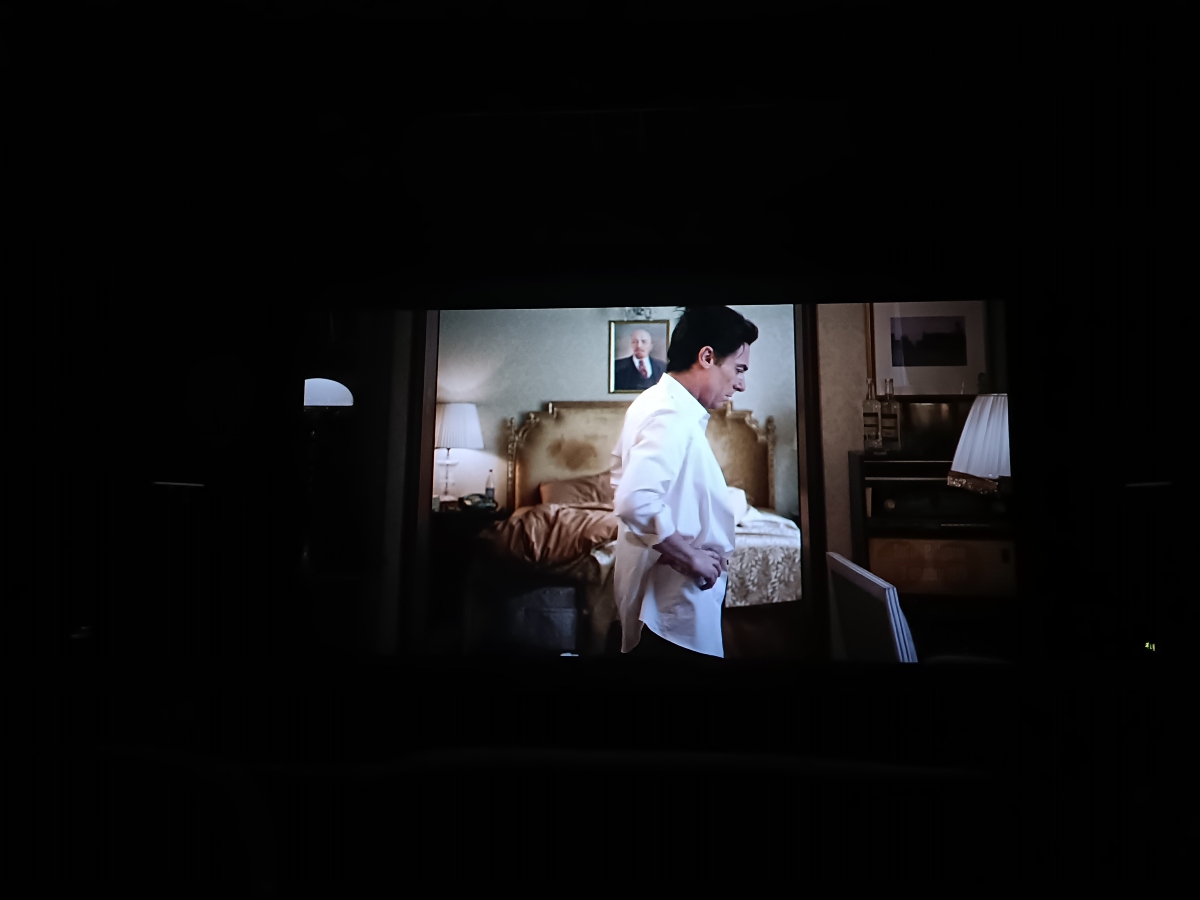Edward Hopper era un pittore americano, che espresse la sua arte, in particolare, nella prima metà del ‘900. Famosi i suoi scorci urbani; le sue immagini nette, e definite, e, nello stesso tempo, capaci di astrarre dalla pura materialità della rappresentazione; i colori saturi, quasi privi di sfumature.
Le sue figure umane, particolarmente quelle femminili, paiono segnate da una profonda malinconia; dall’attesa, finendo con l’evocare una assenza, più che la loro presenza talvolta fortemente carnale.
Tutto il film di Wes Anderson, sembra riprodurre le inquadrature di Edward Hopper; ma dove il pittore sembrava illustrare un giallo hard-boiled ( il cinema anni ‘40 americano, dei gangsters e delle piccole città di campagna che nascondono storie torbide ), il regista, coi suoi colori pastello, sembra sottolineare, per contrasto, la totale incapacità dei suoi personaggi di comunicare e mischiarsi tra loro. E quando il film vira sul bianco e nero di una fantomatica trasmissione televisiva, o del dietro le quinte di una rappresentazione teatrale, i suoi personaggi ancor più sembrano cercare il proprio autore, e la storia di cui sono interpreti, incapaci d’aiutarsi l’un l’altro; di evolvere.
E mentre il pittore scarnifica la scena che rappresenta, a pochi ed essenziali elementi geometrici, il regista invece, la carica di segni, di simboli, di richiami, di ricordi, che sembrano affollare una tavola barocca, e, contemporaneamente, nettissima, scolpita quasi, tanto da far somigliare i suoi attori a figure da fumetto americano degli anni ‘50, colmo di stereotipi e di fissità archetipiche.
La scena è attraversata periodicamente da una sparatoria tra due auto che corrono veloci, perdendosi verso l’orizzonte, senza che un qualche colpo produca degli effetti e senza che il loro passaggio turbi la trama della storia; come se le auto sostituissero i cespugli rotolanti di un cartone animato ambientato nel deserto, e proprio da quel cartone animato, esce il Beep Beep che pare cercare, per provocarlo, il suo Wile E. Coyote, che la storia però ci consegna, senza mostrarlo, ucciso ed abbandonato sul bordo di una strada.
E ogni inquadratura produce evocazioni.
Scarlet Johansson è adagiata in una vasca, accanto ad un gigantesco flacone di Chanel n.5, che non può non evocare Marilyn Monroe; e tutto il suo personaggio, è quello di un’attrice che cerca di fuggire dal proprio clichè di donna fatale, scostandosi costantemente da questa caratterizzazione, persino quando, compare una fugacissima e sfocata scena di nudo, che la storia stessa provvede a depotenziare di ogni carica sessuale, insinuando il dubbio, che ad essere ripresa, fosse una controfigura e non la notissima Midge Campbell.
Il fotografo di guerra, al quale “ogni foto viene bene”, parrebbe evocare quel giornalismo d’inchiesta americano, oggi totalmente depotenziato dai social, e, forse per questo, la sua foto più importante, quella di un alieno, non produce uno scoop giornalistico grazie alla sua tenacia, o alla sua etica libertaria; ma arriva alla stampa perché un gruppo di adolescenti, ha deciso di rompere le barriere che il potere costituito, vorrebbe alzare intorno ad Asteroid City, censurandone l’avvenimento dirompente della visita di una civiltà diversa dalla nostra.
E i ragazzi, uniti tra loro, sono l’unica forza viva del film, e l’unica forza in movimento; capace di dialogare, e nel dialogo mischiarsi e cambiare sé stessi e il proprio modo di essere, viziato forse, da quello spirito profondamente americano dell’accettare ogni sfida, sol perché grazie a quella sfida si diventa visibili: ai propri genitori, e alla società.
I militari dell’Esercito evocano un’America che ubbidisce, senza fare domande, e il gestore del villaggio di Asteroid City, evoca quell’America che è pronta a cavar soldi anche dal deserto, con l’aiuto di oscuri e mirabolanti strumenti finanziari.
E il nonno dei bambini, figli del fotografo di guerra, rimasti orfani, evoca quel patriarcato americano che assegna alla famiglia solo una funzione proprietaria.
E tutta la storia, che si svolge dentro i confini di un deserto che isola, e che è esso stesso il mondo, evoca persino il “Quarto Potere” di Orson Welles, e la sua indagine sul potere dei mezzi di comunicazione.
E l’incontro con l’alieno, si risolve nella constatazione, evocatrice, di una inattesa vicinanza terrestre; di una inattesa volontà burocratica che pervade ogni galassia e che tutto voglia controllare e catalogare.
Nella scena finale compare – una Margot Robbie per niente Barbie – un fantasma, forse, quello della mamma dei bimbi orfani, o forse un’attrice che interpreta un’attrice, in una scenografia da strada di Broadway, dalle cui insegne teatrali, scopriamo che si rappresenta, non “Morte di un commesso viaggiatore”, ma la “Morte di un narcisista”: magari lo sberleffo ultimo del regista, che ha passato un intero film a cercar di mostrare come si costruisca una storia, esilissima purtroppo, e come la si rappresenta in teatro, e come di essa si parla in televisione, mentre lui la sta mostrando in un cinema.
“Asteroid City” è un caleidoscopio che ubriaca l’occhio e confonde il senso dell’orientamento. E’ un’opera calligrafica che smonta la narrazione, senza però riuscire del tutto a narrarne il processo; è un quasi cartone animato in cui i personaggi si muovono come stereotipi che cercano, vanamente talora, di contraddire sé stessi; è una girandola di grandi attori e grandi attrici, al servizio totale di una idea di cinema che sta deragliando, forse, come accadde talora a Fellini, in Andersonismi troppo interessati a portare lo spettatore ad un limite, non sempre raggiungibile, di comprensione; oppure forse, fino al limite di godere del puro viaggio scenico e visivo, senza preoccuparsi di una trama o di coerenze narrative.
A me è sembrato, anche, un film che cercasse di rinvenire nell’America degli anni ‘50 dello scorso secolo, le radici dell’assenza di comunicazione di oggi; le radici dell’incapacità ad assumere il punto di vista dell’altro, di oggi; le radici dell’assenza di affettività e di empatia di oggi, le radici della noncuranza con cui si arriva al male, oggi ( quello spettacolo ricorrente del fungo atomico… ), ma per far questo, forse, occorre un nerbo da Commedia all’Italiana, che Wes Anderson, deve ancora conquistarsi.
E’ troppo pastello.
Dovrebbe essere più bianco e nero.