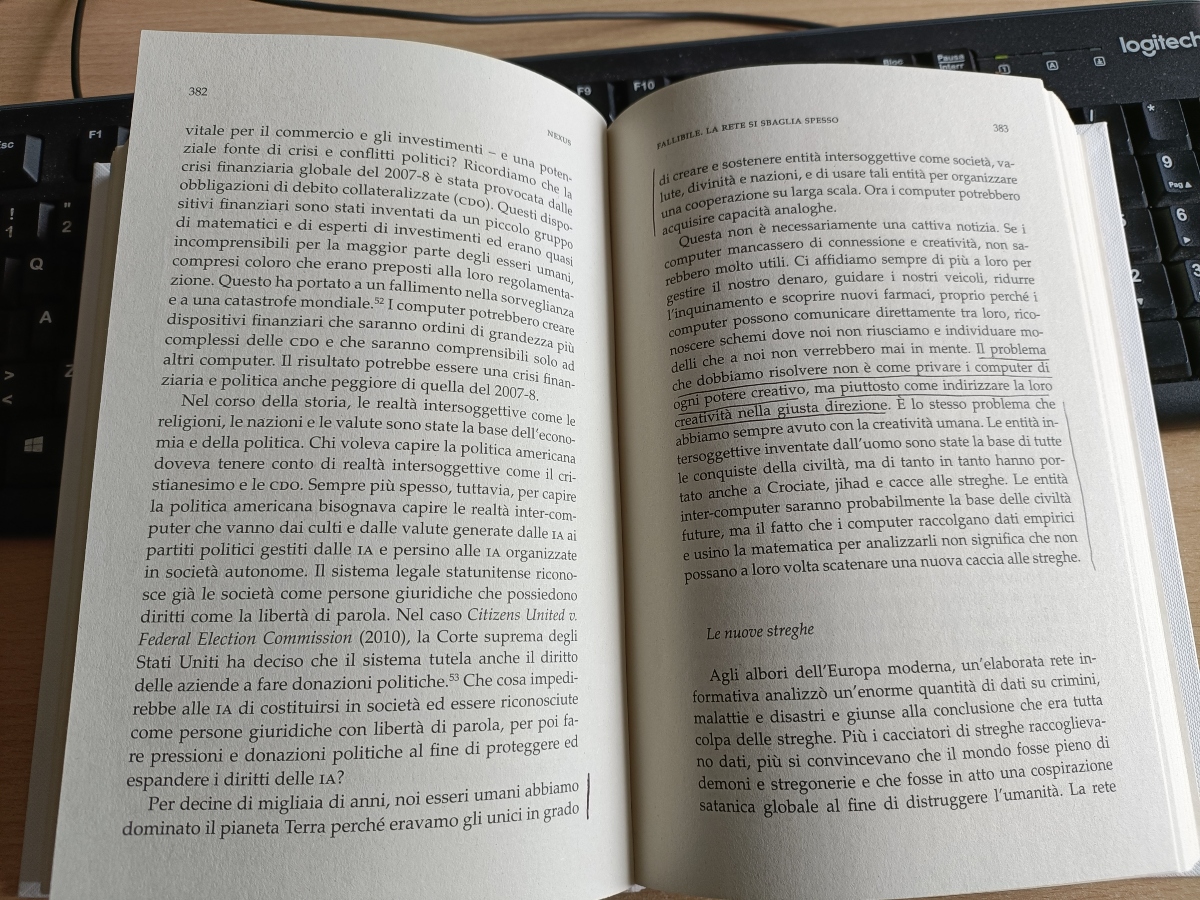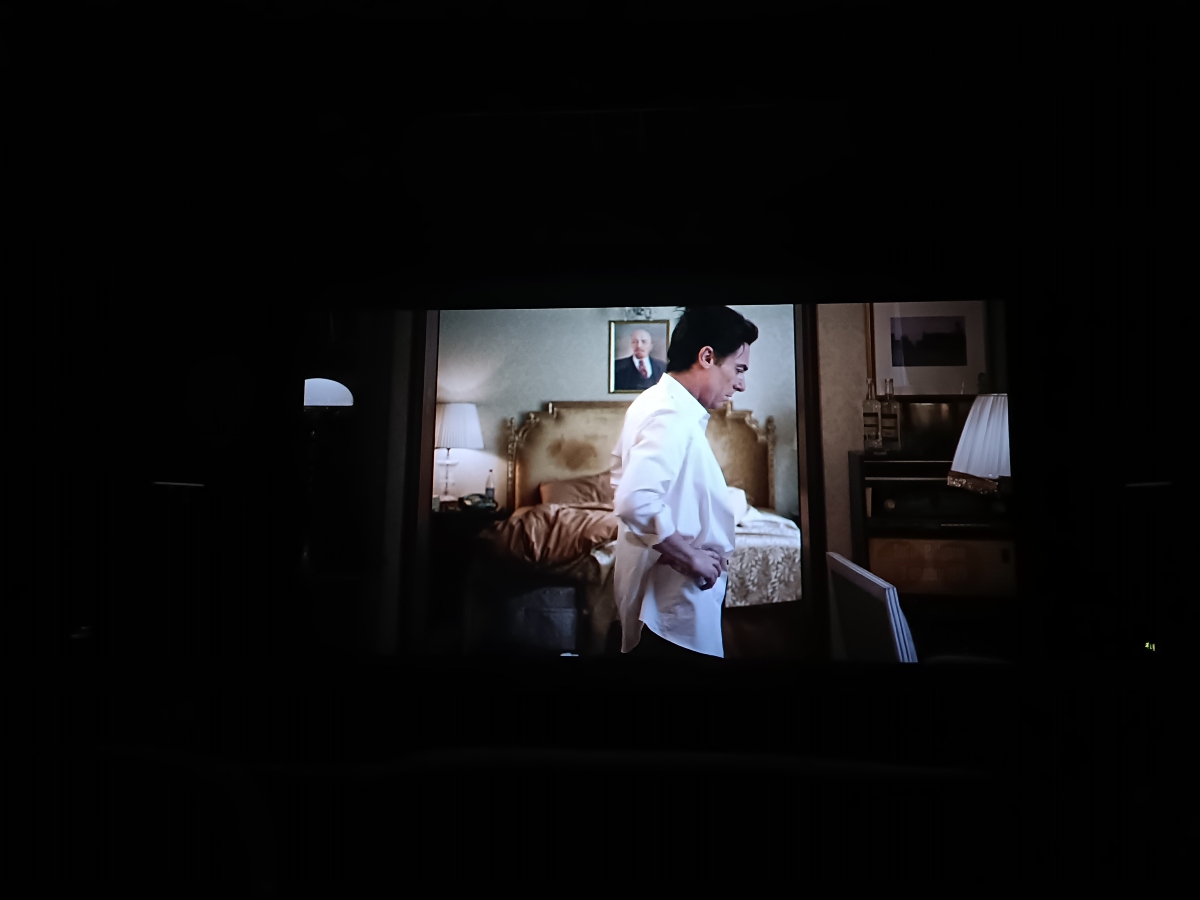Raffaella Carrà, nel 1974, interpreta il brano “Felicità Ta Ta”: è una delle sigle del programma televisivo “Canzonissima”. Il testo, è una specie di tiritera nonsense, scritta da Gianni Boncompagni, e si prestava benissimo ad accompagnare i balletti di Raffaella, al massimo del suo splendore, coreografata da Don Lurio, con una fantasia ed un rigore davvero speciali, dal punto di vista visivo.
Micaela Ramazzotti non era ancora nata, nel 1974. E sarebbe sicuramente interessante chiederle come, e perché, sia andata a recuperare quel brano di Raffaella Carrà, non solo per dar titolo al suo primo film da regista, ma, soprattutto, per usarlo come colonna sonora di una squallida esibizione dei genitori protagonisti del suo film: lui che canta, e si muove ammiccando, in modo del tutto imbarazzante ed inopportuno, dinanzi ad una platea di anziani malati in pigiama, forse all’interno di una Residenza Sanitaria Assistita; lei che lo riprende col cellulare, come se fosse di fronte ad una esibizione magistrale in un grande teatro ed avesse l’urgenza di ritrasmettere su un social quell’esibizione straniante: autistica, in qualche misura.
Forse frutto di un compulsivo tentativo di lui, che mentre uno psichiatra cerca di renderlo consapevole della malattia del figlio, pensa solo a sé stesso, offrendosi a lui come intrattenitore col proprio biglietto da visita. E se lo psichiatra lo ha ascoltato, persino lui, appare essere senza redenzione alcuna.
“Felicità” è un tentativo di spiegare in quale modo l’Italia sia giunta ad un grado zero delle relazioni sociali e della capacità di entrare in relazione con l’altro, lasciando vincere il proprio egoismo; la propria indifferenza; la propria arroganza.
La protagonista – una Micaela Ramazzotti che racconta con grande forza interpretativa, il proprio straniamento da una vita vissuta con dolorosa consapevolezza, sin dall’abuso sessuale subito da bambina a dieci anni – attraversa ogni passaggio del proprio personale annientamento, mentre continua ad essere generosa con chi non meriterebbe nulla: i propri genitori; con chi forse, un tempo, avrebbe meritato qualcosa: il suo compagno; con chi forse è l’unico innocente del film: suo fratello che lei riesce, forse, a salvare dall’autodistruzione.
Il panorama che delinea Micaela Ramazzotti, è quello di una Italia che, ad un certo punto della propria storia, abbagliata dalla possibilità di approfittare delle occasioni che lo Stato Sociale forniva ( baby pensioni; case popolari ), dimentica totalmente le proprie responsabilità, per provare a saziare ingordamente il proprio ego in un susseguirsi indecente di autoindulgenza; di ignoranza ed indifferenza rapace. Fino ad arrivare a credere alle proprie bugie. Esattamente come può fare chi abbia completamente smarrito il proprio senso della realtà.
La famosa “famiglia normale”, diventa uno specchio deforme, dal quale emergono le storielle che gli italiani “brava gente” amano raccontare su sé stessi, pervertite invece in un infame e vergognoso delirio, nel quale persino il più orrendo carnefice, diventa vittima della propria ansia frustrata di visibilità e protagonismo, prostrandosi a masturbare il padrone di una televisione locale o facendosi deridere da una troupe cinematografica, il cui regista, imponendo il proprio presunto status artistico, non manifesta alcuna comprensione e solidarietà per le velleità d’autore del padre di Desirè ( Micaela Ramazzotti ).
Qui, Max Tortora, non può essere l’Alberto Sordi, anche carogna, di tanti suoi impietosi film; perché quell’Alberto Sordi, conservava sempre un barlume di umanità ingenua e innocente, e fragile.
Il padre di Desirè non può avere alcun riscatto umano, perché nemmeno arriva a comprendere cosa questo possa essere; e sua madre, una spietata Anna Galiena, ancor meno.
Questa coppia di genitori disfunzionali, manipolativi e anaffettivi, accompagna i propri figli in un inferno sempre più atroce e privo di speranza; in cui l’unica speranza è, in realtà, la fuga, da questa “famiglia normale”, che deve restare “unita”, contro tutti; contro i negri approfittatori; contro un mondo che si ostina a non riconoscere la loro dimensione televisiva: perché è lo spettacolo, la presenza in televisione, l’illusione che basti questo a dar senso alla propria vita, a condurre l’Italia nel baratro morale che ci ammorba e che vuole sommergere tutto quanto di buono, come Paese, abbiamo dato, e possiamo ancora dare al mondo.
Ed in questo quadro, non è poi tanto migliore la figura che fanno le classi culturalmente più avvedute. E magari progressiste.
Il professore universitario, compagno di vita di Desirè, evita, anch’egli, l’assunzione di responsabilità nei suoi confronti, negandole la possibilità di costruire una famiglia, che invece, è pronto a mettere in piedi con una donna più giovane, e culturalmente più affine.
Sergio Rubini rappresenta plasticamente una Sinistra capace di individuare con chiarezza il male che incontra e persino le soluzioni, a questo male, mentre dimostra però tutta la propria assenza di generosità ed il proprio egoismo, tradendo la classe popolare di Desirè, perché impresentabile “in società”; perché porta con sé problemi difficili da affrontare, come il disagio psichico del fratello; in sostanza, perché non corrispondente ad una propria idea di mondo, non all’altezza della propria presunta nobiltà intellettuale, che è solo un’altra faccia dell’egoismo sociale e dell’assenza di apertura, di questi tempi orrendi che viviamo.
“Felicità”, non è un film che ti lascia uscire indifferente dal cinema; soddisfatto d’aver visto uno spettacolo, ma senza domande. Riempie invece d’inquietudine.
Micaela Ramazzotti, dimostra d’avere uno sguardo profondo su questa Italia devastata da decenni di ipocrisie, di uso senza scrupoli del potere, che ha corrotto nel profondo la moralità delle persone e spappolato ogni legame sociale, lasciando ciascuno solo davanti alle proprie ossessioni, ai propri ritornelli, alle proprie bugie autoconsolatorie.
Il film somiglia ad un ascensore.
In cui due fratelli s’incontrano per un istante allo stesso livello, mentre uno sale verso una propria consapevolezza, e l’altra scende in un progressivo denudarsi di ogni propria difesa.
Questo ascensore corre dentro un palazzo fatiscente, e schifoso e pericoloso.
Il cinema italiano ha una nuova voce, ed è bello, che sia così.