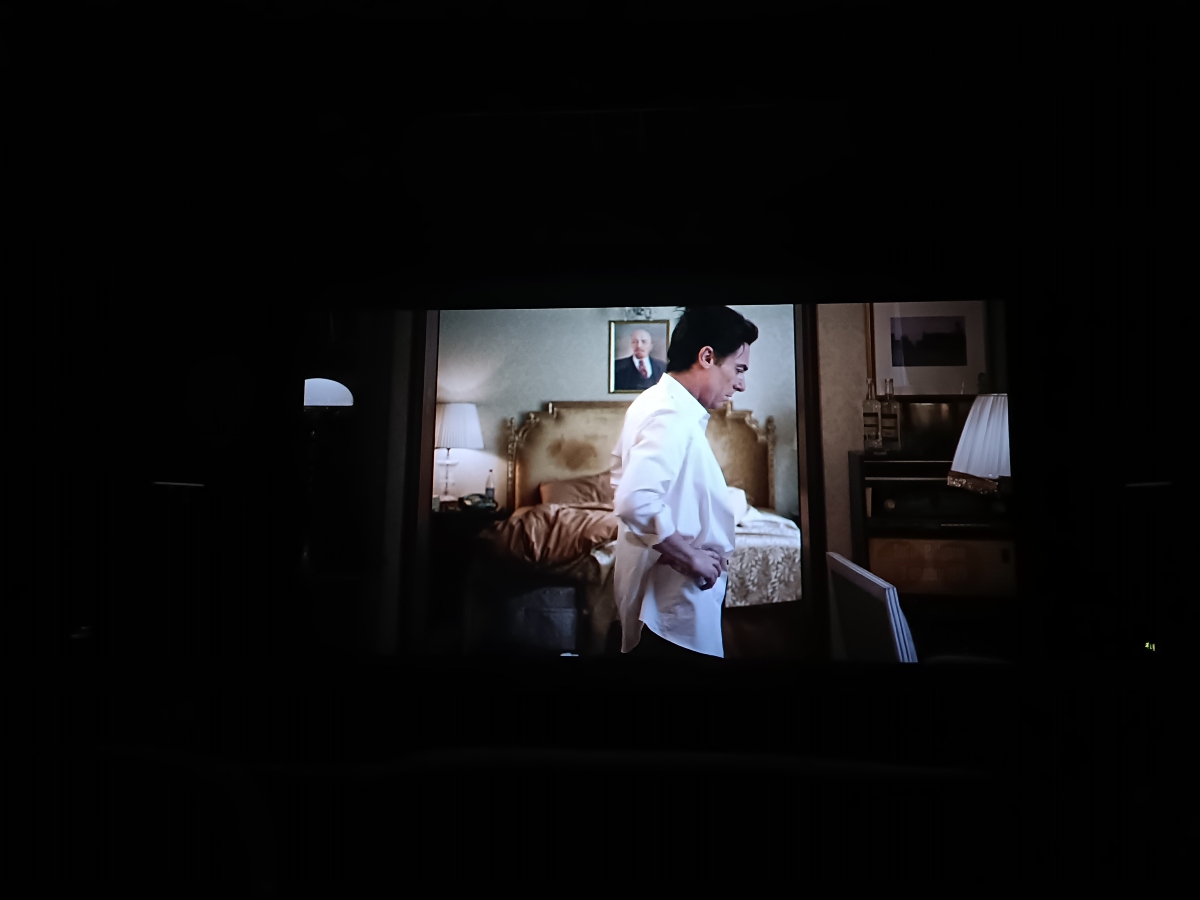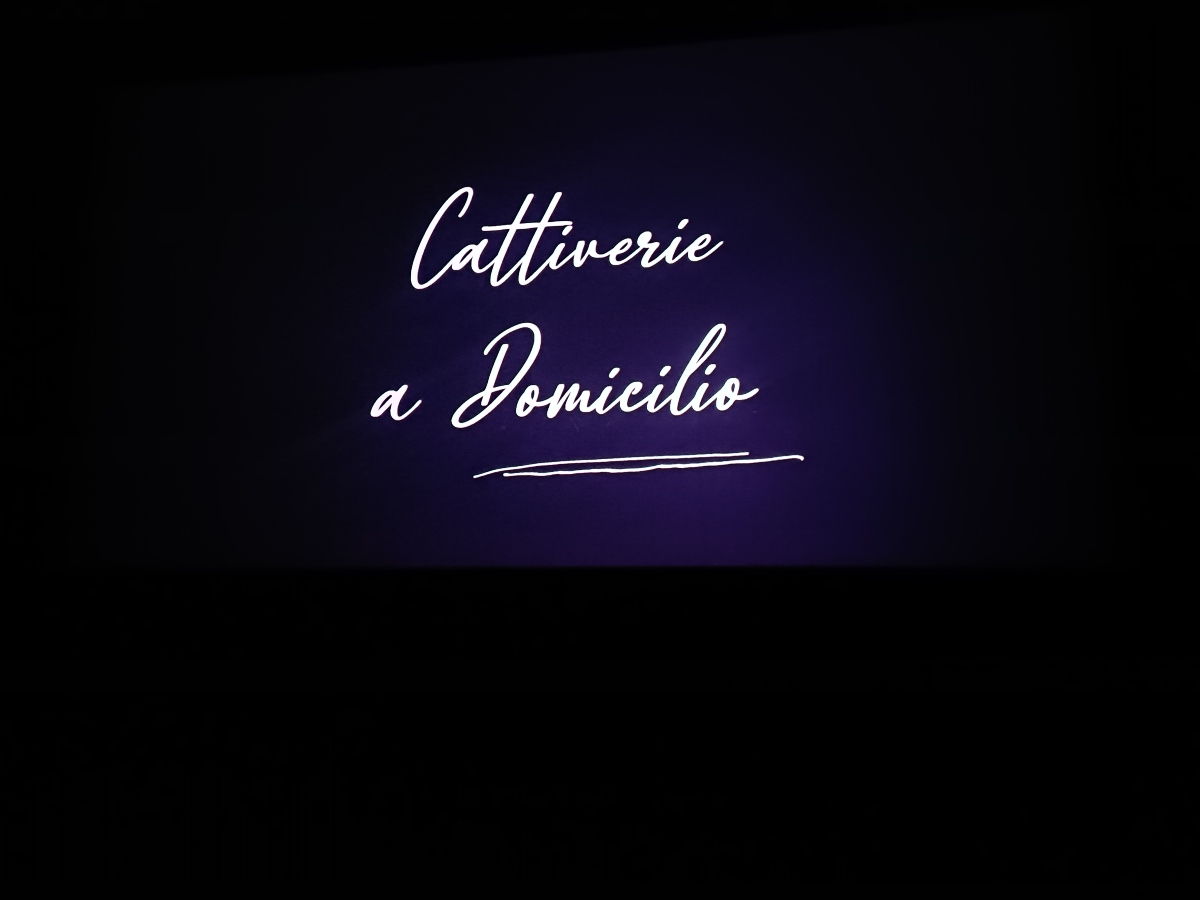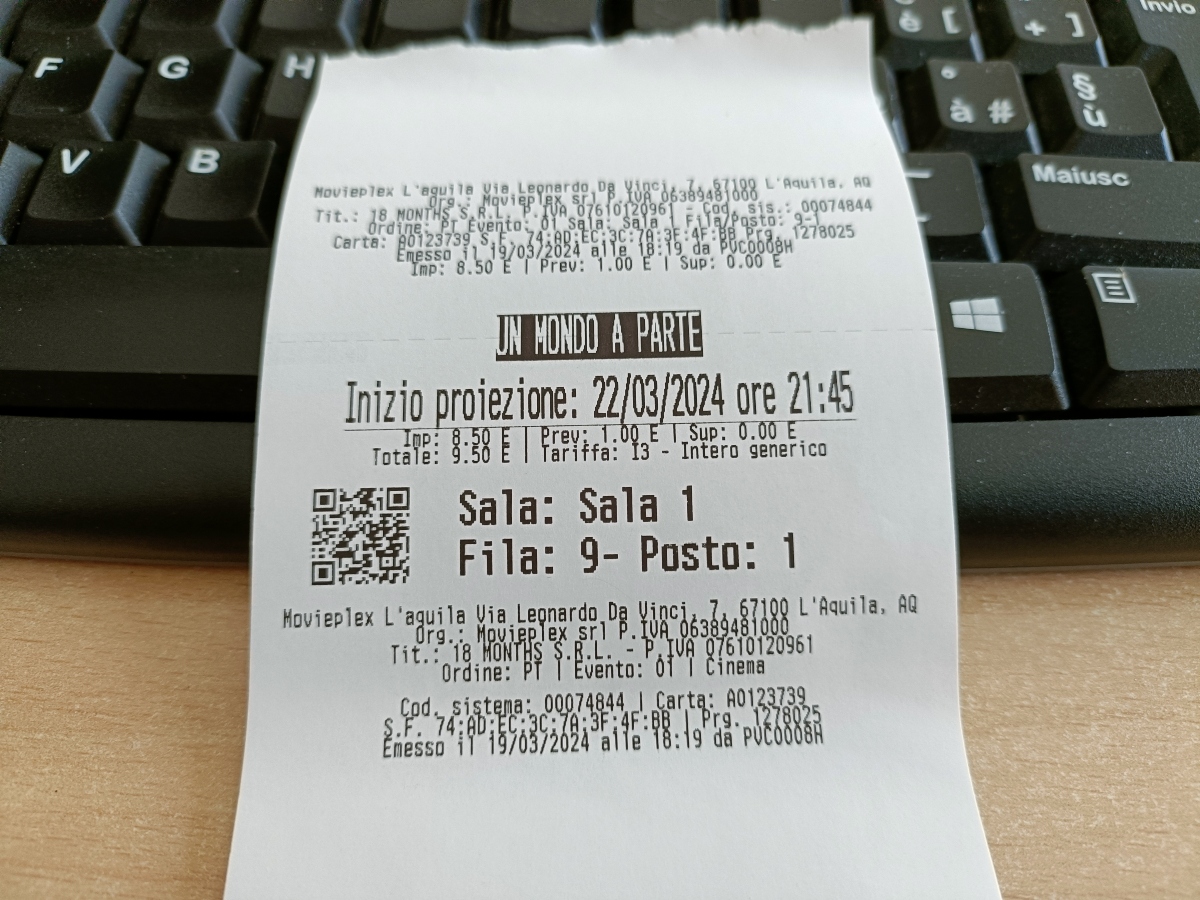Se vai a vedere un film di Nanni Moretti, in sala, non sentirai odore di popcorn, e rumore di mascelle manducanti. Non so per quale ragione. Forse perché in sala ci sono solo vecchi babbioni come me, preoccupati per l’altezza del colesterolo; oppure perché gli spettatori di un film di Nanni Moretti, si sentono intimamente minacciati dall’integralismo cinematografico del regista il cui spirito onnipresente ed onnisciente, sarebbe comunque seduto tra le poltrone rosse del Movieplex, pronto ad ammonire e a reprimere con cipiglio austroungarico chiunque attenti alla sacralità della proiezione, anche indossando sabot, magari.
In ogni caso, senza odori molesti e rumori irritanti, si sta bene, al cinema.
Deve essere questa la stagione dei film che riflettono sul futuro del cinema, e sul suo passato, e, contemporaneamente, si misurano col tempo che scorre e con le possibilità di sovvertire, il corso delle cose e della realtà.
Amsterdam;
La stranezza;
Il principe di Roma;
Avatar;
Babylon;
Empire of light;
Il ritorno di Casanova.
Per citarne solo alcuni.
Come se, ad un certo punto, lo spirito del tempo chiedesse a tutti d’interrogarsi sulle sorti del cinema; sulla materialità del tempo che scorre – e sulle sue possibilità di andare in direzioni diverse, rispetto a quelle effettivamente vissute – ; e, dunque, sulla realtà: sulla sua esistenza, o sulla sua possibilità di trovare strade diverse da quelle che sta invece materialmente camminando.
Naturalmente, ognuno ha dato le risposte che credeva, e nel modo in cui è stato capace di darne, e Nanni Moretti costruisce la sua risposta a partire da un incredibile, ed incontrovertibile dato di realtà.
In Italia, c’erano due milioni di iscritti al Partito Comunista Italiano. E, a nessuno di loro, si poteva rivolgere, impunemente, la parola “Comunista”, come fosse una specie di insulto storico. Qualcosa destinato alla “damnatio memoriae”.
E’ lecito, che un regista costruisca un intero film sulla “nostalgia”, non tanto autobiografica, quanto generazionale, come se stesse cercando di scavare dentro le proprie sconfitte, che si riverberano, necessariamente, anche nella propria vita familiare, perché “il personale è politico” ?
( Come diceva un vecchio slogan di tempi che ero troppo bambino per vivere davvero ).
Ed è lecito che, mentre, cerca in questa direzione, gigioneggi suggerendo che la propria autobiografia possa confrontarsi con quella di Fellini, segnandone contemporaneamente la differenza con le autocitazioni dai propri film passati e con la concettosa autoassertività di ogni proprio enunciato che, come la Sinistra di un tempo, è, contemporaneamente, vero e scostante, incapace di autocritica e di autoironia ?
Proprio mentre invece Nanni Moretti mette in mostra le vene scoperte della propria inadeguatezza, del proprio essere fuori tempo e fuori fuoco, in un corto circuito comprensibile solo se lo si segua in un unico piano-sequenza che, dall’alto, lo mostra traversare la stanza in cui discute del film che sta facendo, per passare poi alle stanze abitate dal film stesso e a quelle abitate dalla sua crisi familiare, per finire poi col sedersi in una ricostruita sezione del PCI del 1956, come fosse una tana, un rifugio, un luogo seminale: il cinema, la finzione cinematografica, unica realtà in cui rifugiarsi.
Il circo, che si chiama come il pallanuotista ungherese di “Palombella rossa”, immarcabile, mentre la giornalista petulante lo cerca per intervistarlo, ma “parla male…pensa male…”, e ora invece, è il regista giovane a girare il suo film con un linguaggio filmico che non è arte, ma solo condiscendenza, e, per questo, Nanni-Giovanni, lo interrompe mentre si autodescrive come un novello Woody Allen in fila per entrare al cinema che sente un tizio sproloquiare e, improvvisamente, a sostegno vincente alle proprie tesi, compare Marshall McLuhan in persona; così come Moretti chiama a sostegno, per la sua idea di arte, Renzo Piano, Corrado Augias e… Martin Scorsese, che però lo trafigge con una segreteria telefonica.
Si ride, e si sorride, mentre il film indaga una pagina dolentissima della storia del nostro Paese, e del Partito Comunista, in particolare.
L’invasione sovietica dell’Ungheria nel 1956.
Nella seconda metà degli anni ‘80, prima della caduta del Muro di Berlino, e appena dopo, la morte di Enrico Berlinguer, io mi ero iscritto, al PCI. Un Partito che faticava ancora ad uscire dal cono d’ombra del comunismo sovietico, ma che stava ricomponendo le sue fratture col passato: dentro il quale era in corso una discussione vera, anche se, come poi la Storia ha deciso, fuori tempo massimo. Una discussione che, sia pure in modo implicito ed involuto, riguardava la possibilità che un Partito, che si autodefiniva “Comunista”, riconoscesse la propria pratica storica di grande partito socialdemocratico, avvicinando, finalmente, le parole alla realtà, nel segno della libertà, ma anche della sperimentazione di nuovi linguaggi e nuove forme organizzative.
Antonio Giolitti era uscito, dal Partito Comunista Italiano, rompendo, proprio per la posizione del PCI riguardo l’invasione sovietica dell’Ungheria, ed era stato Ministro, col Partito Socialista Italiano, e rientrava, invece, nel PCI, proprio in quegli anni, in cui tifavo per Dubceck, ed avevo imparato a conoscere la tragedia di Imre Nagi, ed ascoltavo la musica dei CCCP, che avevano trasformato l’Emilia Romagna di Togliatti ( “Ceto medio ed Emilia Rossa” ), in una musica visionaria e capace di relegare la simbologia sovietica ad una sorta di provocatoria scintilla che smontava tutte le certezze ipocrite di una modernità che era divenuta quasi solo consumo.
E quanto mi sono sentito sconfitto io, per non aver combattuto abbastanza, nel mio piccolissimo, dentro quel Partito, per provocarne una trasformazione prima che la fame di condizioni materiali insostenibili, abbattesse quelle separatezze che avevano tenuto distanti tra loro due mondi egualmente ingiusti, anche se non oppressivi alla stessa maniera, impedendo a chiunque volesse costruire dialogo e superamento, d’aver voce e possibilità.
E quanto è bravo Silvio Orlando, a dar voce ad una idea di militante comunista quasi sacerdotale, ma incapace di emanciparsi dalla chiesa-Partito, quando questa tradisce le sue idealità, e quelle di tanti altri; e Nanni Moretti, lo tradisce doppiamente, perché non gli fa recitare una scena di suicidio, alla quale l’attore s’è preparato da tutta una vita, ma neanche lo fa essere il “Pasticcere trotzkista”, che pure gli aveva promesso di mettere in cantiere, nel suo precedente film “Aprile”… anche se Lev Trotskij, lo recupera in effige…
E anche Moretti, cede al Multiverso della Marvel.
E se la storia fosse andata in un’altra direzione, nel 1956, oggi sarebbe possibile che il “Quarto Stato”, di Giuseppe Pellizza da Volpedo, somigli ad una ridente e danzante parata felliniana sui Fori Imperiali, con tanto di elefanti tedesco-francesi; popolata di sorrisi e di attori e attrici famosi, soprattutto interpreti di precedenti film di Nanni Moretti, che diventa così, egli stesso, un universo a sé stante, in cui Marx ed Engels, riescono, finalmente, a far felice qualcuno.
Non so se sia troppo, o se sia troppo poco, per quello che realmente abbiamo vissuto, dal 1956 ad oggi. E non so neanche se questa continua sovrapposizione di piani linguistici, narrativi, storici, tematici o di tesi più o meno precostituite sia un modo di resistere alla tirannia delle piattaforme multinazionali, che trasmettono il loro prodotto in 190 Paesi diversi.
Però che un film di Nanni Moretti mi faccia venire in testa tante questioni, può essere solo un segno di due possibili realtà diverse e non comunicanti tra loro.
O io sono un vecchio babbione di Sinistra che avrebbe tanto bisogno di parlare di cose sostanziali senza l’assillo della propaganda in cui siamo stati immersi negli ultimi 34 anni; oppure il film che ho visto era talmente scombiccherato, che ho dovuto trovargli per forza delle giustificazioni per non sentirmi defraudato dall’egolatria morettiana.
Di certo, il film va a Cannes, sotto i peggiori auspici, visto che Moretti ha mandato in galera il produttore francese del film, per manifesta, e italianissima, truffaldinità.