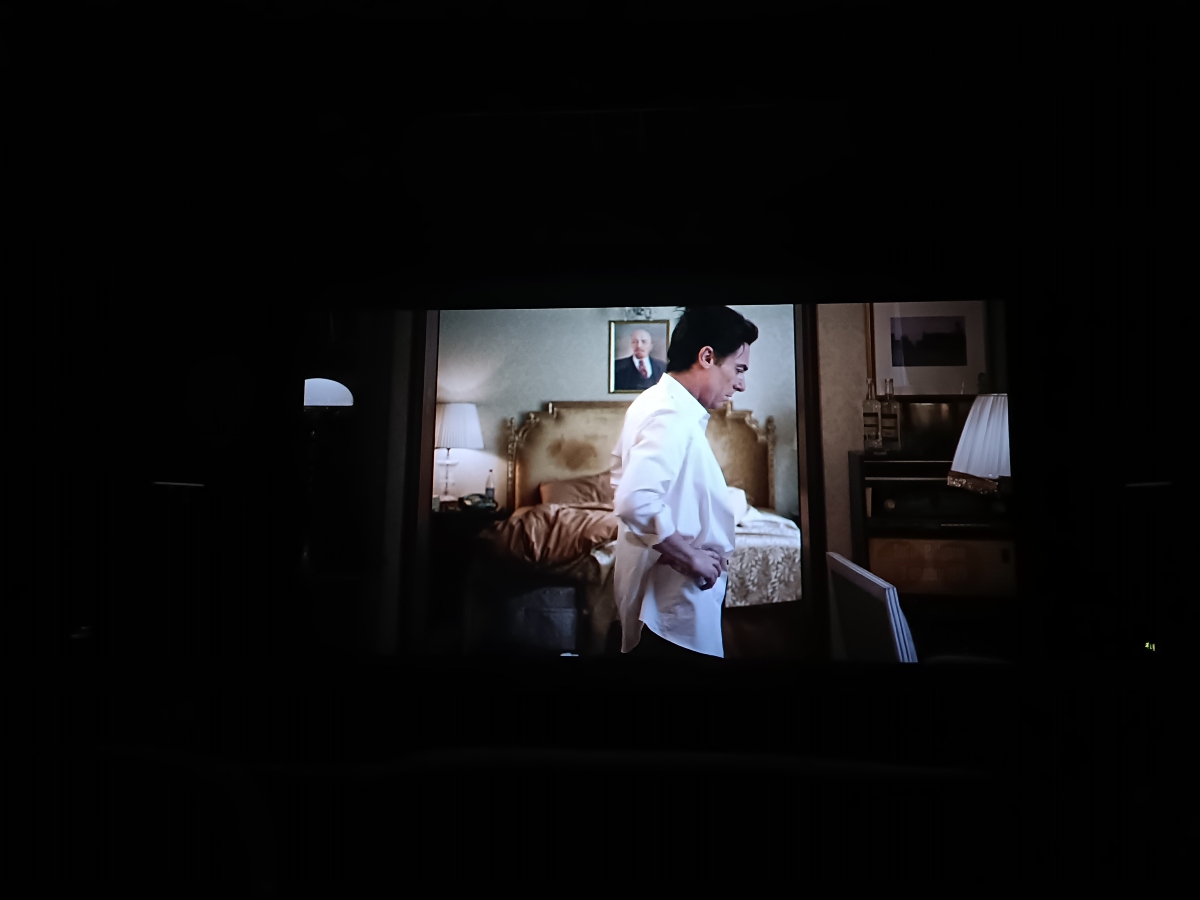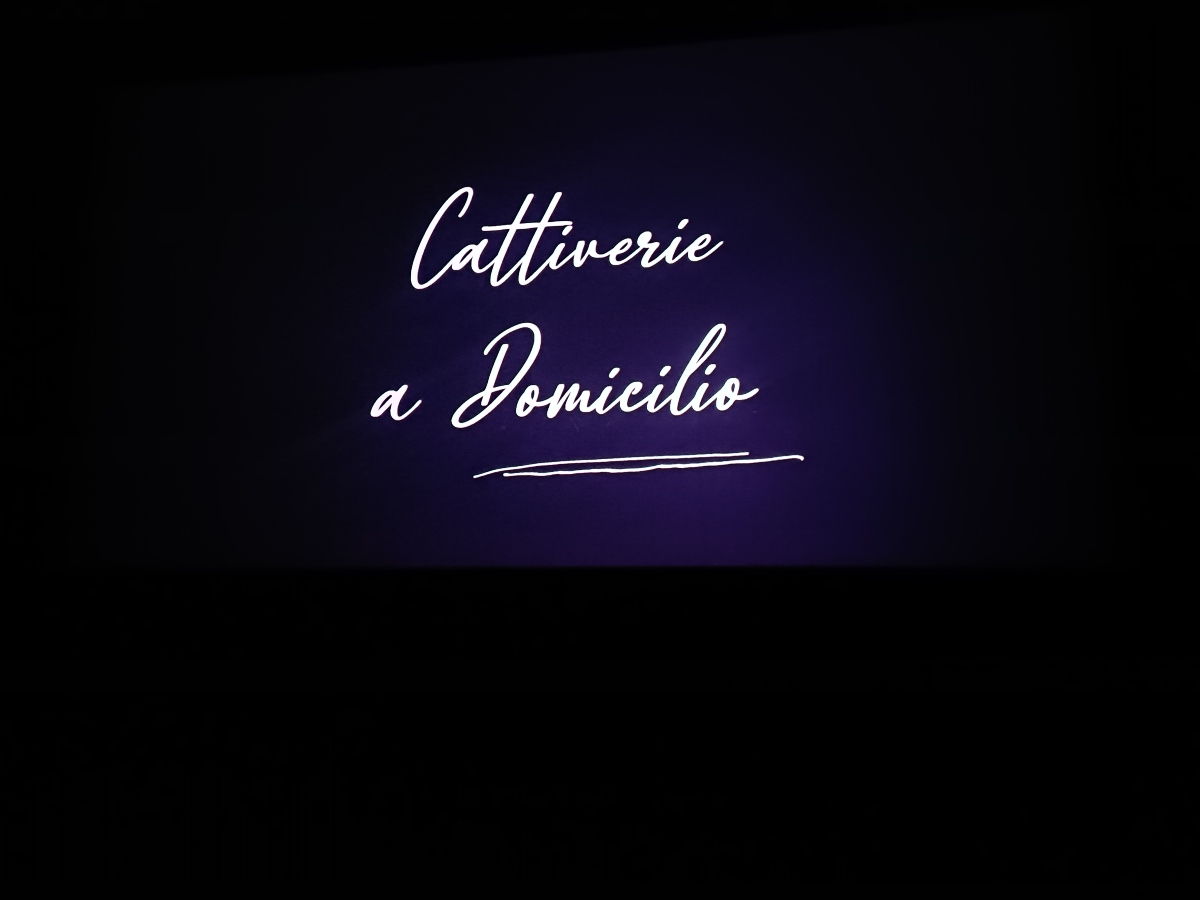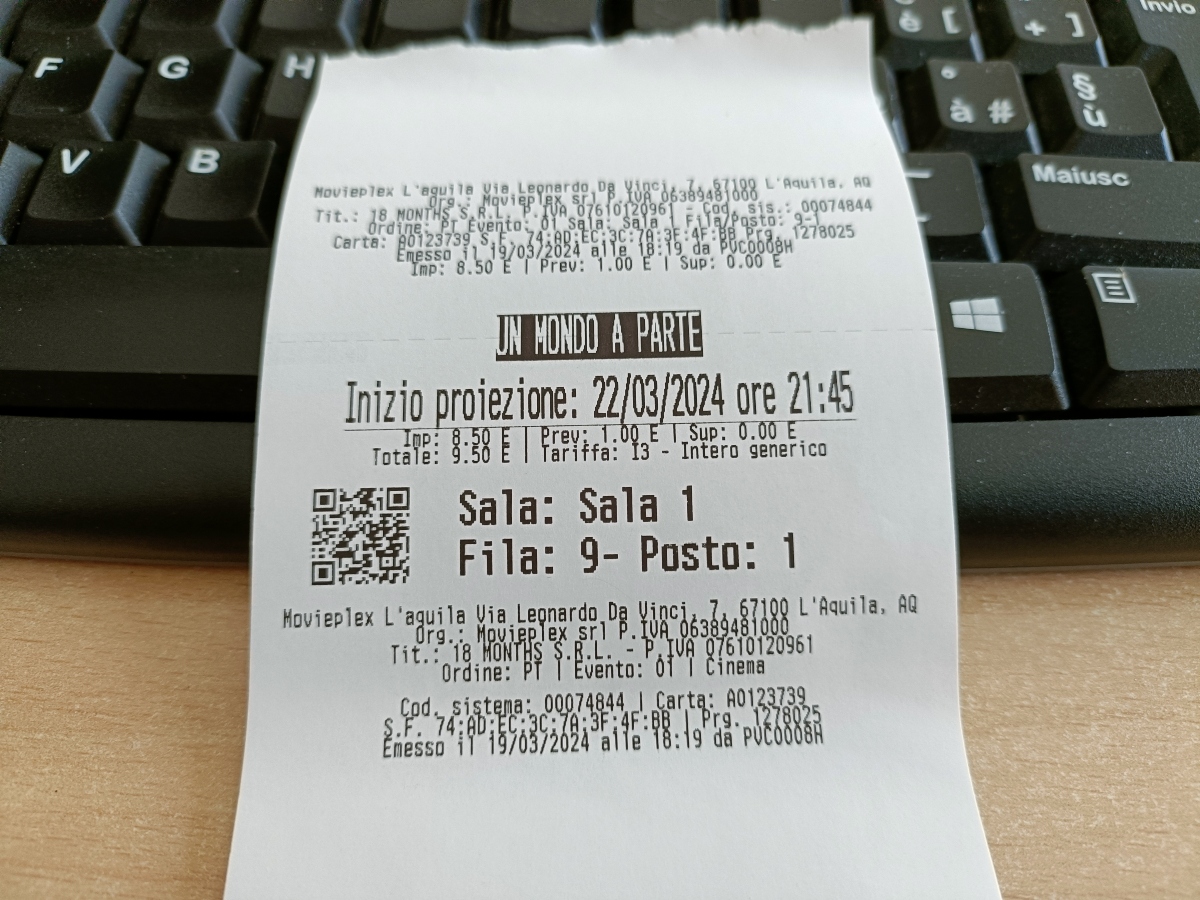Non serve, un motivo valido, per aver paura.
Quanta paura deve sentire un bambino, un figlio di puttana, letteralmente, per essere stato abbandonato dai propri genitori, anzi, affidato, a pagamento, ad una vecchia puttana ebrea, reduce da Auschwitz, che, per vivere, accoglie, nella sua casa al sesto piano di un palazzo, senza ascensore, altri figli di puttana, a lei affidati da altre donne, che non potevano, certo, portare con sé i propri bambini, mentre erano a lavoro ?
Bambini di ogni colore, e di ogni religione, a Parigi, nel quartiere di Belleville, qualche decennio prima, che di esso raccontasse Daniel Pennac, con la sua famiglia Malussene, debitrice, al romanzo di Romain Gary, delle parole magnifiche, dell’ironia corrosiva e dolente; della sfrenata vitalità che abbatte ogni steccato, tra musulmani ed ebrei; tra neri e bianchi; tra francesi e immigrati, in nome della bontà, e dell’infinito rispetto che si deve alla Vita.
Solo lo steccato da cui sono circondati i poveri, i marginali, gli irregolari: solo quello resta alto. Talmente tanto alto, che persino un bambino, musulmano d’origine, arabo di nome, lo interiorizza e non riesce a scavalcarlo. Non riesce a vincere l’esclusione cui altri lo ha destinato, perché gli pare normale, semplicemente, che sia così.
E quanta paura, deve fare, in un bambino, che non ha mai conosciuto sua madre, non avere una madre. E quanta paura deve fare, ad un bambino che non ha mai conosciuto suo padre, non avere un padre.
Non sogna di vincere la paura, quel bambino, ma solo di essere guardato, o di prendersi una bella sberla, se fa qualcosa che non deve essere fatto, perché è così, che le madri devono fare. Una sberla, pur d’avere una madre.
Uno strepitoso Silvio Orlando, dal buio del ridotto del Teatro Comunale, prima che s’inizi lo spettacolo, ci avvisa, di non tenere accesi i cellulari, e quante volte, in questi mesi di stagione teatrale abbiamo subito la vergogna di sentir squillare una suoneria, o i trilli delle notifiche, durante le rappresentazioni; interrotte, persino una volta, da un attore, che ha smesso di recitare, e ha chiesto di non fotografare, all’augusta signora che aveva bisogno di uno scatto da mettere sui social.
E il magnifico Silvio Orlando, dal buio del ridotto del Teatro Comunale, prima che iniziasse lo spettacolo, ci avvisava anche che, potevamo, per un’ora e mezzo assentarci dal mondo, senza telefoni in funzione: il mondo avrebbe tranquillamente continuato ad andare avanti facendo a meno di noi, che lo avremmo ritrovato, dopo circa un’ora e mezzo, pressochè uguale a come lo avremmo lasciato.
Cosa della quale era giusto essere certi: lo avremmo trovato sempre irrispettoso, come l’assenza di organizzazione del Teatro Stabile d’Abruzzo, che, per un evento folgorante, come Silvio Orlando che porta in scena il romanzo “La vita davanti a sé”, di Romain Gary, vincitore truffaldino per la seconda volta del Premio Goncourt, che si può attribuire allo stesso scrittore una sola volta nella sua vita ( Romain Gary, che lo aveva già vinto, lo vinse per la seconda volta pubblicando il romanzo con uno pseudonimo ), consente alle persone di entrare in teatro anche quando lo spettacolo è iniziato già da dieci minuti.
Ci avvisa, prima dell’inizio dello spettacolo, dal buio del palcoscenico, un meraviglioso Silvio Orlando, che avremmo assistito al racconto di un grande amore.
Ma che imbarazzo, come direbbe Mohammed, Momo’, Silvio Orlando, riferendosi alla cacca che il bambino spruzzava ovunque, pur d’essere notato, quando, nonostante tutto, mentre lo spettacolo stava arrivando al suo culmine finale, il suono osceno di una notifica sul cellulare, ha violato un silenzio piovoso di emozioni fortissime.
Un WhatsAp che chiedeva quale locale si sarebbe scelto per il vicino aperitivo. O la foto finalmente giunta del nipotino che sorrideva mostrando il suo primo dentino appena spuntato. O la fondamentale informazione che consentiva di sapere che, esattamente in quel momento, il Torino aveva segnato un gol sul campo della Lazio.
Silvio Orlando ha modulato la propria voce, cantilenandola, come un bimbo spaventato, ed assetato d’amore, e l’ha cambiata, in accenti, interiezioni, toni gravi e burocratici e divertenti e paradossali; in carezze suonate, quando diventava giovane doppiatrice bellissima, o medico generoso che visitava gratuitamente i “diversi” di Belleville, o quando raccontava Madame Rosa, invisibile e segreta protagonista di tutta la storia. Una storia d’amore, appunto. Cercato, come fosse l’unico modo di esistere. Scansato, per il timore di non essere abbastanza. Sconosciuto, per un bambino che s’ingegna a sopravvivere, ad inventarsi giocattoli e compagni, come quando raccoglie un cagnolino ancor più disgraziato di lui e lo cura, per poi venderlo infine ad una ricca passante, non per i 500 franchi ricevuti, che butta via in un tombino, ma perché così, quel piccolo essere avrebbe avuto una vita migliore, rispetto a quella che lo avrebbe atteso, in braccio a Momo’, che lo amava, davvero, ma non aveva neanche nulla di cui nutrirlo.
Con la sua sola voce, ed una gestualità raccolta, e solenne al tempo stesso, Silvio Orlando dipinge, davanti agli occhi di tutti, come se lo facesse per ognuno di loro singolarmente, e con lo stesso carisma di un Picasso che inventa le Damigelle d’Avignone, cambiando per sempre così la pittura, un intero mondo tenuto in piedi solo da quell’assurdo legame che è l’amore. Che non chiede nulla in cambio, ma che è egoista al punto tale da donare sé stesso, anche quando questo significhi rischiare, o separarsi dall’amato, perché possa ricevere ancora più amore da altri; perché noi siamo limitati, sempre.
L’ultima frase, che Silvio Orlando pronuncia, un attimo prima che si spengano le luci, suona come un lascito. Un fiammifero acceso che chieda di poter illuminare l’intero mondo, chiuso dentro scorze e corazze di violenza e follia, dentro mura di guerra e sfruttamento.
“Bisogna volere bene”.
Perchè, forse, è solo questo, che sconfigge la paura.
Silvio Orlando, accompagnato da quattro maestri di musica che hanno messo insieme, con gioiosa malinconia, il klezmer e l’Africa con la tarantella del bis finale, in cui il protagonista della serata ci ha mostrato la sua gioia di essere suonando per noi il suo flauto, ha illuminato, finalmente la stagione teatrale aquilana, con un evento di rara intensità e rapimento.
L’aria della sera, fuori dal Ridotto del Teatro Comunale, era più trasparente, e pulita, dopo.