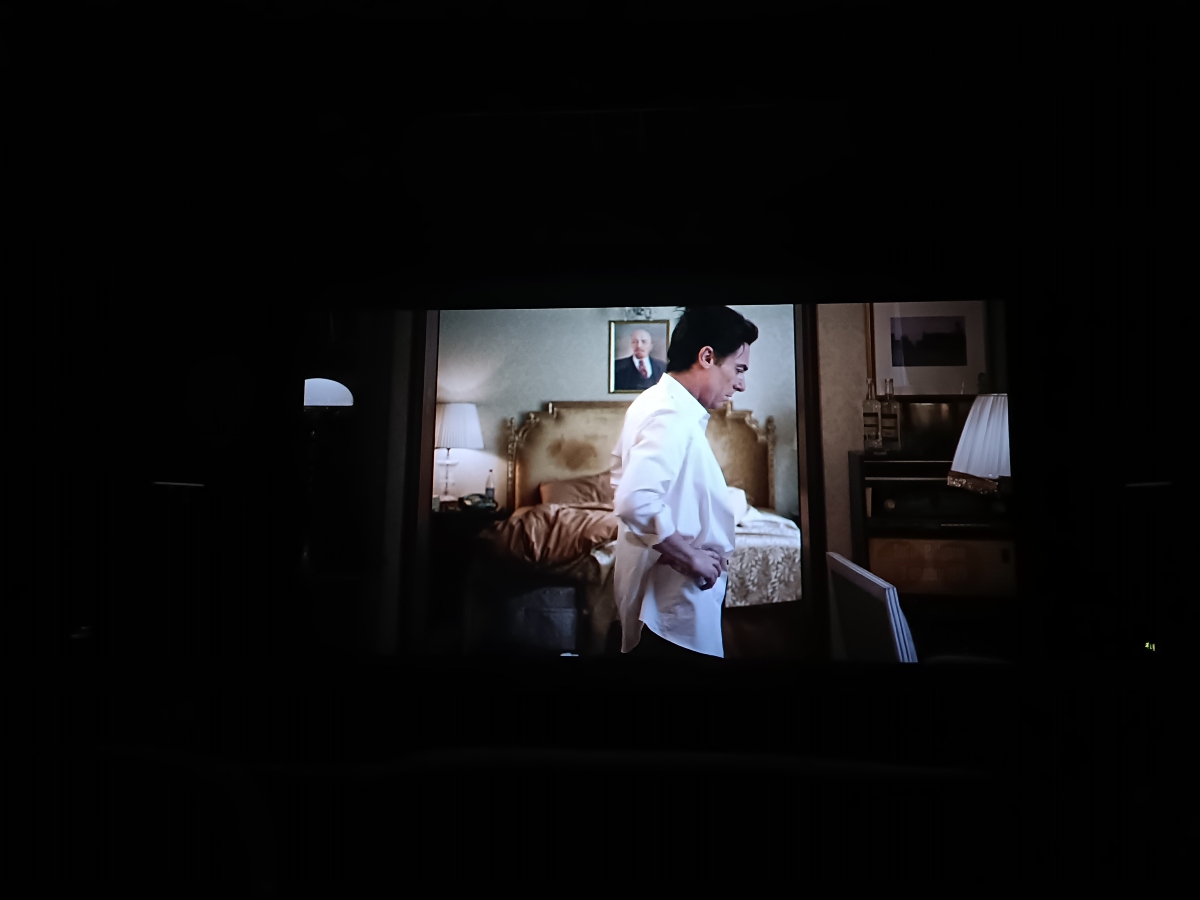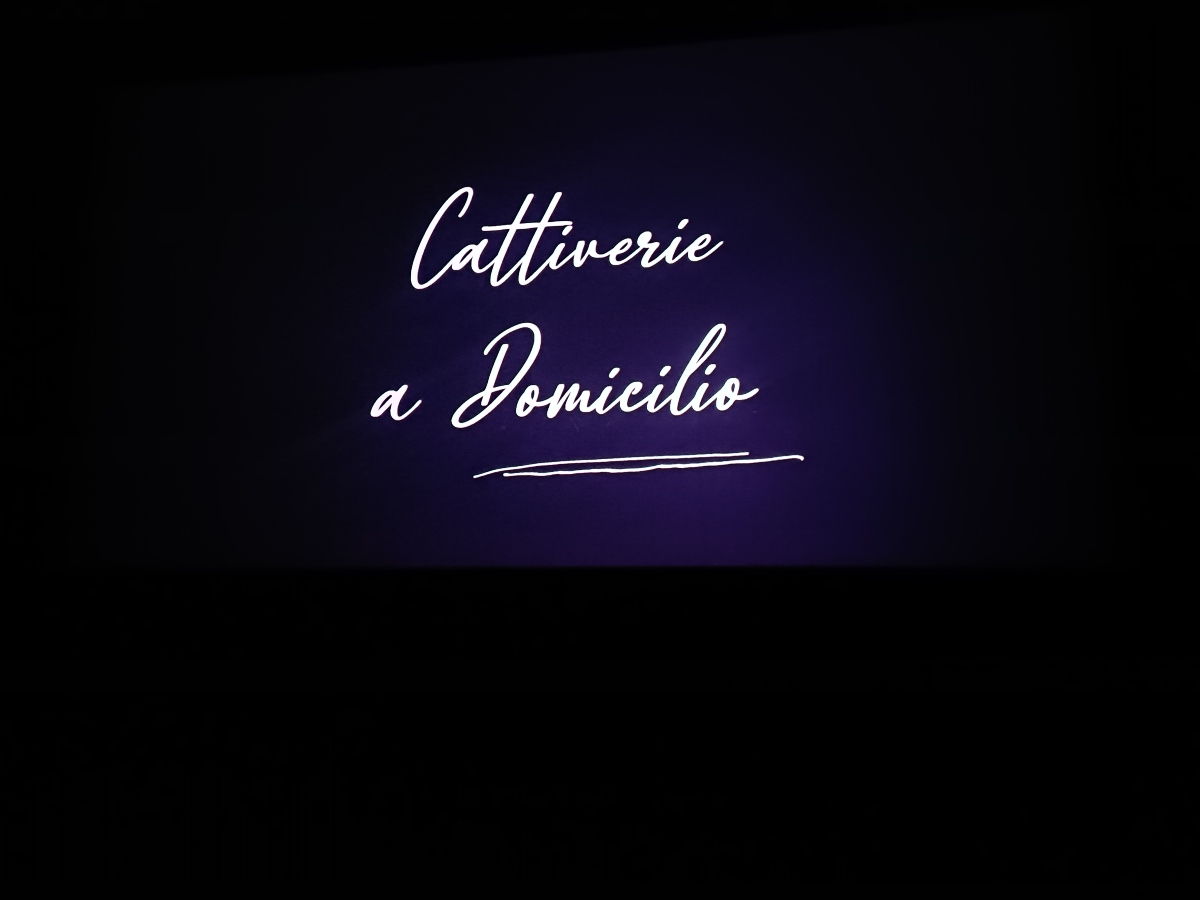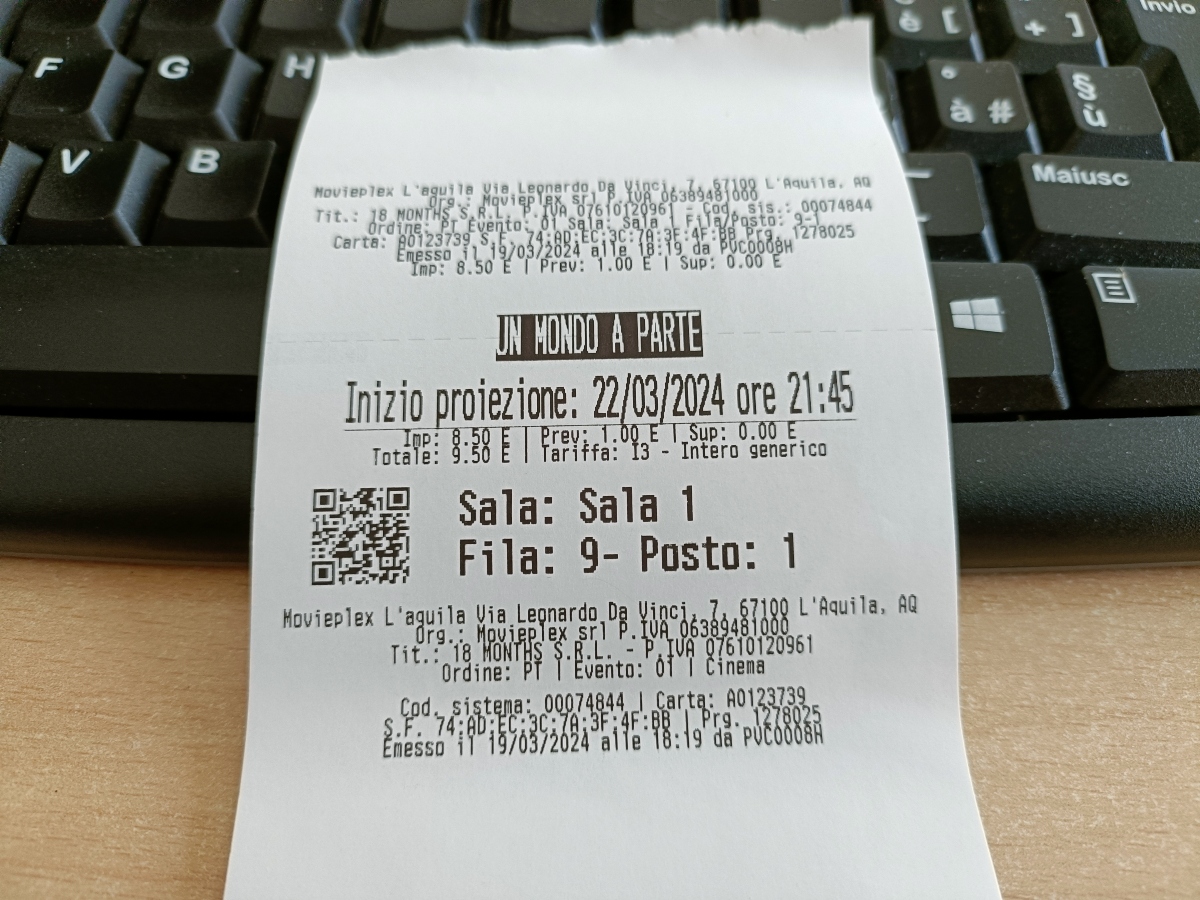Babilonia, per le grandi religioni, rappresenta il male; la grande meretrice.
Babilonia rappresenta anche la grande confusione: l’impossibilità di comprendersi tra loro, degli uomini, destinati a rovinosamente fallire, mentre, costruendo la loro torre, danno l’assalto al cielo.
Chiamare “Babylon”, un film che racconta il passaggio, nel cinema americano, dal muto al sonoro, e la sua progressiva trasformazione in una vera e propria industria, significa, sin da subito, accentuare un significato problematico, se non negativo, della libertà di cui godettero gli artisti, nel breve periodo tra il Primo Dopoguerra e l’immediatezza della Grande Depressione seguita alla caduta della Borsa di New York nel 1929.
E’ come se il regista, Damien Chazelle assumesse il punto di vista della “moral majority” – quella corrente del pensiero reazionario statunitense che, dalle paranoie della “caccia alle streghe” del periodo maccartista ( subito dopo la Seconda Guerra Mondiale ), conduce fino al Tea Party; a Donald Trump e al sovranismo di Steve Bannon e ai complottisti di Qanon – per problematizzarlo, o forse addirittura, per farci brutalmente i conti e smascherarne l’intima connessione con il cosiddetto “sogno americano”, che così si colora di tinte profondamente inquietanti.
Fatty Arbuckle era uno dei comici più importanti del cinema muto americano; lavorava in coppia con un vero genio del cinema: Buster Keaton, ma anche da solo. Fu durante una sua festa, che trovò la morte una giovane attrice. Il comico venne sottoposto a tre processi, da cui uscì assolto. Ma la sua vicenda, anche per la grande popolarità del personaggio, si prestò per una furibonda campagna moralizzatrice. La sua carriera venne distrutta. Hollywood, si disse, perse la sua innocenza.
Il film inizia con una citazione di quell’episodio. Una scena molto forte. Che racconta un degrado, forse. O forse, tra due adulti consenzienti, tutto è possibile. Ma, è davvero tutto lecito, quando l’uomo riveste un ruolo, importante, e una donna, giovane, invece non ha nessun ruolo ?
E però la donna appariva consenziente, e divertita.
E, ad “aggiustare le cose”, nascondendo la tragedia, ancora non del tutto consumata, arriva uno di quegli “spicciafaccende”, duri e silenziosi, fedeli al capo, e pronti a tutto; e, per impersonare questo ruolo, il regista ha scelto Flea, il bassista dei Red Hot Chili Peppers; ha dato cioè al membro di una rock band, facente parte quindi di un mondo non esattamente ascetico e cristallino, il ruolo di riportare “ordine”, in un mondo persino più sfrenato ed eccessivo di quello della musica rock in tournée.
Il regista ci sfotte ? O ci provoca magari, per far deragliare il senso dei nostri pensieri, mentre guardiamo il suo film che corre velocissimo, ubriacandoci di immagini mai ferme e contrasti sempre stridenti: sembra avvertirci che la storia nella quale siamo immersi, racconta di persone che sono state capaci di travalicare persino i limiti superati dal dorato mondo della musica “giovane”; e, nello stesso tempo, sembra dirci che persino il potenzialmente eversivo rock, è ormai ridotto ad elemento d’ordine, della società: totalmente fagocitato dal business e rispettoso delle sue regole più bieche, come sedare un possibile scandalo, anche a costo di nascondere le responsabilità di chi forse ha irrimediabilmente compromesso la vita di una giovane donna. E, ancora, il regista ci consegna una confusione di piani temporali, con la sua scelta spiazzante, per quel ruolo, di un non-attore fortemente caratterizzato e noto, e ci obbliga, sin dalle prime scene del film a confrontare costantemente la nostra realtà di oggi, con quella di cento anni prima: la libertà di quegli artisti, che era sì creativa, ma anche confliggente con la morale comune, in fondo, e richiedeva comunque di proteggere un investimento sul mercato ( tale è da considerarsi la carriera di un attore ), anche passando sopra il corpo martoriato di una giovane donna; mentre oggi invece, l’unica libertà reale è quella del mercato che ha trasformato noi stessi in merce ( cosa altro siamo, su un social network, cui, in cambio della gratuità d’uso, cediamo le nostre caratteristiche fisiche; i nostri pensieri, le nostre preferenze… ? ).
Il regista ci porta dentro una festa hollywoodiana.
Un’orchestra suona meravigliosa musica jazz da ballo, e, intorno, il mondo è rosso. Scatenato. Molti corpi sono nudi. Molti corpi si stanno unendo in una libera, frenetica e spudorata attività sessuale. Si fuma. Si beve. Ci si droga.
Una cantante cinese androgina ed omosessuale esibisce la sua elegantissima classe. Un elefante arriva dentro la casa, e distrugge ogni cosa al suo passaggio, mentre tutto intorno continua a vibrare di vita e gioia, e sfrenatezza orgiastica.
Siamo seduti su una sedia di cinema, ma è come essere su una poltrona che ruoti vorticosamente su sé stessa, impedendoci di fissare anche un solo particolare di quel che stiamo guardando, e, nel contempo, lasciandoci addosso una impressione generale di frenesia vitalistica che non pensavamo neppure possibile.
Una giovane e bellissima donna vuole entrare nella villa in cui si tiene la festa.
E’ lei stessa, uno sfasamento temporale. I suoi capelli sono pettinati come li porterebbe una donna di oggi, ma la scena si svolge a metà degli anni ‘20 dello scorso secolo. La sua sfrontatezza, e la sua decisione, sono quelle di una donna che non accetta di restare nel posto, e nel ruolo, cui il mondo l’ha destinata: cento anni fa, e oggi.
Lei non vuole diventare una stella: lei è già, una stella.
Un giovane immigrato messicano darebbe qualsiasi cosa, per poter lavorare su un set cinematografico. Vorrebbe poter essere partecipe di qualcosa di grande; più grande dei propri limiti e delle proprie aspirazioni persino.
Le vite di questi giovani, attraversano la vita di un maturo divo del cinema muto.
Un uomo cui è concesso tutto. Cui ogni donna si concede.
Queste vite cercano il successo. Cercano di essere al centro della scena. Con la sfrontata grazia della propria bellezza e del proprio talento; con la tenacia di chi vuol cambiare il proprio destino, ed è pronto a tutto, per questo; anche a venire a patti con la propria coscienza e con la propria rettitudine.
Ed ecco che si delinea l’essenza del “sogno americano”.
Raggiungere un orizzonte, senza curarsi dei mezzi; del modo, con il quale lo si raggiunge. E senza accorgersi che sono proprio i mezzi, invece, a definire il fine. A segnarne la qualità ed il peso, anche morale. L’altezza.
Ed è qui, che il film ci racconta il progressivo vuoto che s’impadronisce dell’esistenza di chi quel sogno non riesca, o non riesca più ad afferrarlo. Un terribile vuoto di senso che nessun eccesso può riempire.
Ma è possibile concepire l’esistenza di un senso, e di una felicità del vivere, che non comporti necessariamente l’inseguimento di un sogno di successo e di emersione, e di gratificazione del proprio ego ?
Il film ci racconta che, nell’America del Novecento, non era possibile.
E oggi ?
Dev’essere per questo che il film, in particolare negli USA, ha ricevuto critiche feroci.
Perchè evidentemente non piace vedersi sullo schermo, posti di fronte alle conseguenze profonde che le proprie narrazioni identitarie comportano. Un mondo che misura tutto sul successo personale, non può accettare la spiegazione che la giornalista fornisce al divo del muto, riguardo il declino della sua carriera.
Non c’è spiegazione, sostiene la giornalista: ad un certo punto, la propria parabola inizia a scendere, e, semplicemente, non c’è spiegazione.
Tutta l’etica, e l’estetica del successo, che teoricamente ( e persino religiosamente, direbbe Max Weber col suo “L’etica protestante e lo spirito del capitalismo” ), dovrebbe anche coincidere col merito, viene abbattuta dal caso; dalle circostanze. Il che significa, in estrema sintesi, che il cosiddetto “sogno americano”, è solo la spiegazione, postuma, agiografica, propagandistica, di un successo del tutto casuale, la cui visibilità abbagliante non ha legami, se non circoscritti, col tempo della vita di una persona.
Inaccettabile, per tutti quelli che del successo hanno fatto una religione; della visibilità una mistica.
Inaccettabile, per chi, ancora oggi, propaganda una presunta superiorità morale degli Stati Uniti d’America, e che, per questo, se la prende con i seni nudi o gli eccessi scatologici mostrati da Chazelle.
Il divo del muto, un misuratissimo e umanissimo Brad Pitt, cerca una nuovo paradigma, che ridefinisca tutta la sua arte, ed immagina che sia il sonoro; esattamente quell’innovazione tecnologica che, invece, segnerà il suo tramonto artistico. E il regista del film, sembra anch’egli cercare un nuovo paradigma che ridefinisca il modo di far cinema e raccontare storie, in un mondo ormai dominato dalle piattaforme e dallo streaming che proprio il cinema stanno distruggendo; ancora uno sfasamento temporale che riemerge, anche quando il suo film cita altri film.
Quando Tobey Maguire reinventa il criminale Joker.
Quando Jovan Adepo, reinterpreta il coppoliano Cotton Club.
Quando Katherine Waterstone, in un rovesciamento di ruoli dal maschile al femminile, non riesce ad essere Pigmalione.
O quando l’immigrato messicano, l’unico a conservare il proprio attaccamento vero all’esistenza, perché non rinuncia alla propria viltà, in un cinema, vive qualcosa che ancora non è stato vissuto, guardando-sognando, frammenti/fotogrammi di film che sarebbero stati prodotti nei decenni seguenti, in un moderno, ed allucinato “ Nuovo Cinema Paradiso”.
Babylon, è un film sontuoso e sfrontato, che si pone sul terreno inesplorato delle domande sul futuro della nostra umana capacità di raccontare storie.
Ma le storie, per diventare davvero importanti, devono essere condivise; vissute insieme ad altri. Diventare parole tra le persone. Ed è questa, la funzione più vera, ed insostituibile, del cinema.
L’industria di Hollywood, nei decenni successivi, per poter continuare ad esistere, si piegò alle regole del “Codice Hays”. Dalle storie scomparvero gli omosessuali, i baci, i rapporti adulterini, il nudo; la legge divina non poteva essere discussa o ridicolizzata; il peccato era condannato; l’uso di droga o alcool, era nascosto; alla violenza era possibile solo alludere; bisognava perseguire la santità della famiglia e del matrimonio; non potevano esservi relazioni tra persone di “razza” diversa.
Babylon ci avvisa che, con la scusa di mettere sotto tutela gli eccessi ( presunti o veri ), la Libertà è in pericolo.