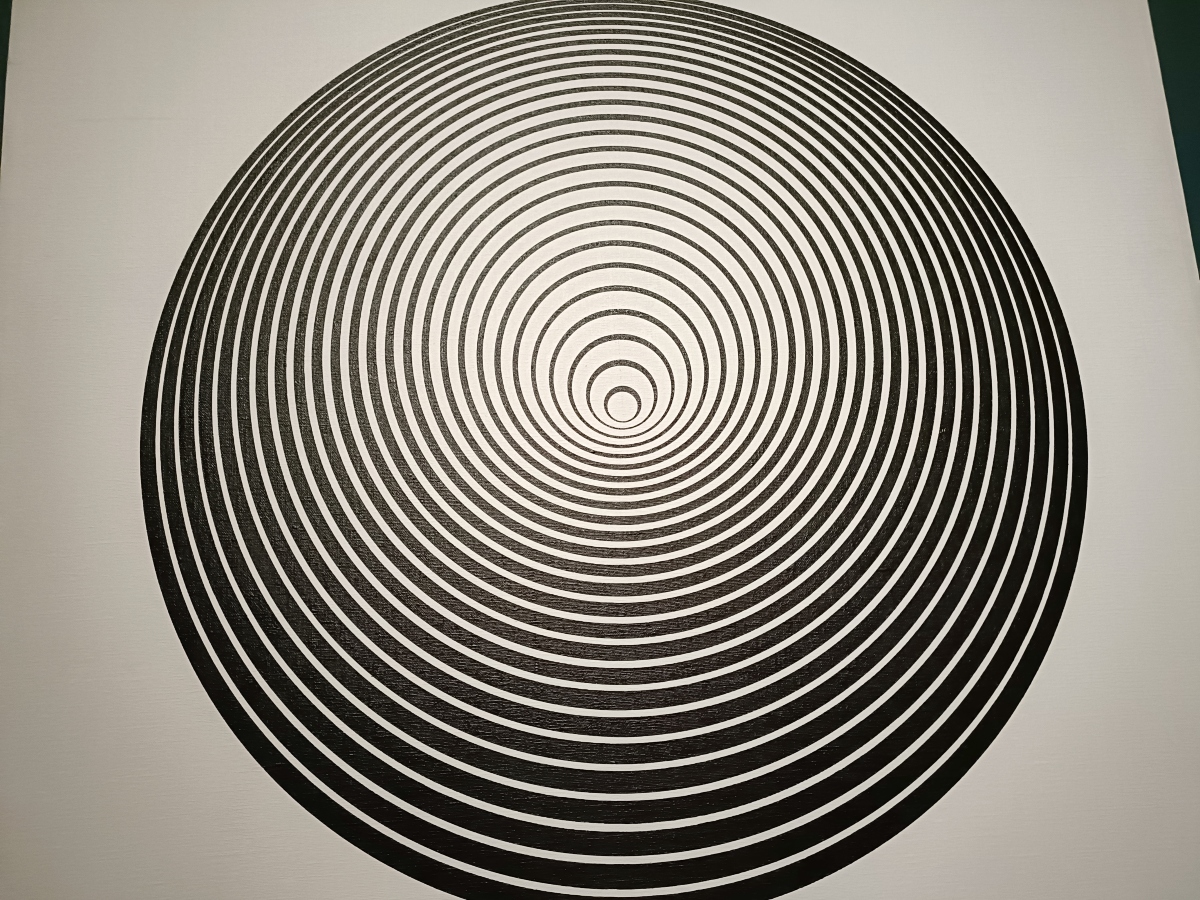Lungo Corso Roma a Gallipoli, accanto a certe tabaccherie, c’erano dei giochi per ragazzi, lasciati in strada e poggiati al muro delle case. Sembravano piccoli flipper senza luci.
Dentro un contenitore verticale, reso trasparente da una finestra di vetro, c’erano i premi da vincere, visibili, per invogliare al gioco.
Pupazzetti, bamboline, biglie di vetro, piccoli portachiavi. Spettavano a chi avesse saputo, dopo aver inserito cinquanta lire in una fessura e fatto girare una sorta di rubinetto metallico, far rotolare una biglia di ferro, liberata sul piano di gioco protetto da una lastra di vetro orizzontale, lungo il percorso difficilissimo e obbligato di una tavoletta basculante, che il giocatore poteva muovere dall’esterno, per far correre la pallina, scegliendo adeguate curvature e pendenze, più o meno veloci, entro spessori che segnavano le strade di un labirinto, ed evitando che la sfera metallica cadesse in una delle buche trappola scavate lungo il percorso, perdendosi, prima d’arrivare alla stazione finale che segnava la vittoria, ed il diritto a portare a casa il premio.
Il premio era contenuto entro una sfera di plastica trasparente, che era il vero motivo per cui Paolo, ogni tanto, si fermava a giocare e, spesso, riusciva a vincere.
Ad ora di tramonto, quando il sole scendeva oltre il faro di sant’Andrea, restando in piedi sugli scogli dietro il Canneto, entro il breve canale che collegava il porto al mare aperto di scirocco, la plastica trasparente, che galleggiava sulle onde placate dalla protezione della murata del molo, scintillava, ancora, e restava visibile, anche quando la notte cominciava a chiudere il cielo, oltre le mura della città vecchia. Perciò Paolo la cercava: per usarla come galleggiante col quale attrezzare la sua canna da pesca.
Aveva imparato come trattenere la sfera al filo di nylon; facendolo passare intorno a più d’uno dei piccoli pioli di plastica che, infilandosi dentro le parti ispessite del bordo, fissavano tra loro le due emisfere che, così, potevano aprirsi e chiudersi senza rompersi.
Ed era attento poi, a fermare, attraverso un particolare nodo, il filo alla plastica, cercando di far sì che la sfera non s’aprisse, per tutte le tensioni della pesca, e, non sempre, ci riusciva, ritrovandosi talvolta senza più galleggiante, portato via dalla cresta di un’onda.
Collocava la piccola sfera di plastica a meno d’un metro di distanza dagli ami, la cui posizione in acqua era tenuta quasi totalmente al bando delle correnti, da un piccolo piombino, posizionato martellandolo sul filo della lenza.
La breve distanza dalle esche, avrebbe fatto oscillare immediatamente la sfera immergendola leggermente, quando un pesce avesse toccato l’amo, e avrebbe dovuto essere veloce, Paolo, a ferrare, per allamare le aguglie che immaginava di prendere.
I piccoli pesci argentei, col breve rostro, sulla punta superiore della bocca che, di sera s’avvicinavano a riva a cercare rifugio nelle acque più basse, per crescere, nel tempo, talvolta fino ai due metri di lunghezza e veleggiare allora solo in acque lontane e scure, dai fondali bui, neri come la paura, scrutati dall’alto di una barca.
Acure ‘rrustute, se fosse riuscito a prenderne qualcuna, da offrire alla mamma, come una primizia rubata alla stagione.
Di pomeriggio, dopo aver fatto i compiti, traversava la Giudecca quasi correndo, e correndo, saliva fin sopra il molo del Canneto, indifferente all’odore di pesce seccato e marcito e nafta e reti incrostate di mare e salsedine e abbandonate sulla banchina.
Arrivava fino alla lanterna fissata sulla punta estrema della costruzione che proteggeva il seno del Canneto e il vecchio fondaco degli Ebrei, cacciati da Gallipoli dagli Spagnoli cristianissimi, ma rimasti per sempre in quel mare col loro nome di Sciudei regalato ai pesci gialli e blu e arancio, che, pescati, riempivano zuppe e fritture di un sapore dolce più del pomodoro, e da lì, scendeva sugli scogli aspri e puntuti, dal cui confine incerto con l’acqua, trasparivano le stelle di mare rosse e il cielo rovesciato dell’acqua blu e fonda che brillava di sole lontano, sempre più aranciato e scuro.
Paolo sapeva che, con la sua canna armata in quel modo, avrebbe potuto pescare sino al buio, guardando sulla plastica il riflesso delle luci elettriche delle case affacciate alla riviera Armando Diaz, appena sopra le mura entro cui era contenuto il centro storico del paese.
Quella sera, di coda alla scia d’una barca che rientrava, dopo aver appena calato i conzi per la notte, gli sembrò di scorgere una pinna, appena sotto il bordo dell’acqua, appuntita e veloce e il dorso grande, spezzato dalle onde e confuso, di un immenso pesce color acciaio e ombra.
Una aguglia imperiale.
Grande forse poco meno della barca che pareva seguire.
Paolo s’era sentito le gambe sparire e lo stomaco contrarsi, come prima di vedere un cane che, da lontano abbaiasse furioso correndo verso di lui. La sua canna da pesca era poggiata appena nell’incavo di uno scoglio. Un pesce del genere mai avrebbe immaginato di veder avvicinato a terra e voleva buttarsi in acqua, per prenderlo, con le mani, di certo più forti dei piccoli ami che un breve cenno della testa di quell’aguglia, avrebbe sfrantumato come pane secco.
La voce strozzata, che voleva gridare.
E, distintamente, vide la sagoma del pesce fermarsi, un istante prima di curvare verso il porto chiuso, e tornare indietro con uno scatto potente della coda. Paolo deglutiva senza saliva nella bocca e senza neppure parole da pensare, mentre il pesce riguadagnava il mare denso di lame gialle di luce, svanendo dalla sua vista.
Paolo si guardò intorno, ed avvertì il silenzio che lo circondava come una bolla di plastica trasparente, e non gli era rimasto nulla di quell’incontro, mentre la sfera s’apriva ed iniziava ad accorgersi del rumore del motore entrobordo della barca appena passata, che s’allontanava. Solo le onde leggere della sua scia, che andavano slargandosi e perdendosi sotto le ombre del molo, gli restavano negli occhi.
Non era arrabbiato, perché non aveva potuto pescare un pesce così.
Aveva capito che quell’aguglia imperiale era come il mattino dopo un sogno bellissimo, quando cominciava un giorno nuovo e tra le mani non restava nulla.
Tornò a casa, quella sera, senza aver nemmeno provato a pescare.
Sapeva che il mare gli aveva mostrato un suo respiro nascosto e che, per quella sera, non avrebbe permesso che altro gli fosse portato via.
Non lo avrebbe raccontato a nessuno, quel pesce.
Forse aveva visto solo il riflesso di un suo desiderio.