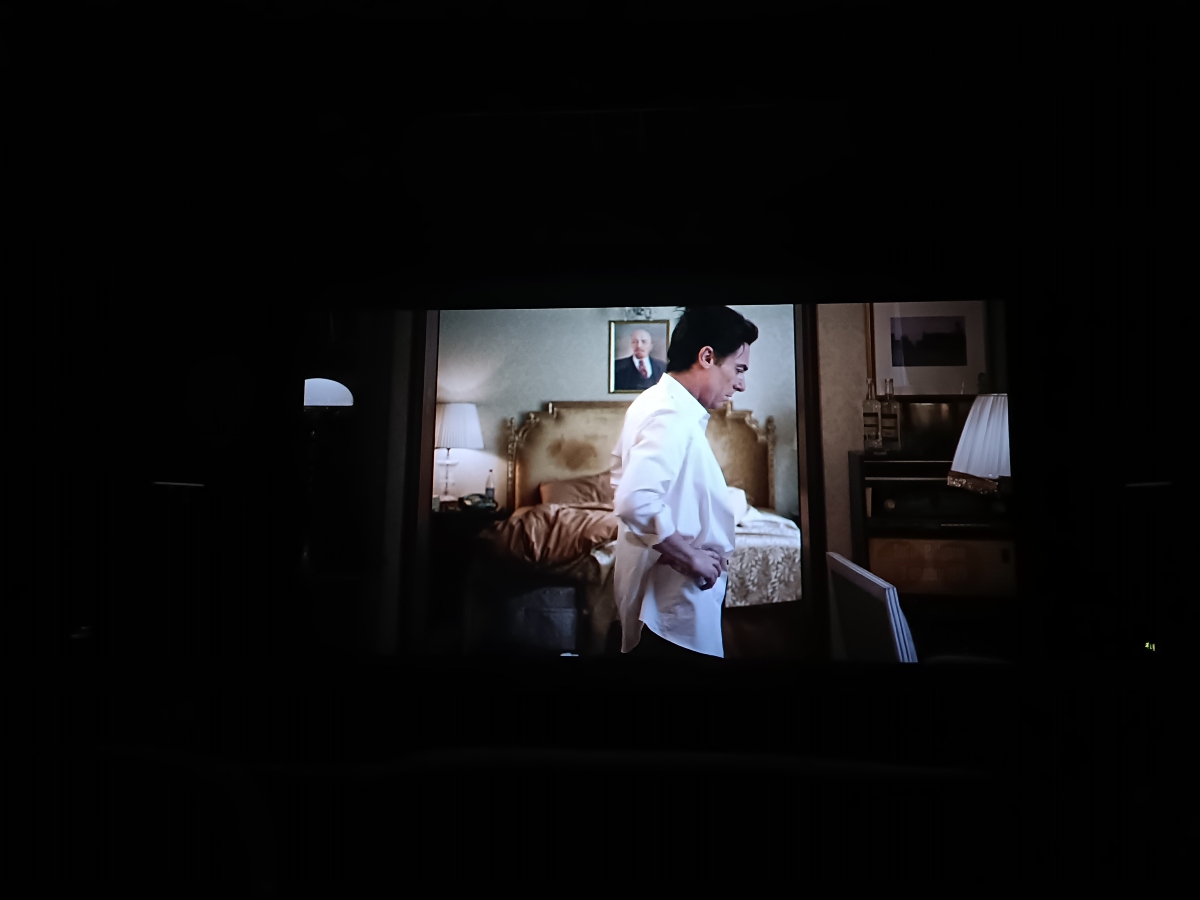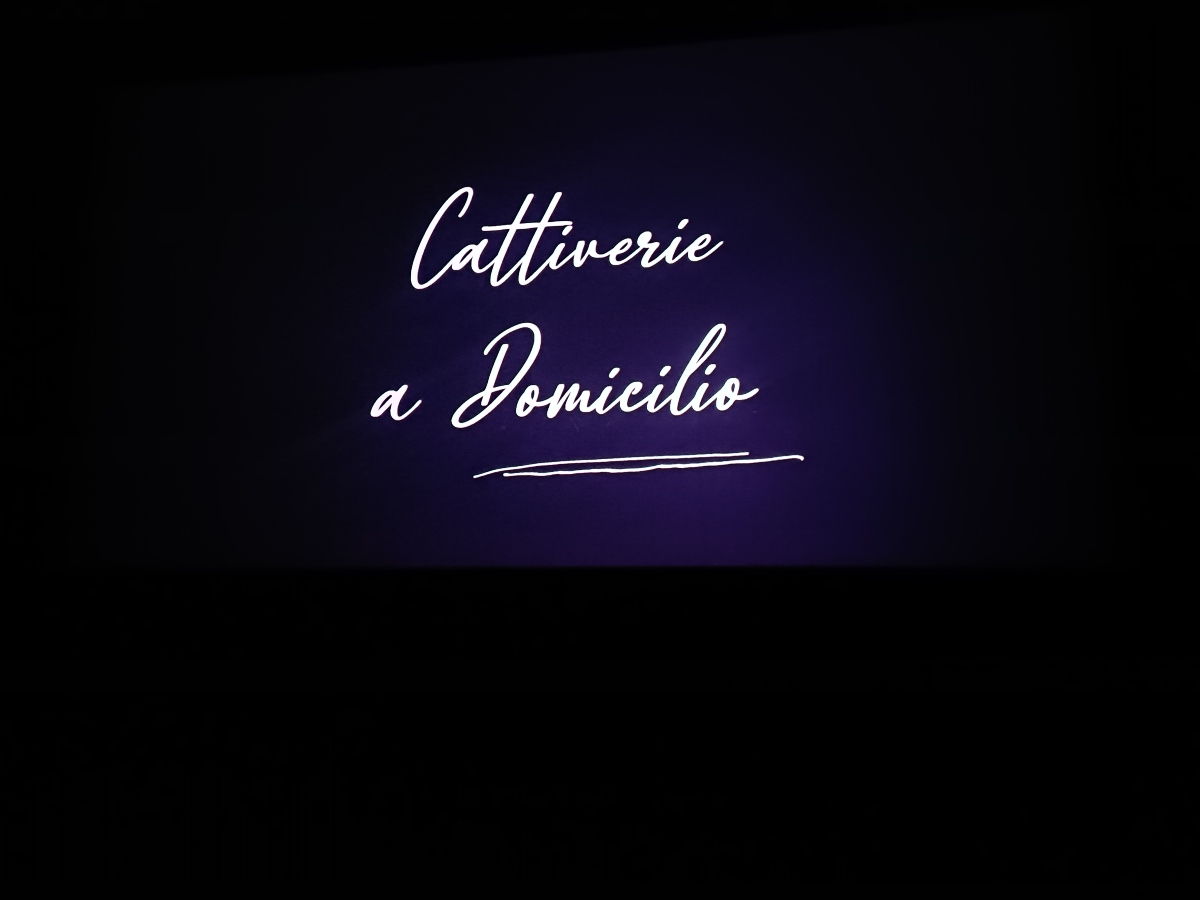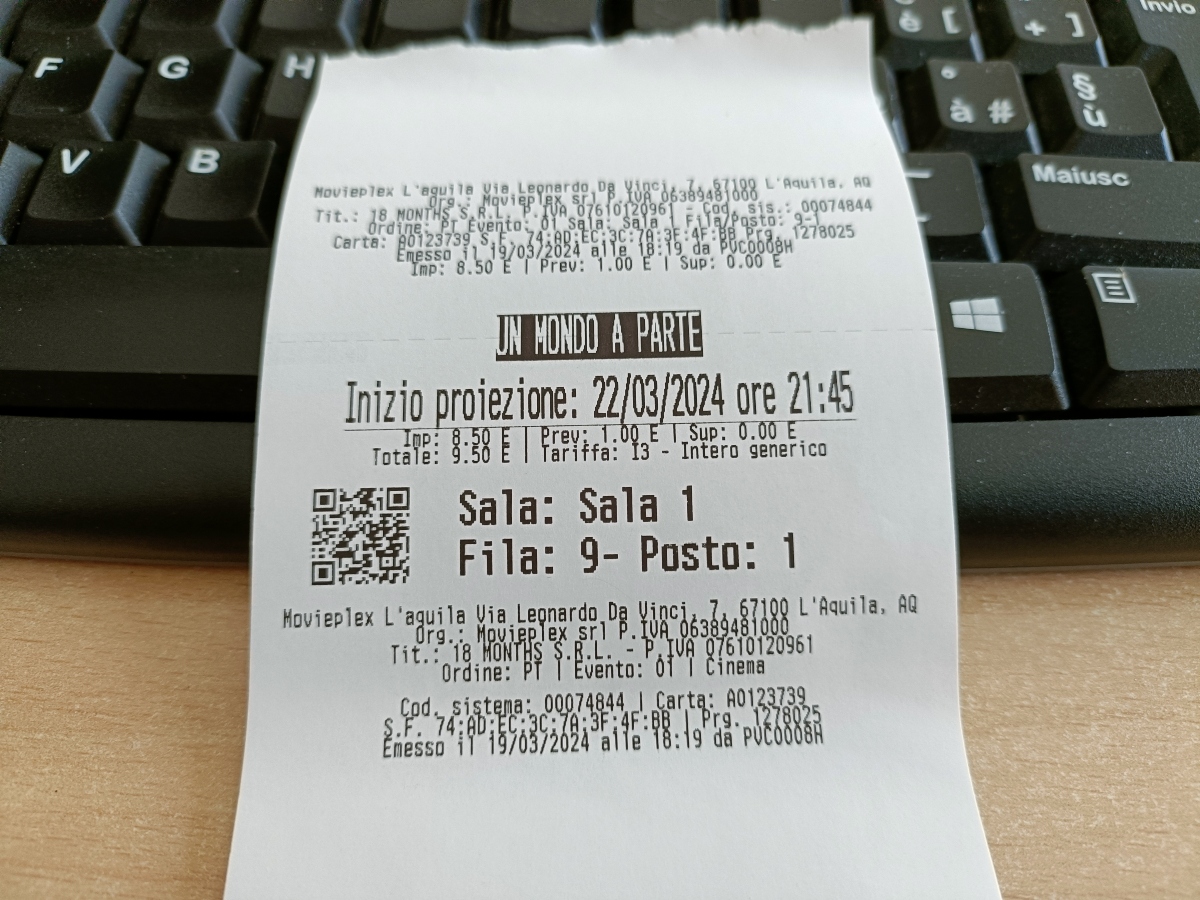Dante, al cinema, non è la stessa cosa che ascoltare una lezione sul Paradiso in Terza Liceo ( quinto anno ), alla quinta ora del sabato, quando, l’unica cosa che hai in mente, è uscire di scuola, salire sulla vespa, e andartene a sognare da qualche parte, foss’anche un piatto di spaghetti a casa da mamma, invece che tra le braccia della tua ragazza.
Però, qualcuno, ci ha provato, a ridurlo così, anche al cinema.
Chiunque sia la persona, regista compreso, che abbia scelto la colonna sonora del film, andrebbe denunciato per vilipendio alla bellezza.
Sarebbero bastati l’assoluto silenzio e le parole della storia, e i suoi rumori, e i suoi respiri e la folgorante bellezza del paesaggio italiano ( quando non era preda della speculazione edilizia, della rendita fondiaria e dell’abusivismo legalizzato ), e dei suoi centri spersi tra monti e colline, dove monaci e suore e contadini e pastori e artigiani radicavano le loro pietre tra gli alberi e le rocce, e le acque, e ne consegnavano le loro superfici a pittori, e scultori coraggiosi e visionari, per rendere ancor più denso il racconto; ancor più simile alle stanze di una poesia, o alle novelle dei Dieci Giorni, o alle cantiche alternate del racconto cinematografico, tra l’inferno terrestre del Dante esiliato, migrante, e il Purgatorio di Boccaccio, pellegrino penitente alla ricerca delle sue parole, e invece tutto è stato sommerso in una melassa televisiva di violini alla ricerca ossessiva del patetico e del sottolineato vibrante di commozione indotta, come gli applausi e le risate fuori campo di una pessima sit-com americana.
Pupi Avati ci mette di fronte, sin dalle prime scene, alla vita quotidiana delle donne e degli uomini del Medio Evo, che era, innanzitutto, consuetudine con la morte nella sua materialità più spaventosa, priva di ogni retorica e di ogni propaganda, e ci dipinge subito, la sua nuda e terribile, enfia, “Morte della Vergine” – che, nel suo originale, giace in un corridoio del Louvre, dove l’hanno spinta bigotti preti romani rifiutatori del Caravaggio -.
Un’opera di forza immensa, come la scena di un bambino costretto ad assistere all’agonia della propria madre, e a baciarla, appena cadavere.
Il gesto istintivo del bambino, del pulirsi la bocca, dopo quel bacio, non racconta il sacrilegio di un rifiuto d’amore, ma la consapevolezza che non sono gesti imposti dalla superstizione e dalla rigidità catechistica, a salvare, ma, innanzitutto, una limpida coscienza di sé, e delle proprie scelte, anche di separazione.
Non c’è bisogno di giocare con l’horror, cui ogni tanto a Pupi Avati piace indulgere, in passato, come anche in questo “Dante”, per sentire il terrore della morte; basta la sua naturalità.
A partire da quella pandemica, della Peste Nera di Firenze, che portò via, si stima, il 30% della sua popolazione dell’epoca ( riusciamo, ad immaginare, il 30% della popolazione italiana portato via dal Covid ? ).
Credo che in questo film, il regista abbia compiuto, col suo continuo confronto con la fine, uno sforzo narrativo demistificante assai forte, e crudo, capace di riportarci tutti ad una dimensione più umile, e vera, del vivere: un vivere che, proprio per questo cerca il suo riscatto nell’amore, e nella felicità, anche dentro la rassegnazione bestiale dell’attesa e della incomprensibilità della morte.
Pupi Avati ci ha raccontato un Dante capace di scegliere, in nome di convinzioni morali, a partire dal desiderio di Pace, anche di colpire le proprie più care amicizie e, per queste sue convinzioni confliggere con una chiesa solo intesa al proprio potere, e alla simonia della vendita delle indulgenze.
Uno straordinario Leopoldo Mastelloni papa Bonifacio VIII, mi ha evocato Jabba the Hutt; la stessa fisicità, la stessa depravazione.
Se a scuola fossero stati capaci di raccontarci, con la stessa intensità, e con la stessa asciutta leggerezza, le parole del Dolce Stil Novo, e quelle dedicate a Beatrice, non ci saremmo mai nascosti, per non farci interrogare, e non ci saremmo mai annoiati mortalmente, a disquisire delle varie interpretazioni critiche. Avremmo solo provato a farci prendere dall’incanto profondo, e ingenuo, e necessario e per questo vero, e nudo, e fragile, di quelle parole.
E se ci si pensasse, a parole scritte con un inchiostro incerto, intinto con stecchi rozzi, e tracciate, col lume di candela nel vento, su pergamene irregolari; al loro destino di scomparsa, quasi certa, travolte dal correre degli anni, se ne sentirebbe tutta intera la loro capacità di oltrepassare i secoli, mentre le nostre parole di bit luminosi, non hanno quasi mai la stessa scabra ruvidezza che ci toglie sangue dalle dita, a sfiorarle.
Solo copiare, quei testi, li avrebbe salvati. Fisicamente copiare, riga, dopo riga. E preservare dagli sguardi indagatori e giudicanti.
Sergio Castellitto è uno straordinario Boccaccio, che, di fronte alla ricerca di Dante, non rammenta neppure, le proprie novelle dei Dieci Giorni – ricevendo in tutto il film, un solo accenno grato, alla sua immensa opera – come se non fossero quell’assoluto mare di storie, in cui tutte le storie italiane seguenti hanno pescato, e ci regala una interpretazione di intensità trattenuta e potentissima insieme, come un diapason che cerchi costantemente la nota più alta, e la tenga ferma dentro quel cielo di stelle di cui il Sommo Poeta conosceva, di ciascuna, il vero nome, senza mai farla cadere o scivolare nella maniera, fino ad arrivare nella scena finale del film a rompere ogni argine e a farmi piangere.
Perchè certe parole, dette con quella forza, fanno piangere.
E’ persino capace, con un solo sguardo muto, Castellitto di spiegare ad Enrico Lo Verso che non sarà una presunta acqua miracolosa, a pagamento, a guarire le sue mani piagate. Ci vorrebbe ben altro. Quella scienza che si oppone al Covid, non le fanfaluche credulone e fanatiche dei nostrani Vandeani.
Da solo, Sergio Castellitto, vale il biglietto del film, che per fortuna nostra, non ci è addebitato anche per tutte le altre interpretazioni; tutte misurate, e al sevizio pieno della storia, che non imbellisce ed imbelletta i volti, a partire da quello di Alessandro Sperduti – un credibilissimo Dante giovane – ma li scava e li rivela rudemente nelle loro pieghe di tempo amaro, con questo suo procedere di specchio palindromo: dall’infanzia di Dante alla sua fine, mentre, al contrario, Boccaccio viaggia dalla fine del poeta alla sua eternità, per riscoprirne le storie e le tappe, e le tracce, di una personale via crucis inseguita dall’editto papale di condanna a morte, per rogo e conclusa, “alla fine di tutti i disii…”, con gli ultimi Canti della sua Commedia, Divina, e con la visione sovrumana di Dio, appunto.
O forse, con la visione infinitamente umana, della ricerca, della poesia e delle storie e delle parole, che, sole, con la loro bellezza, possono riscattare il nostro umano destino di certa finitezza.
Io sono solo uno spettatore.
Non ho strumenti critici. E, quindi, le mie parole non hanno poi questo gran valore.
Se togliessero i violini, magari, con questo film, Pupi Avati ci vincerebbe l’Oscar, se per gli americani non contasse invece, prima di tutto, che nel film si vedono troppi seni femminili nudi, e troppi culi maschili, altrettanto nudi; ci fossero stati più sbudellamenti, invece, l’Academy Awards, sarebbe stato tranquillamente suo.